Oggi accendiamo i riflettori su due gemme nascoste del nostro idioma: ‘lucore’ e ‘ferale’. Parole che brillano di luce propria, pronte a illuminare i meandri del nostro linguaggio e a suscitare in noi emozioni profonde.
Lucore, /lu·có·re/: s. m. [lat. *lucor –oris, der. di lucēre «splendere», sull’analogia dei deverbali in –or da verbi in –ēre (cfr. fulgēre – fulgor, splendēre – splendor, ecc.)], ant. o letter. – Lucentezza, luce vivida e intensa ma anche luce diffusa, luce attenuata.
Per capire questa parola, dal significato che appare ambivalente, dobbiamo riferirci al suo suffisso nominale deverbale ‘-ore’. Come ci ricorda la Treccani, questo suffisso ha il potere di trasformare verbi in sostantivi, catturando l’essenza di un’azione, di un’esperienza vissuta. Il suffisso -ore, con la sua origine latina, è un testimone della nostra storia. Dai tempi antichi, questo morfema è stato utilizzato per creare nomi che esprimessero l’azione in modo concreto e tangibile.
I nomi formati con il suffisso -ore sono come istantanee di esperienze vissute sulla nostra pelle. Che si tratti di sensazioni fisiche, come il calore del tepore o il freddo del raffreddore, o di emozioni profonde come l’amore o il dolore, questi termini ci immergono in un mondo di percezioni e sensazioni. L’errore, l’orrore, il fervore, il languore: ciascuno di essi evoca un’esperienza unica, un’emozione intensa, un’immagine viva.
Il lucore è un’esperienza intima e soggettiva, un momento in cui la nostra percezione della luce si intensifica. Che si tratti del bagliore di un fulmine, del chiarore dell’alba o del tremolio di una candela, il lucore ci tocca in profondità, suscitando in noi emozioni e sensazioni che vanno oltre la semplice registrazione visiva. È in questi istanti che la luce diventa qualcosa di più di una mera radiazione elettromagnetica, assumendo un valore simbolico e affettivo. Sia che ci abbagli con la sua forza, sia che si stagli appena percepibile sul fondo del buio, il lucore ci offre un’esperienza sensoriale intensa e memorabile. È nell’abisso tra l’oscurità più profonda e la luminosità più accecante che il lucore trova la sua dimora, invitandoci a riflettere sulla natura ambivalente della luce.
Ferale, /fe·rà·le/: agg. [dal lat. feralis, di etimo incerto]: funesto, luttuoso, funereo, infausto.
Il termine ‘ferale’ appartiene a un lessico raffinato, evocando immagini di morte e sventura. Può qualificare una notizia luttuosa, un atto violento, una calamità o un fallimento rovinoso, conferendo a questi eventi una connotazione particolarmente sinistra e infausta.
La scelta di usare ‘ferale’ è una decisione stilistica precisa. La sua connotazione aulica può sembrare in contrasto con la necessità di esprimere un sentimento forte come il dolore, ma in realtà è proprio questo contrasto che rende la parola così efficace. ‘Ferale’ ci invita a riflettere sulla natura del tragico, a osservare la realtà da una prospettiva più distaccata, senza per questo rinunciare alla profondità di significato.
Spesso a ‘ferale’ viene preferito ‘funesto’ ma qual è la sottile differenza tra i due? A prima vista sembrano sinonimi, ma l’orecchio percepisce sfumature diverse. ‘Funesto’ avvolge in un silenzio attonito, quasi stordito dal peso della notizia. ‘Ferale’, invece, suscita un brivido, un’angoscia più viva, più palpitante. Il suono stesso della parola sembra evocare un’ombra oscura e minacciosa.
Una specie ferale è una specie animale che vive e si riproduce liberamente in natura pur appartenendo ad una specie domestica. La feralità può essere considerata il processo opposto alla domesticazione.
Tra l’altro, Ferale è una montagna dell’Isola d’Elba, in effetti situata in una zona piuttosto selvaggia.
Cosa mi dite di queste due parole? Le usate, vi piacciono?


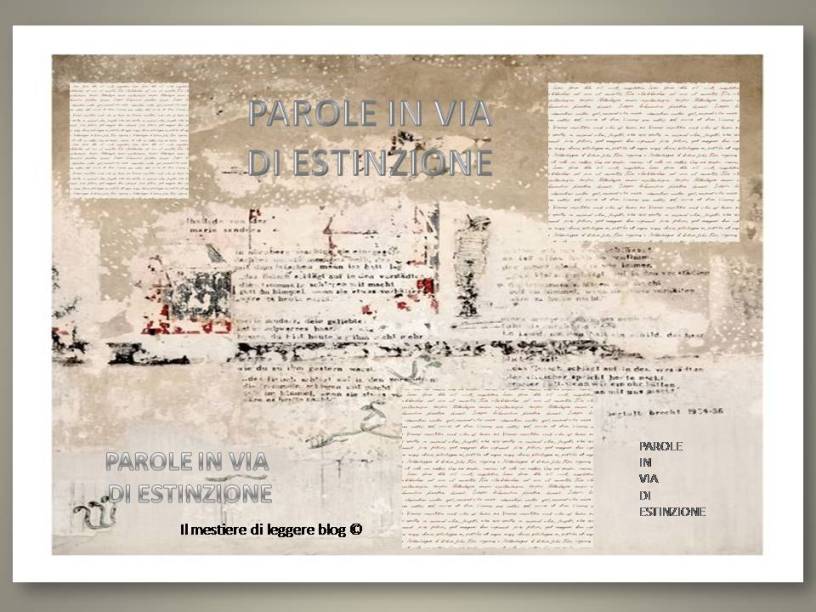

Entrambe quasi estinte.
"Mi piace"Piace a 1 persona
è un vero peccato, le trovo davvero piene di fascino
"Mi piace"Piace a 2 people
Potremmo definirle parole vintage
"Mi piace"Piace a 1 persona
Lucore sì, ferale si usa ancora nelle condoglianze e in caso di vittoria elettorale di trump
"Mi piace"Piace a 1 persona
allora tornerà di sicuro in vita….
"Mi piace"Piace a 2 people
ah è già tornato
"Mi piace"Piace a 2 people
😔
"Mi piace"Piace a 1 persona
bellissimo post
"Mi piace"Piace a 3 people
grazie, spero di contribuire al ritorno di questi due termini desueti. buona domenica
"Mi piace"Piace a 1 persona
Due termini densi di significato che aggiungono intensità alle nostre parole.
Grazie
"Mi piace"Piace a 1 persona
Grazie a te, per avere così bene colto quanto queste due parole possano dare lustro al nostro lessico.
"Mi piace""Mi piace"
Confesso che ferale mi è più familiare che lucore. Proprio vero: presto certe parole saranno estinte…
"Mi piace"Piace a 1 persona
Alcune hanno il destino segnato 😔
"Mi piace"Piace a 1 persona
Due parole bellissime! Che non credo estinte, solo molto ricercate. Signore parole che non se la fanno con il popolino. Credo siano sempre state così: un po’ snob, non frequentano il popolo parolaio.
Bene ricordale, gustarle, e poi, perché no, introiettarle nel nostro linguaggio, e usarle. Per consigliare loro di scendere un po’ dal piedistallo se desiderano sopravvivere.
"Mi piace"Piace a 2 people
sì, dovrebbero abbandonare quell’aura un po’ altezzosa e farsi più umili, più accessibili
"Mi piace"Piace a 1 persona
Due parole che appartengono decisamente all’italiano letterario, con lucore che nella mia testa fa subito poesia.
"Mi piace"Piace a 2 people
È vero, lucore è un termine molto poetico
"Mi piace"Piace a 1 persona
In un testo adatto, le userei entrambe. Lucore lo userei in un testo poetico, come altri hanno già notato; ferale invece in un contesto ironico, perché mi pare una parola troppo sovraccarica per essere usata per descrivere qualcosa di luttuoso. “La ferale notizia”, per me, ha senso solo in chiave ironica.
"Mi piace"Piace a 1 persona
ottima osservazione questa sulla chiave ironica nell’uso di ferale. un po’ come quando ci si riferisce a qualcuno definendolo “il nostro eroe”, in senso ironico
"Mi piace""Mi piace"
Mi veniva giusto da pensare che “ferale” poteva riferirsi al campo del “selvaggio” (anche perché credo che “feral” in inglese significhi appunto questo). Ma il vero valore di questo post (come di tutti quelli di questa rubrica) è stato avermi fatto riflettere su quanto belli siano i sostantivi in -ore: esprimono in maniera così precisa quello che vogliono significare. Potrei fare una lunga perifrasi per spiegare quel sentimento, ma non riuscirei a catturare l’essenza di quello che è il languore (e, soprattutto, “il languore del circo prima o dopo lo spettacolo”); infinite storie di martirio non riuscirebbero a definire cos’è il fervore della fede. E come altrimenti definire l’architettura di luce di una cattedrale gotica, che parlando del suo lucore?
"Mi piace"Piace a 2 people
Infatti!! È verissimo, i sostantivi deverbali si portano dietro tutto il bagaglio esperienziale del verbo, difficile competere…
"Mi piace"Piace a 1 persona
Hai ancora una volta scelto delle bellissime parole. Lucore è una parola straordinaria, esprime quello spazio che c’è tra l’abisso e la luce, rendendo tutto più splendente. Misteriosa parola che spero proprio non cada in disuso, io continuo ad usarla. Ferale l’uso spesso, dà una sensazione ancora più vivida dell’accaduto, sia in senso ironico che drammatico. Grazie del bellissimo post.
"Mi piace"Piace a 1 persona
Grazie per contribuire a mantenere viva la capacità espressiva della nostra lingua. 🥰
"Mi piace""Mi piace"
“Ferale” lo uso spesso, purtroppo, mentre “lucore” anche se, da adesso, mi riprometto di farlo perché è davvero bellissimo e vibrante.
Che dire?
In questo nostro mondo dove l’informazione è sempre più
dominata da notizie ferali, il tuo blog ci accarezza con il suo lucore e ci fa continuare a sperare che un altro mondo sia ancora costruibile e possibile: per ora ci accontentiamo di leggerlo, in attesa di poterlo vivere.
Grazie! 😊
"Mi piace"Piace a 1 persona
Grazie 🫶 che bel pensiero
"Mi piace""Mi piace"