Ho una mania a cui non riesco a tenere testa: leggere gli incipit di tutti i volumi che mi capitano tra le mani. A volte vado in libreria, cerco tra gli scaffali quello che mi serve e, intanto che ci sono, prendo tre o quattro libri, mi siedo da qualche parte e leggo la prima pagina. Può succedere che decida di leggere tutto il resto, oppure che rimanga delusa. Può anche succedere che il resto del romanzo non sia all’altezza dell’incipit e allora la delusione arriva dopo, più cocente, perché intanto, magari, l’ho anche comprato … Comunque, assaporare un romanzo e prefigurarsi come potrà andare avanti è un gioco che mi intriga tantissimo.
In questa pagina copio tutti gli incipit dei romanzi che più mi hanno colpito. Dove è presente il link, si trova il post dedicato al romanzo. Nel menù a tendina della Home Page, a rotazione, ne propongo alcuni per poterli più facilmente visualizzare e leggere. La rotazione è a cadenza mensile.
Ed eccomi ancora davanti a questo quadretto nella sua modesta cornice. Domani, domattina, devo partire per il villaggio, e guardo il quadro a lungo e attentamente, come se dovesse augurarmi un felice cammino. Quel quadro io non l’ho ancora mandato ad alcuna mostra. Anzi, quando, dal villaggio, vengono a trovarmi dei parenti, cerco di farlo passare inosservato. Non che vi si trovi qualche ragione di vergogna, ma è ben lontano dall’essere un’opera d’arte. È semplice, com’è semplice la terra che vi è rappresentata. Sullo sfondo c’è la linea d’un cielo appassito d’autunno; il vento, sopra una lontana cavalcata di montagne, mette in fuga rapide e piccole nubi pezzate. In primo piano, col suo color bruno rossastro, la steppa degli assenzi. E la strada, scura, che non ha avuto il tempo di seccarsi dopo le piogge recenti. Ai lati, aridi arbusti si serrano spezzati. Lungo il solco zuppo della strada vengono ad allinearsi le orme di due viandanti; più si allontanano più sono deboli; i viaggiatori, poi, si direbbe che con un passo debbano uscire dal fondo. Uno dei due … ma io anticipo.
Tschingis Aitmatov, Melodia della terra
Mio padre scriveva nelle sue lettere: “Figlia mia, non preoccuparti per il mantenimento dei tuoi studi. Venderei anche la mia giacca per pagarteli!”, e io mi chiedevo quanto valesse la sua giacca. Quando si era tranquillizzato riguardo le spese, si metteva a scegliere il corso di studi che avrei dovuto frequentare e, senza la mia partecipazione, stilava il presunto elenco. Ma immancabilmente questo iniziava con la medicina e finiva con la medicina: oculistica, odontoiatria, psichiatria, veterinaria, persino la paramedicina che né io né lui sapevamo cosa fosse. Anche se, come al solito, il mio parere non aveva molta importanza. Poi continuava aggiornandomi sul valore del rial rispetto al dollaro, alla sterlina, al franco, allo yen, alle lire, eccetera eccetera, dicendomi che era in caduta libera. Infine, concludeva sottolineando ancora la faccenda della vendita della giacca.
Tahereh Alavi, Nelle stanze della soffitta
Venti giorni di giallo e torrido deserto. Le chiappe come un budino sbatacchiate sul dorso di un serafico cammello e in testa soltanto tre parole: acqua, bidè e parrucchiera. Madame De Cecco stentava a ricordare per quale motivo aveva accettato di partecipare a quel dannatissimo viaggio. Le era sembrato, come sempre, di annuire ad una civettuola proposta di facili emozioni, nulla di più. Aveva pensato, come sempre, di potersi avventurare per finta, magari a braccetto di qualche giovane fusto, in situazioni risolte da altri, alle quali avrebbe potuto contribuire con la solita, adorabile fragilità e senza dover patire le vere asprezze di una spedizione. Invece a ogni sobbalzo dell’animale sentiva un rigurgito che le sconquassava impietosamente lo stomaco. Vuoto, senza mezzi termini, vuoto.
Domenico Aliperto, Non conquistammo che sabbia

Vadinho, il primo marito di dona Flor, morì a Carnevale, una domenica mattina, mentre ballava un samba vestito da baiana in Largo 2 Luglio, non lontano da casa sua. Non apparteneva al gruppo, ci si era semplicemente aggregato, con altri quattro amici tutti vestiti da baiana, e tutti provenienti da un bar della zona del Cabeça, dove il whisky correva a fiumi, alle spalle di un certo Moysés Alves, piantatore di caffè, ricco e spendaccione.
Jorge Amado, Dona Flor e i suoi due mariti
Dal momento che lo chiede con tanta buona grazia, giovanotto, io le dico: con le disgrazie basta incominciare. E quando sono incominciate, non c’è niente che le faccia fermare, si estendono, si sviluppano, come una merce a buon mercato e di largo consumo. L’allegria, invece, compare mio, è una pianta capricciosa, difficile da coltivare, che fa poca ombra, che dura poco e che richiede cure costanti e terreno concimato, né secco né umido, né esposto ai venti, insomma una coltivazione che viene a costar cara, adatta a quelli che son ricchi, pieni di soldi.
Jorge Amado, Teresa Batista stanca di guerra
Come poteva sapere Teta, che il viaggio che da lì a poco l’avrebbe portata a ‘Arrabeh, suo villaggio natale in Palestina, avrebbe avuto un peso così decisivo nella sua vita? L’adulterio che ebbe luogo durante quell’assenza di due mesi avrebbe cambiato, e per sempre, l’intero spettro dei sentimenti e delle dinamiche familiari, e reso quasi muta per il resto dei suoi brevi giorni la già silenziosa Teta. Era la prima volta che andava a trovare la sua famiglia da quando, nel 1896, aveva sposato Jiddo. All’epoca aveva solo quattordici anni, mentre lui ne aveva venti di più: Jiddo era nato nel 1862, Teta nel 1882. A separare ‘Arrabeh da Damasco e Teta dalla sua adorata mamma e dai suoi cinque fratelli minori c’erano centocinquanta chilometri e all’incirca trent’anni.
Suad Amiry, Damasco
Un sole rosso stava in bilico sull’orizzonte quando arrivai al Premiato Diner del Deserto. Le ombre dell’alba ne avvolgevano gli angoli. Nel cielo che si andava rischiarando era ancora visibile una pallida luna piena. Posteggiai l’autoarticolato lungo il perimetro esterno del parcheggio in ghiaia. Sulla porta era appeso il cartello CHIUSO. A sinistra, come una specie di monumento a Superman, una cabina telefonica in vetro e metallo nero. Dentro c’era un vero telefono con il disco che ruotava scattando su dieci numeri bianchi. A differenza dei telefoni nei film, questo funzionava – se avevi abbastanza monetine. La curiosità non era mai stata un problema per me. La trattavo come un cane che dorme in una discarica. In linea di massima, non scavalcavo la recinzione. Alcune cicatrici frastagliate sul sedere mi ricordavano le poche volte in cui avevo violato quella regola. Solo perché il cane non si vede, non vuol dire che non ci sia. Certo, di tanto in tanto do una sbirciatina oltre la rete. Ciò che vedo e penso lo tengo per me. Quel lunedì mattina di fine maggio mi trovavo pericolosamente vicino alla recinzione. Walt Butterfield, il proprietario del diner, era una specie di unitariano: la sua era una parrocchia con un unico fedele, di cui lui stesso era il cane da guardia. La sua discarica era il Premiato Diner del Deserto, e prima di strapparti la gola non abbaiava né ringhiava. Mi piaceva lui e mi piaceva il suo rottamaio. Quel luogo era una specie di strano tempio. Nel corso degli anni, il diner era diventato per me un’area di sosta, oltre una fonte di attrazione e di inutili congetture. Era sempre la prima fermata, anche quando non avevo consegne per Walt. A volte era anche l’ultima.
James Anderson, Il diner nel deserto


Solo un silenzio fugace segnava il passaggio dall’estate all’inverno. Dopo aver vissuto nel cuore del deserto dello Utah gran parte dei miei quasi quarant’anni, di cui venti alla guida di un camion, ero giunto alla conclusione che di fatto esistevano solo due stagioni: una calda e ventosa, l’altra fredda e ventosa. Tutto il resto era solo una variazione sul tema. Una sera, sul tardi, mentre me ne stavo in dormiveglia nel mio letto, capii che quel silenzio significava che la stagione era cambiata. Mi piace pensare di saperne qualcosa, del silenzio. Il vero silenzio è più che assenza di suoni: è qualcosa che si percepisce. Qualche attimo prima un vento costante aveva disperso i rumori residui della sera – il motore di una macchina, le parole dei vicini dietro le porte chiuse, un cane che abbaiava da qualche parte – il solito frastuono ovattato delle vite intorno a me. Poi più nulla, niente di niente, come se il deserto e tutti quelli che lo abitavano fossero svaniti lasciandosi dietro solo un’incurante luce senza stelle. Alle quattro del mattino, quando iniziava la mia giornata lavorativa, l’inverno mi aspettava sulla soglia. Impiegai più tempo del solito ad arrivare al centro di smistamento e caricare il tir. Riuscii finalmente a mettermi in marcia molto dopo le cinque, guidando con prudenza tra la neve leggera e il ghiaccio nel buio che precedeva l’alba. Il riscaldamento era al massimo, ma il freddo aspro e secco rubava il calore dal corpo e screpolava la pelle, rendendola simile al fondale argilloso di un lago. L’ultima sosta della mia routine mattutina era il rifornimento di diesel. Dovevo essere arrivato con qualche minuto di anticipo o di ritardo e mi ero perso l’ora di punta, ammesso che ci fosse stata. Tutte le pompe del distributore erano vuote.
James Anderson, Lullaby Road
Eccola lì, la poverina. Va a infrangersi su di lui. Come s’infrange un’onda sugli scogli. Un po’ di schiuma e ciao. Non vede che non si prende nemmeno la briga di aprirle la portiera? Sottomessa, più che sottomessa. E quelle scarpe con i tacchi e quelle labbra rosse a quarantacinque anni? Con la tua classe, figlia mia, con la tua posizione e i tuoi studi, cos’è che ti fa comportare come un’adolescente? Se l’aita fosse vivo … Al momento di salire in macchina, Nerea rivolse lo sguardo alla finestra; immaginò che, dietro la tenda, sua madre la stesse come al solito osservando. E sì, anche se lei dalla strada non poteva vederla, Bittori la stava guardando con tristezza e con le sopracciglia aggrottate, e parlava da sola e sussurrò eccola lì, la poverina, solo un ornamento di quel vanitoso a cui non è mai passato per la testa di far felice qualcuno. Non si rende conto che una donna dev’essere proprio disperata per cercare di sedurre il marito dopo dodici anni di matrimonio? In fondo è meglio che non abbiano avuto figli.
Fernando Aramburu, Patria

La storia di Zenia dovrebbe cominciare quando è cominciata Zenia. Dev’essere stato in un luogo lontano nel tempo e nello spazio, pensa Tony; un luogo confuso e caotico. Una stampa europea, colorata a mano, in ocra, con una luce polverosa e un bel po’ di boscaglia dal fogliame denso e dalle antiche e contorte radici, dietro la quale, nel sottobosco, sta succedendo qualcosa di ordinario e di orripilante, qualcosa che non si vede ma si indovina soltanto da una scarpa che spunta o da una mano senza vita.
Margaret Atwood, La donna che rubava i mariti
Sulla ghiaia crescono le peonie. Spuntano in mezzo ai sassolini grigi, i boccioli esplorano l’aria come antenne di lumaca, poi si gonfiano e si aprono, grossi fiori rosso scuro lucidi e brillanti come seta. Poi scoppiano e cadono per terra.
Margaret Atwood, L’altra Grace
Era il primo giorno di lezione nella scuola di Obaba. La nuova maestra passava di banco in banco con il registro degli alunni in mano. – E tu? Come ti chiami? – chiese quando mi si avvicinò. – Josè, – risposi -, ma tutti mi chiamano Joseba. – Molto bene-. La maestra si rivolse al mio compagno di banco, l’ultimo a cui doveva ancora chiedere: – E tu? Qual’è il tuo nome? – Il ragazzo rispose imitando il mio modo di parlare: – Io sono David, ma tutti mi chiamano il figlio del fisarmonicista -. I nostri compagni, bambini e bambine di otto o nove anni di età, accolsero la risposta ridacchiando.
Bernardo Atxaga, Il libro di mio fratello
È cosa nota e universalmente riconosciuta che uno scapolo in possesso di un solido patrimonio debba essere in cerca di moglie. E benché poco sia dato sapere delle vere inclinazioni e dei proponimenti di chi per la prima volta venga a trovarsi in un ambiente sconosciuto, accade tuttavia che tale convinzione sia così saldamente radicata nelle menti dei suoi nuovi vicini da indurli a considerarlo fin da quel momento legittimo appannaggio dell’una o dell’altra delle loro figlie.
Jane Austen, Orgoglio e pregiudizio
Sei giorni fa un uomo si è fatto saltare in aria sul ciglio di una strada del Wisconsin del nord. Non ci sono testimoni, ma pare che fosse seduto sull’erba accanto alla sua macchina intento a costruire una bomba, quando questa gli è esplosa fra le mani per sbaglio. Secondo i referti dei medici legali che sono stati appena diramati, l’uomo è morto sul colpo. Il suo corpo si è frantumato in decine di pezzettini, e frammenti del cadavere sono stati rinvenuti fino a quindici metri dal luogo dell’esplosione.
Paul Auster, Leviatano

Evelina cercava la pace e il silenzio. Per quello si svegliava prima di tutti. Prima del padre che andava presto nei campi, prima della madre e della nonna che facevano le faccende, prima dei fratelli più grandi che andavano a scuola e di quelli più piccoli che invece dormivano fino a tardi. Certe mattine si svegliava persino prima del gallo. Le piaceva stare un po’ alla finestra della camera e guardare Candelara. Quella mattina si vedevano solo i rami nudi del noce che spuntavano appena in mezzo al bianco.
Poi le sembrò che la neve si muovesse.
Simona Baldelli, Evelina e le fate
Amalia osserva le case aggrappate alla collina in faccia all’acqua. Le strade erano state strappate dalla terra, si diceva, ché quell’altura non era stata creata dagli uomini. Sulla sinistra spunta il candore di São Vicente de Fora e, poco più avanti, la cupola del Panteão Nacional. Da lì, l’occhio scivola inevitabilmente nel tago, poi, stordito dai bagliori, cerca rifugio verso la riva di Cacilhas. Guarda la distesa d’acqua, Amalia, non capacitandosi ancora, a quasi due anni di distanza, che sia dolce e non salata, perché quel fiume immenso le sembra il mare. Non passa mattina senza l’affaccio al belvedere di Portas do Sol, che ci sia pioggia o bel tempo, oppure nebbia, a salire dal Tago. Scruta l’orizzonte sull’altro lato della riva, e oltre ancora, come se da là dovesse giungere la risposta a una preghiera dimenticata. Non ricorda più la domanda né cosa aspetta, ma la nascita del giorno, mentre se ne sta aggrappata alla balaustra della piazza, le dà un momento di pace.
Simona Baldelli, Vicolo dell’Immaginario
“Non piangere.” Nel silenzio che divide l’uno dall’altro i miei singhiozzi, questa voce figura una ragazzetta che abbia corso in salita e voglia scaricarsi subito di un’imbasciata pressante. Non alzo la testa. “Non piangere”: la rapidità dello sdrucciolo rimbalza ora come un chicco di grandine, messaggio, nell’ardore estivo, di alti freddi cieli. Non alzo la testa, nessuno mi è vicino.
Poche cose esistono per me in quest’alba faticosa e bianca di un giorno d’agosto in cui siedo in terra, sulla ghiaia di un vialetto di Boboli, come nei sogni, in camicia da notte. Dallo stomaco alla testa mi strizzo in lagrime, non posso farne a meno, in coscienza, e ho il capo sulle ginocchia.
Anna Banti, Artemisia
Con Giulia ritornavo normale. Quando le raccontai del Fatto, lei quasi non cambiò espressione. Fu come se mi avessero tolto una montagna dalle spalle. Davanti alla panchina dove mi sono seduto c’è un prato curato all’inglese, più in là si alzano alberi secolari e oltre le fronde un aereo disegna una scia. Il giardino della clinica non mi è mai sembrato così imponente come in questo momento. Sono qui da mesi e pensavo che sarei scappato non appena avessi avuto via libera, invece ora che sono tornato non so più andarmene.
Diego Barbera, Ti scriverò prima del confine
“Marx cambia completamente la mia visione del mondo” mi ha dichiarato questa mattina il giovane Pallières che di solito non mi rivolge nemmeno la parola.Anoine Pallières, prospero erede di un’antica dinastia industriale, è il figlio di uno dei miei otto datori di lavoro. Ultimo ruttino dell’alta borghesia degli affari – la quale si riproduce unicamente per singulti decorosi e senza vizi -, era tuttavia raggiante per la sua scoperta e me la narrava di riflesso, senza sognarsi neppure che io potessi capirci qualcosa. Che cosa possono mai comprendere le masse lavoratrici dell’opera di Marx? La lettura è ardua, la lingua forbita, la prosa raffinata, la tesi complessa.
Muriel Barbery, L’eleganza del riccio
Sabbia a perdita d’occhio, tra le ultime colline e il mare – il mare – nell’aria fredda di un pomeriggio quasi passato, e benedetto dal vento che sempre soffia da nord.
La spiaggia. E il mare.
Potrebbe essere la perfezione – immagine per occhi divini – mondo che accade e basta, il muto esistere di acqua e terra, opera finita ed esatta, verità – verità – ma ancora una volta è il salvifico granello dell’uomo che inceppa il meccanismo di quel paradiso, un’inezia che basta da sola a sospendere tutto il grande apparato di inesorabile verità, una cosa da nulla, ma piantata nella sabbia, impercettibile strappo nella superficie di quella santa icona, minuscola eccezione posatasi sulla perfezione della spiaggia sterminata. A vederlo da lontano non sarebbe che un punto nero: nel nulla, il niente di un uomo e di un cavalletto da pittore.
Alessandro Baricco, Oceano mare
In principio erano le minevaganti. Minevaganti tutto un nome, così come si legge, non staccato, perché almeno nel grafema deve comparire un senso di unione che, poi, in realtà, non esiste. Non minevaganti come quelle del film di Özpetek, per carità. Minevaganti e basta. Minevaganti come “la teoria delle minevaganti”, che corrisponde alla teoria cinetica dei gas, cioè, quella scienza che si occupa di descrivere un gas, appunto,come un gran numero di piccole particelle – atomi o molecole – che sono in costante movimento casuale. Casuale proprio, non direi. Però, l’analisi dice che le particelle, muovendosi, urtano tra di loro e con le pareti del contenitore in cui sono costrette. E giacché questa teoria serve a spiegare le principali qualità dei gas, quindi la pressione, la temperatura e il volume, è importante sapere che la pressione non è dovuta alla repulsione statica delle molecole, ma all’urto contro le pareti delle particelle.
Valentina Barile, #mineviandanti sull’Appia antica
«Trovati un’altra via da percorrere», il mio editore tuona qualche giorno dopo aver ricevuto #mineviandanti sull’Appia antica in casa editrice. Con queste parole capisco che gli è piaciuto. E ho la conferma che un altro orso da interpretare stia entrando nella mia vita. Penso alla Salaria, alla terra sulla faglia, all’appennino centrale, ma subito metto da parte questa idea di viaggio perché la ferita è ancora sanguinante. Un viaggio deve avere la sua etica, sennò diventa altro senza accorgersene, soprattutto se dopo lo si vuole narrare. E in che modo? E come viene poi percepito il racconto agli occhi di chi lo leggerà? Bisogna stare attenti a come si entra in certe cose per non fare del male.
«Ho deciso, la via Popilia. È la decisione più logica. La Popilia esce dalla costola dell’Appia e arriva a sud, in Calabria, quindi mi sembra la strada giusta».
«Dimmi solo quando, e partiamo». Federica, sempre lei, che non ha bisogno di sapere dove e perché, ma solo il quando.
Valentina Barile, #mineviandanti sulla via Popilia
Accadeva in pieno tempo di guerra, su una banchina ferroviaria piatta e polverosa come la sconfinata distesa che la circondava. Fermo a caldaia accesa, il treno diretto a ovest si trovava a un paio di giorni da Mosca, a due o tre dalla meta, a seconda dell’approvvigionamento di carbone e dei movimenti delle truppe. Era da poco passata l’alba, ma l’uomo – o per meglio dire, il mezzo uomo – già si sospingeva verso i vagoni letto a bordo del suo carrello piatto montato su ruote di legno. Non c’era modo di manovrarlo, quell’arnese, se non bloccandone di colpo l’estremità anteriore, e, per non essere catapultato in avanti, l’uomo aveva passato una corda sotto il carrello e se l’era fatta girare intorno alla cinta dei calzoni. Le sue mani erano fasciate con strisce di stoffa annerita e la pelle era coriacea a furia di mendicare all’aperto fra strade e stazioni. Suo padre era stato un superstite della guerra precedente. Partito con la benedizione del prete per andare a combattere per la madrepatria e lo zar, non aveva più trovato, al ritorno, né prete né zar, e anche la madrepatria non era più la stessa. La moglie si era messa a strillare vedendo cosa gli aveva fatto la guerra. Adesso se ne combatteva un’altra, ma l’invasore era lo stesso, anche se diversi erano i nomi, da tutte e due le parti.
Julian Barnes, Il rumore del tempo
Tutto è partito da questo principio: che non bisognava ridurre l’innamorato a un puro e semplice soggetto sintomatologico, ma piuttosto dar voce a ciò che in lui vi è d’inattuale, vale a dire d’intrattabile. Di qui la scelta di un metodo “drammatico”, che rinuncia agli esempi e si basa unicamente sull’azione di un linguaggio immediato (niente metalinguaggio). La descrizione del discorso amoroso è stata perciò sostituita dalla sua simulazione, e a questo discorso è stata restituita la sua persona fondamentale, che è l’io, in modo da mettere in scena non già un’analisi, ma un’enunciazione.
Roland Barthes, Frammenti di un discorso amoroso
Da molti anni desideravo scrivere dei Finzi-Contini – di Micòl e di Alberto, del professor Ermanno e della signora Olga -, e di quanti altri abitavano o come me frequentavano la casa di corso Ercole I d’Este, a Ferrara, poco prima che scoppiasse l’ultima guerra. Ma l’impulso, la spinta a farlo veramente, li ebbi soltanto un anno fa, una domenica d’aprile del 1957. Fu durante una delle solite gite di fine settimana. Distribuiti in una decina d’amici su due automobili, ci eravamo avviati lungo l’Aurelia subito dopo pranzo, senza una meta precisa.
Giorgio Bassani, Il giardino dei Finzi-Contini
Ancora e ancora, nell’azzurro abisso del giorno colmo di ardenti, crudeli bagliori, il campanile di Celebeevo lanciava i suoi fragorosi appelli. Sopra, nell’aria, i rondoni iniziavano a volteggiare frenetici qua e là. Il giorno della Pentecoste, dagli aromi soffocanti, disseminava intanto sui cespugli delicate rose canine. La canicola era opprimente; e nella canicola le ali delle libellule divenivano vitree sopra lo stagno e si libravano verso il caldonell’azzurro abisso del giorno, lassù, verso la quiete celeste dei deserti. Un contadino accaldato si strofinava incessantemente il viso con la manica sudata per togliersi la polvere, trascinandosi in alto lungo il campanile per far oscillare il batacchio della campana, per faticare e adoperarsi per la gloria di Dio. E ancora e ancora lanciava i suoi rintocchi nell’azzurro abisso del giorno il campanile di Celebeevo; e sopra i rondoni svolazzavano e garrivano descrivendo delle figure a forma di otto.
Andrej Belyj, Il colombo d’argento
E’ la verità che conta. Adesso che sono vecchia, sono finalmente serena per poter vivere. Posso parlare e dare alle parole e ai tempi il loro posto. Mi sento un po’ affaticata. Non sono gli anni che mi pesano, ma soprattutto quello che non sono riuscita a dire: tutto quello che non ho detto e che ho dissimulato. Non avrei mai creduto che una memoria, piena di silenzi e di sguardi impenetrabili, potesse diventare un sacco di sabbia che rende difficile il cammino.
Tahar Ben Jelloun, Notte fatale
Sulla prima pagina è scritto: nell’affresco sono una delle figure di sfondo. La grafia meticolosa, senza sbavature, minuta. Nomi, luoghi, date, riflessioni. Il taccuino degli ultimi giorni convulsi. Le lettere ingiallite e decrepite, polvere di decenni trascorsi. La moneta del regno dei folli dondola sul petto a ricordarmi l’eterna oscillazione delle fortune umane. Il libro, forse l’unica copia scampata, non è più stato aperto. I nomi sono nomi di morti. I miei, e quelli di coloro che hanno percorso i tortuosi sentieri. Gli anni che abbiamo vissuto hanno seppellito per sempre l’innocenza del mondo. Vi ho promesso di non dimenticare. Vi ho portati in salvo nella memoria.
Luther Blisset, Q
In Norvegia c’è un fiordo – un braccio di mare lungo e stretto chiuso tra alte montagne – che si chiama Berlevaag Fjord. Ai piedi di quelle montagne il paese di Berlevaag sembra un paese in miniatura, composto da cascine di legno tinte di grigio, di giallo, di rosa e di tanti altri colori. Sessantacinque anni fa, in una delle casine gialle, vivevano due anziane signore. A quell’epoca altre signore portavano il busto e le due sorelle avrebbero potuto portarlo con altrettanta grazia, perché erano alte e flessuose. Ma non avevano mai posseduto un oggetto di moda, e per tutta la vita si erano vestite dimessamente, di grigio o di nero. Erano state battezzate col nome di Martina e Filippa, in onore di Lutero e del suo amico Filippo Melantone.
Karen Blixen, Il pranzo di Babette (in Capricci del destino)
Era già buio quando arrivai a Bonn. Feci uno sforzo per non dare al mio arrivo quel ritmo di automaticità che si è venuto a creare in cinque anni di continuo viaggiare: scendere le scale della stazione, risalire altre scale, deporre la borsa da viaggio, levare il biglietto dalla tasca del soprabito, consegnare il biglietto, dirigersi verso l’edicola dei giornali, comprare le edizioni della sera, uscire, fare cenno ad un tassì.
Heinrich Boll, Opinioni di un clown
Credo che la morte abbia sempre fatto parte di me. Forse è una banalità, una cosa che dicono tutti quelli che stanno per morire. Ma io non sono come tutti gli altri, o così mi piace credere. L’ho detto quando è morto Masood: il nostro tempo era solo in prestito. Non avremmo dovuto vivere così a lungo. Avremmo dovuto morire durante la rivoluzione. O sotto le sue macerie. O in guerra. Invece ho avuto altri trent’anni. Più di metà della mia vita. Non è poco. C’è di che essere grati. Tanti anni quanti ne ha mia figlia, la si può vedere anche così. Ma lei non aveva bisogno di avermi intorno così a lungo. Nessuno ne aveva bisogno. Si tende a pensare che, siccome siamo genitori, siamo necessari. Non è vero. Gli esseri umani imparano a cavarsela comunque. Chi lo dice che nella mia vita sono stata più di aiuto che di intralcio? Io no di certo. Non sono il genere di persona che dà più di quanto prenda. Dovrei esserlo. Sono una madre, in fin dei conti. Il mio compito è quello di spianare la strada agli altri. Ma non l’ho mai fatto, per nessuno.
Golnaz Hashemzadeh Bonde, Un popolo di roccia e vento

Si svegliò, aprì gli occhi. La stanza gli diceva poco o niente, profondamente immerso com’era nel non-essere da cui era appena affiorato. Se l’energia di accertare la propria collocazione nel tempo e nello spazio gli mancava, gliene mancava anche il desiderio. Sapeva soltanto di esistere, d’avere attraversato vaste regioni per ritornare dal nulla; c’era, al centro della sua coscienza, la certezza di una tristezza infinita e al tempo stesso rassicurante, poiché era la sola ad essergli familiare. Non aveva bisogno di ulteriore consolazione. Del tutto rilassato e a suo agio, giacque per un poco assolutamente immobile, poi scivolò in uno di quei sopori momentanei che spesso seguono a un sonno lungo e profondo.
Paul Bowles, Il tè nel deserto
Al largo i marinai erano un’ottima compagnia. Dal Dollart al Sund mi ero goduto i racconti di tempeste e naufragi con cui Huig, Melle e Aristides condivano i pasti, ma sulla terraferma mi sembrarono tizi un po’ rozzi. Avremmo dovuto raggiungere Oulu, il porto più a nord della Finlandia, per portare sale e caricare pasta di legno. Ma vedendo la stiva, il noleggiatore cambiò idea: era troppo sporca per trasportare sale da cucina. Dopo ventriquattr’ore di attesa al porto di Emden, il cabotiero si vide assegnare un’altra destinazione: Pärnu, in Estonia. Conoscevo il paese solo di nome, per via di quell’elenco imparato a scuola: Estonia, Lettonia e Lituania. Una filastrocca impossibile da dimenticare.
Jan Brokken, Anime baltiche
Quando, nel 1975, soggiornai per la prima volta nella mia vita a Leningrado, erano trascorsi solo nove anni dal giorno in cui Anna Achmatova aveva esalato l’ultimo respiro. In città la sua influenza era ancora tangibile, ma per non rischiare problemi con le autorità era meglio evitare di nominarla in pubblico. Proprio proibite le sue opere non lo erano più, un leningradese su dieci – a occhio – sapeva recitare a memoria il suo ciclo di poesie Requiem, eppure il suo nome continuava a evocare un sospetto di protesta e dissidenza. La versione completa e non censurata di Requiem in Unione Sovietica non sarebbe apparsa che molti anni dopo, nel 1987; Anna Achmatova era ancora parzialmente sulla lista nera.
Jan Brokken, Bagliori a San Pietroburgo
La prima volta che lo vidi indossava la camicia dei condannati davanti al plotone di esecuzione. Lui: un uomo di quasi trent’anni che si preparava alla morte e baciava la croce d’argento che gli porgeva il prete. Io: un ragazzino curioso che a distanza di sicurezza era testimone di cosa fosse l’ingiustizia. Ero in vacanza. Il 1849 fu l’anno del colera, la gente a San Pietroburgo moriva in massa. Per il rischio di contagio il nostro liceo venne chiuso già prima di settembre. Abitavo da uno zio e per mesi non feci che ciondolare per casa. A dicembre la direzione della scuola ci consigliò di tornare dalle nostre famiglie per trascorrere le feste. Fuori città c’erano meno vittime e pensai di mettermi in viaggio per Terpilicy. La tenuta era a sole 70 verste da Pietroburgo e si poteva raggiungere in un giorno. Forti nevicate non ce n’erano ancora state, la strada doveva essere accessibile, si poteva fare; invece mi trattenni da mio zio, il barone Nikolaj Korf, che abitava in una piccola casa di legno nell’angolo della Prospettiva Litejnyj con la Kiročnaja. Quando uno ha diciassette anni, non si cura tanto della famiglia e considera la città di gran lunga più eccitante della campagna, specie in inverno. In realtà mancavano ancora tre mesi al mio diciassettesimo compleanno, ma mi sentivo già un uomo fatto e in più ero altissimo per la mia età.
Jan Brokken, Il giardino dei cosacchi



Konstantin, il gallo di Marja, mi sveglia di nuovo durante la notte. Per Marja è una specie di surrogato. E’ stata lei ad allevarlo, coccolarlo e viziarlo fin da quando era un pulcino; ora è cresciuto e non serve a un bel niente. Si aggira impettito e dispotico per il cortile di lei e mi guarda di sbieco. Il suo orologio biologico è completamente sballato, è così da sempre, ma non credo che abbia a che fare con le radiazioni. Non possono certo essere ritenute responsabili di ogni forma di demenza che compare sulla terra.
Alina Bronsky, L’ultimo amore di Baba Dunja
Il coltello graffia la vernice rossa, disegna la traccia da seguire. È stato in quei giorni di nuvole inaspettate, di correnti gelide venute da lontano, di strade deserte e ricordi inafferrabili che il mare calmo sul quale navigava la mia vita ha cominciato a ruggire, rivelandomi che è nella sicurezza di ciò che è piatto e si offre allo sguardo che le tempeste peggiori sorprendono i viaggiatori. La mia colpa, se così la si può chiamare, era di aver ruotato il timone di qualche grado, quasi per gioco. Non dovevo essere lì, in quei giorni, ma a Milano, tra meeting e proiezioni e bottigliette d’acqua disposte in cerchio e ore passate in casa con jeans troppo larghi e scarpe da ginnastica per supervisionare la ristrutturazione del mio bagno. Per assicurarmi che installassero la nuova cucina come Dio comanda. Volevo i pavimenti in roccia naturale e la vasca multigetto e le piastre invisibili e il frigorifero intelligente: ero arrivato al punto della mia vita in cui credevo fosse giusto fare certi investimenti. Il punto in cui un uomo si accorge di avere scelto quella briciola di mappamondo nella quale infilzare la bandiera con scritto casa. Ma ho ruotato il timone proprio un attimo prima. La mia colpa, la mia fortuna.
Luca Brunoni, Il cielo di domani
La bicicletta rotta è appoggiata al muro della casa. Il patrigno l’ha recuperata e l’ha legata alla grondaia con una catena arrugginita. È una vecchia bicicletta dell’esercito e la ruota davanti – che è finita sotto l’automobile – è piegata a novanta gradi. Un pezzo di cartone penzola dal manubrio: sopra c’è scritto vendesi con una grafia sghemba. La osservo dai gradini dell’entrata. Ho levato le scarpe e dondolo i piedi sotto il sole di mezzogiorno. Nel basso della pancia sento il bisogno di fare pipì che preme, ma il patrigno è stato chiaro: non devo muovermi di qui. Lui è partito all’alba per il turno alla centrale elettrica. Ci va a piedi, perché il nostro quartiere non è lontano dalla centrale, che sta sulla riva nel punto in cui il fiume Aare si piega a serpente. Ieri ha detto che non mi voleva più. Piangeva, ma le lacrime non erano per me. Ha detto anche che qualcuno sarebbe venuto a prendermi, di aspettare fuori casa tra mezzodì e l’una. Poi è andato a dormire. Ha sbattuto la porta così forte che ho sentito lo schiaffo dell’aria.
Luca Brunoni, Silenzi
Il giorno in cui Qualcuno McQualcuno mi ha puntato una pistola al petto e mi ha chiamata gatta e ha minacciato di spararmi è lo stesso giorno in cui il lattaio è morto. È stato fatto fuori da una delle squadre d’assalto governative, e a me non è importato nulla che l’avessero fatto fuori. Ad altri importava però, e alcuni di questi mi conoscevano solo di vista, come si suol dire, ma non ci eravamo mai parlati, ed ero sulle loro bocche per un pettegolezzo che loro stessi avevano messo in giro, o più probabilmente era stato cognato numero uno, cioè che io avessi una relazione con questo lattaio, io diciottenne, lui quarantunenne. Sapevo quanti anni aveva, non perché l’avevano ammazzato ed era finito su tutti i media, ma perché questi professionisti del pettegolezzo non facevano che ripeterlo, da mesi, prima che gli sparassero, che una diciottenne con un quarantunenne era disgustoso, che ventitré anni di differenza erano una cosa disgustosa, che lui era sposato e non era il tipo da farsi abbindolare da me perché c’era un mucchio di gente tranquilla di cui nemmeno ti accorgevi che pure stava lì a sbirciare.
Anna Burns, Milkman

Nella primavera del 1958, la mia famiglia si trasferì dalla casa infestata di topi che affittava su King Street a uno degli ultimi prefabbricati di Cowdenbeath, proprio sul margine fra il bosco disseminato di macerie dietro Stenhouse street e i campi sterposi che si estendevano al di là. Eravamo saliti di qualche gradino, per più versi; i prefabbricati erano alloggi temporanei costruiti in tempo di guerra ma, almeno nella mia mente di bambino, il freddo e l’umido, le pozze di condensa delle mattine invernali e il caldo soffocante dei pomeriggi d’agosto erano minuzie rispetto al piacere di avere a disposizione, intorno a una casetta indipendente, un giardino a pochi metri dalla faggeta dove di notte cacciavano gli allocchi, i loro richiamo talmente vicini che sembrava di averli fra le mura di casa, nella minuscola stanza da letto che condividevo con mia sorella.
John Burnside, La natura dell’amore
La prima cosa che guardò una volta salita in macchina era l’orologio che aveva al polso sinistro: oltre a essere bello ed elegante, era diventato il suo talismano che l’accompagnava fedele durante le sue giornate, scandite sì dal tempo, ma soprattutto da un susseguirsi incessante e rassicurante di azioni codificate, la sua routine. Quasi fosse un robot con una scheda master di funzionamento in grado di prevedere un’adeguata risposta a ogni singolo evento potesse verificarsi, aveva organizzato la sua vita e, di fatto, viveva in un modo quasi standardizzato, grazie al quale faceva fronte alle sue insicurezze con una corazza creata ad arte.
Laura Busnelli, Al di là della paura
Nominato ufficiale, Giovanni Drogo partì una mattina di settembre dalla città per raggiungere la Fortezza Bastiani, sua prima destinazione. Si fece svegliare ch’era ancora notte e vestì per la prima volta la divisa da tenente. Come ebbe finito, al lume di una lampada a petrolio si guardò allo specchio, ma senza trovare la letizia che aveva sperato. Nella casa c’era un grande silenzio, si udivano solo piccoli rumori da una stanza vicina; sua mamma stava alzandosi per salutarlo. Era quello il giorno atteso da anni, il principio della sua vera vita. Pensava alle giornate squallide dell’Accademia militare, si ricordò delle amare sere di studio quando sentiva fuori nelle vie passare la gente libera e presumibilmente felice; delle sveglie invernali nei cameroni gelati, dove ristagnava l’incubo delle punizioni. Ricordò la pena di contare i giorni ad uno ad uno, che sembrava non finissero mai.
Dino Buzzati, Il deserto dei Tartari
Sul posto. – Quanto dobbiamo restarci quassù, chiede lui mentre la segue zoppicando per la scarpata dell’albergo. Indossa un completo verde scuro e delle scarpe da ginnastica blu con la chiusura a strappo. I calzoni gli vanno corti. Quattro notti, dice lei, dai, vieni. Mamma mia, era meglio se ce ne restavamo a casa, dice lui, ho fame. Ha un sacchetto di plastica in mano. Una buona volta che abbiamo vinto ci andiamo eccome, fa lei. Vinci una volta a tombola, dice lui, una volta nella vita sei il grande vincitore, il re del montepremi, e per punizione ti tocca dormire quattro notti fuori casa, e per di più il trentunesimo anniversario di matrimonio, ma ti sembra giusto, sospira lui, cristo se è ripido. Ormai non manca molto, dice lei chiudendosi il golfino rosso sul collo. Avessimo vinto il secondo premio, dice lui, hai visto che cesto di roba da mangiare che c’era? Non li trovi neanche in Croazia dei cesti grossi così. E invece no, il bel cesto se l’è beccato quel testa di legno dell’Hans che adesso se ne sta a casa come un pascià e se la ride fin dentro i calzoni.
Arno Camenisch, La cura
Orapronobis, certo che quest’anno il Vecchio lassù se la prende comoda, sacramento, non sarebbe male se cadesse un po’ di neve, dice il Paul e guarda il cielo, ma quel somaro del Pietro si fa pregare e il suo capo ha altri pensieri. Si scherma gli occhi con la mano, ha in testa una cuffia di lana ed è fermo davanti alla baita dello skilift. Il cielo è bluastro come l’acciaio, sta sorgendo il sole. Cosa vuoi farci, una spolverata è ben scesa, prendiamo quel che viene, dice il Georg e si sistema il berretto, vedrai che vien giù ancora qualcosina, purtroppo non sta a noi fare i miracoli. Porta una vecchia giacca da sci e ha un secchio rosso in mano. Ce n’è un velo, almeno, così fa un po’ inverno, una passata di zucchero sulle montagne, mica male, no? L’Onnipotente ha perso coraggio, dice il Paul, o forse dobbiamo chiedergliela in ginocchio ‘sta neve, ormai è più rara della coca. L’anno prossimo prendiamo esempio dagli austriaci, a fine stagione arrotoliamo la neve come un tappeto e la ritiriamo nel bunker, poi non appena novembre ha buttato giù ottobre dal balcone ed è tornato più freddo, che bisogna andare in motorino coi guanti, la tiriamo fuori dall’hangar e la srotoliamo, non si accorge nessuno che gli ripresentiamo la neve dell’anno prima, non gli viene neanche in mente, e non c’è scritto da nessuna parte che è vietato, tanto fanno i furbi pure gli austriaci. Il Georg appoggia il secchio rosso vicino al Paul, prende una sigaretta dalla tasca della giacca e se l’accende, mmh. Se ci beccano ci fingiamo morti, dice il Paul guardando il cielo. Madre mia, che c’è capitato in questa vita … Oppalà, e m’è anche caduta la sigaretta di bocca, fa il Georg cercandola con gli occhi nella neve.
Arno Camenisch, Ultima neve
Oggi la mamma è morta. O forse ieri, non so. Ho ricevuto un telegramma dall’ospizio: “Madre deceduta. Funerali domani. Distinti saluti.” Questo non dice nulla: è stato forse ieri.
L’ospizio dei vecchi è a Marengo, a ottanta chilometri da Algeri. Prenderò l’autobus delle due e arriverò ancora nel pomeriggio. Così potrò vegliarla e essere di ritorno domani sera. Ho chiesto due giorni di libertà al principale e con una scusa simile non poteva dirmi di no. Ma non aveva l’aria contenta. Gli ho persino detto: “Non è colpa mia.” Lui non mi ha risposto. Allora ho pensato che non avrei dovuto dirglielo.
Albert Camus, Lo straniero
Come ogni mattina entri nel solito bar per fare colazione. Da quando vivi solo – da parecchio, ormai – non ti riesce di fare colazione a casa. La cena, a volte il pranzo, sì. Chissà perché, invece, la colazione no. Così ogni mattina vai al bar. A volte resti in piedi al bancone, altre volte ti siedi a un tavolino e te la prendi più comoda. Non c’è una regola, dipende da come ti senti – come non ti senti -, dal tempo, dagli impegni o dalla loro assenza, dal caso. Non lo sai perché a volte ti siedi e a volte no.
Oggi ti siedi, e sul tavolino è poggiato un quotidiano. Così, aspettando il caffè e la brioche, sfogli distrattamente le pagine, leggendo i titoli. Sempre per dire del caso: ci sono due fogli attaccati. Non si vogliono separare e tu stai quasi per lasciar perdere quando, alla fine, le pagine si aprono e ti ritrovi nel bel mezzo della cronaca nera e giudiziari.
Gianrico Carofiglio, Il bordo vertiginoso delle cose
Doveva decidersi a buttare più spesso l’umido. Da quanto tempo se lo ripeteva? Anni, sicuramente. Ogni estate, a causa della sua indolenza, il conferimento della frazione umida nell’apposito bidone diventava, ogni volta, una complicata serie di procedure, la maggior parte delle quali disgustose. In queste occasioni, Aldo se ne usciva di casa con il fare circospetto di un delinquente intento a far sparire un cadavere che scotta, portandolo via in un tappeto arrotolato. Il paragone calzava a pennello: il sacco dell’umido, puntualmente dimenticato nel bidoncino per dieci giorni, puzzava proprio come un cadavere e una volta estratto diventava una specie di placenta sfatta, piena di materia in putrefazione, brulicante larve di mosca, da cui colavano liquidi nauseabondi. Trasportare questa materia raccapricciante fino al bidone comportava diversi accorgimenti.
Francesco Casoni, Le mille verità

Una volta seduto, Mansani si allentò la sciarpa, perché la lana gli dava prurito al mento; si sfilò i guanti, buttò indietro il cappello, e tirò fuori il pacchetto di Macedonia dalla tasca interna della giacca. La prima sigaretta della giornata: la migliore. L’accese, l’aspirò profondamente, e ricacciò il fumo dalla bocca e dal naso. La carrozza era semivuota, ma si sarebbe riempita strada facendo. Erano sei mesi che partiva a quell’ora, e i viaggiatori abituali li conosceva tutti. Operai per la maggior parte; qualche studente, qualche altro impiegato. Il giovedì viaggiava anche gente di campagna, contadini, fattori: e quelli che salivano a San Vincenzo, non trovavano più da sedere. Mansani si levò il cappello, appoggiò la testa alla spalliera e chiuse gli occhi. Un minuto dopo, s’era assopito. Aprì gli occhi quando il treno si mosse; cambiò posizione e si riaddormentò.
Carlo Cassola, Una relazione
Ci sono segreti che esistono per il piacere di non essere raccontati e altri che si trascinano appresso la vergogna. Matilde Mezzalama, nella sua decorosa esistenza, ne aveva collezionati diversi del primo tipo, una cena con un ex di nascosto dal marito che la credeva a una riunione di condominio, o quando aveva speso più di un milione e settecentomila lire, erano gli anni Ottanta, per una mantella di visone comprata da una televendita. La serata con l’ex era stata prevedibile: i due si erano ritrovati davanti a un piatto di spaghetti con le sarde, evitando di guardarsi per non vedere come erano diventati. Dopo quella volta non si erano più cercati e avevano smesso di provare la nostalgia semplice dei primi innamoramenti. La mantella, invece, un capriccio acquistato a rate, si era rivelata eccessiva per l’altezza modesta di Matilde. L’aveva indossata per un capodanno in trattoria e al funerale della madre di una collega, e in entrambe le occasioni si era sentita esagerata.
Paola Cereda, Quella metà di noi

La mamma non mi aveva detto che sarebbero venuti. Non voleva che sembrassi nervosa, mi spiegò in seguito. Mi stupii, perché pensavo che mi conoscesse bene. Gli estranei mi avrebbero vista serena. Da bambina non piangevo mai. Solo mia madre si accorgeva di una certa tensione nelle mie mascelle e dello sgranarsi dei miei occhi, già grandi per loro natura.
Tracy Chevalier, La ragazza con l’orecchino di perla
Non so bene da dove cominciare. È molto difficile. C’è tutto questo tempo andato, che le parole non riacciufferanno mai, e così i volti, i sorrisi, le ferite. Ma bisogna pure che io cerchi di dire. Di dire ciò che da vent’anni mi rode l’animo. I rimorsi e le grandi domande. Bisogna che apra il mistero a coltellate come se fosse una pancia, e che vi immerga le mani, anche se questo no cambierà niente di niente. Se mi domandassero per quale miracolo conosco tutti i fatti che racconterò, risponderei che li so, punto e basta. Li so perché mi sono familiari come la sera che scende e il sole che sorge. Perché ho passato la vita a volerli radunare e ricucire, per farli parlare, per ascoltarli. Una volta era un po’ il mio mestiere.
Philippe Claudel, Le anime grigie
Le anatre sguazzavano attraverso le finestre del salotto. Il peso dell’acqua aveva fatto spalancare le finestre e così le anatre ci nuotavano dentro. Veleggiarono per la stanza starnazzando in segno di approvazione; dopodiché salparono nuovamente per esplorare il meraviglioso nuovo mondo che era sopraggiunto durante la notte. Il Vecchio Ives sedeva sui gradini della veranda battendo con un bastone il suo secchiello rosso nel tentativo di richiamarle, ma queste lo ignorarono e fluttuarono via bianche e splendenti verso il campo da tennis. Lì c’erano i cigni, i colli intenti a scavare sotto l’acqua scura e fangosa. Mentre l’acqua irrompeva in luoghi inconsueti si udiva tutt’intorno un rumore stridente e affannoso, e in distanza un ruggito, e sopra questo le grida di uomini che cercavano di salvare gli animali dai terreni avvallati.
Barbara Comyns, Chi è partito e chi è rimasto
Soltanto i giovani hanno momenti del genere. Non dico i più giovani. No. Quando si è molto giovani, a dirla esatta, non vi sono momenti. E’ privilegio della prima gioventù vivere d’anticipo sul tempo a venire, in un flusso ininterrotto di belle speranze che non conosce soste o attimi di riflessione.
Joseph Conrad, La linea d’ombra
Poi Eric disse: Non voglio essere come quel tuo collega, Dennis-come-si-chiama, non voglio essere come lui, aggrappato alla propria ostinazione, nient’altro nella tesata ogni minuto di ogni singolo giorno, nient’altro che ostinazione. Non è vita quando l’unica cosa a cui pensi è come restare in vita. Si fermò e si guardarono, e fu come se l’uomo di cui Eric parlava e a cui non voleva assomigliare si fosse materializzato nello spazio gelido della loro conversazione, quell’uomo il cui pensiero era stato tutto rivolto a non morire, che non aveva avuto nessun altro interesse, nessun altro argomento di cui parlare che non fosse la propria sopravvivenza, per il quale azioni, speranze, paure degli altri non avevano più avuto la minima importanza, niente al mondo più era contato se non lui stesso; non il passato, non il presente, non il futuro.
David Constantine, La biografa
Nella zona compresa fra il Pajarito e il Rio de la Plata, piegando bruscamente verso nord, fino a metà del suo corso sempre più stretto e in seguito distendendosi e tracciando lente curve fino alla foce, il rio Anguilas serpeggia, nascosto dalle prime isole. Passata l’ultima ansa, il grande fiume appare all’improvviso, increspato dal vento. È immenso, sebbene le acque in quel punto non siano affatto profonde: dalla foce del San Antonio a quella del Luján è tutto un unico banco. L’Anguilas sfocia al centro di quel bassofondo, in una pianura coperta di canneti. Comunque la si guardi, la zona appare desolata e nei giorni grigi, con molto vento, impressiona chiunque. A sinistra, molto distante, si affaccia l’isola Santa Mónica, scura e silenziosa come un bastimento. A destra, la costa si perde in una lontananza bluastra. Nei giorni chiari, guardando a sud, come quinte teatrali perennemente oppresse da una nuvola ferrigna, si possono scorgere i profili bianchi e grigi degli edifici più alti di Buenos Aires. Quando il fiume cala di livello fa emergere una parte del banco, e quando la secca è al punto più basso sembra che la terraferma si sia estesa, simulando nuovi ruscelli che attraversano la pianura coperta di canne. Qualche pescatore si arrischia su questa terra umida e desolata ma, se non ci stende sopra il graticcio che fa da pavimento alla barca, affonda fino ai ginocchi.
Haroldo Conti, Sudeste
Io vivo a Volgograd. Ma non è quella vera, la città sul fiume Volga che per quasi quarant’anni s’è chiamata Stalingrado, teatro di una delle più importanti battaglie della Seconda guerra mondiale, per quanto per certi aspetti le somigli. Quella che io chiamo Volgograd ha più modestamente origine da volgo, popolo, come la parola volgare, e si trova tutt’attorno a Roma, come un’immensa ciambella di grasso malsano sui fianchi di una pigra, golosa vecchiaccia. O come un cappio di canapa bella grossa, stretto al collo di un disperato. Dovrebbe essere sempre Roma, in effetti, e invece Volgograd è Volgograd. Anche perché Roma, quella autentica, quella nelle Mura Aureliane, è una specie di fantasma, di finzione scenica, perché i romani non ci sono più. Ci sono solo preti, turisti e politici, nel centro storico, gente di fuori. I romani, quei pochi che ci sono nati, ormai vivono quasi tutti a Volgograd, un luogo urbano che si trova qui ma anche in mille altre città in giro per il mondo. Un enorme, labirintico, anonimo non-luogo, micidiale mistura di mancanza di onestà dei palazzinari, di mancanza d’idee di architetti e ingegneri, e di mancanza di scrupoli dei politici.
Luigi De Pascalis, Volgograd
È curioso il modo che ha il destino di venire sotto forma di tempo. Anzi lo sarebbe, se non fosse che ce l’ha per vizio. Se uno, al momento del fatto che gli cambia la vita, buttasse l’occhio all’orologio, vedrebbe le lancette che ripartono da uno zero fatto apposta per lui. Una risposta, una notizia, un incontro, un certo particolare squillo del telefono, arrivano con l’anteprima. Si fanno vedere e scappano in avanti, mostrando la sequenza fin dove l’occhio la segue. Tutto il futuro non lo conosciamo. Quello più in là soprattutto. Ma il primo sì. Lo vediamo benissimo. Livio e Dorina si erano conosciuti per strada. Una strada centrale secondaria, di quelle che la città tiene in bassa considerazione. Di quelle che, anche se ci abiti vicino da vent’anni, hai sempre fatto per andare da un’altra parte. Coi negozi che vorrebbero, dove pure le cose di marca sanno di imitazione. Le assicurazioni che si chiamano col cognome del titolare dell’agenzia. Dove si cammina con una fretta non proprio necessaria, quella fissità impaziente in cui se incontri qualcuno che conosci ci metti un poco a ricordartelo, e lo sforzo di memoria ti disturba. A maggior ragione, se alla fine di questa storia si andasse a chiedere a qualcuno che quella mattina si trovava a passare di là, se avrebbe mai sospettato che quei due estranei, solamente guardandosi, si sarebbero immediatamente riconosciuti in un futuro comune, ci si sentirebbe rispondere il più posato dei no.
Diego De Silva, La donna di scorta
Si svegliò con la certezza che i bambini dormissero ancora. La prospettiva della cena prese forma nella sua mente e, con essa, la sensazione di questa presenza, quella dei ragazzi nelle loro camere all’altro capo del corridoio, i loro corpi nascosti sotto le coperte. Un giorno sfilacciato scivolava dalla finestra e si infrangeva sullo spigolo del comò. L’alba bagnava la camera. Dalla casa, non sentiva il rumore delle onde, ma le arrivarono le grida dei gabbiani. Se le persiane non erano chiuse, e il giorno la trovava allungata sul fianco – il viso rivolto alla finestra – una delle prime immagini che distingueva, aprendo gli occhi, era il volo alto degli uccelli sopra un quadrato di cielo sul muro. Una carovana di nubi ci stazionava, a volte. Se le mattine erano grigie, Louise ci vedeva come un riflesso del mare, una schiuma che poteva essere bianca, o anche nera. Ma poco contano, in verità, le brezze marine: gli uccelli non cessano mai di dominare la città. Qualsiasi cosa accada alla gente del mare, loro sventrano il cielo comunque.La loro costanza le piaceva, niente poteva turbare le loro evoluzioni aeree.
Jean-Baptiste Del Amo, Il sale
E’ cominciato tutto, caro signore, sarà sei mesi fa, quando una mattina il postino ha recapitato una lettera dall’orribile profumo di violetta. O forse no, sarà meglio se dico che è cominciato dodici anni fa, quando nella mia casa onorata è venuto ad abitare un nuovo ospite che diceva di fare il pittore e di essere solo al mondo.
Marco Denevi, Rosaura alle dieci
L’estate in questo borgo è torrida e la gente per tutto il giorno non fa altro che parlare della calura e di quando, cessata la siccità, la terra potrebbe finalmente ricevere la benedizione di qualche goccia d’acqua. Il giorno trascorre velocemente in pigre conversazioni che di solito si svolgono all’ombra dei pergolati e sono spesso corroborate dalla buona acquavite locale, dal caffè molto forte, da qualche pezzo di formaggio o da una fetta di anguria. Così viene la sera – che comunque non è fatta per lavorare – e la gente si trasferisce dai pergolati domestici a quelli dei locali pubblici o va a sedersi su un muretto lungo la via principale e si mette a prendere le misure a quelli che passano. Si esamina e si commenta, si parla a bassa voce e si calunnia un po’…
Ivica Đikić, Cirkus Columbia

Emma Bovary tornò stanca dalla passeggiata. Il sole umido del pomeriggio l’aveva rattristata e convinta a rientrare prima del solito. Entrò nel salotto buono. Era gelido. Chiamò la servetta da poco a servizio e le ordinò di accendere il fuoco nel camino, l’unico camino della casa il cui tiraggio funzionava a dovere.
M.Di Francia/D.Mastrocinque, Amiche di penna
… lo so, l’ho capito, non avrei dovuto. Io, Alfa Ndiaye, figlio dell’uomo vecchissimo, l’ho capito, non avrei dovuto. Per la verità di Dio, adesso lo so. I miei pensieri appartengono soltanto a me, posso pensare quello che voglio. Ma non parlerò. Tutti quelli a cui avrei potuto dire i miei pensieri segreti, tutti i miei fratelli d’armi che saranno ripartiti sfigurati, resi storpi, sventrati, ridotti in uno stato che Dio si vergognerà di vederli arrivare nel suo Paradiso o il Diavolo sarà lieto di accogliere nel suo Inferno, non avranno saputo chi sono io veramente. I sopravvissuti non ne sapranno niente, il mio vecchio padre non ne saprà niente e mia madre, se è sempre di questo mondo, non lo indovonerà. Al peso della mia morte non si aggiungerà quello della vergogna. Non immagineranno che cosa ho pensato, che cosa ho fatto, fino a che punto mi ha condotto la guerra. Per la verità di Dio, l’onore della mia famiglia sarà salvo, l’onore di facciata. Lo so, l’ho capito, non avrei dovuto. Nel mondo di prima non avrei osato, ma nel mondo di oggi, per la verità di Dio, mi sono permesso l’impensabile. Nella mia testa non si è alzata nessuna voce a impedirmelo: le voci dei miei antenati, quelle dei miei genitori sono rimaste in silenzio quando ho pensato di fare quello che ho finito per fare. Adesso lo so, ti giuro che ho capito tutto quando ho pensato che potevo pensare qualunque cosa. È successo così, senza preavviso, mi è piombato brutalmente sulla testa come un grosso seme di guerra dal cielo metallico, il giorno in cui è morto Mademba Diop.
David Diop, Fratelli d’anima
Era una notte meravigliosa, una di quelle notti che forse esistono soltanto quando si è giovani, mio caro lettore. Il cielo era così stellato, così luminoso che, guardandolo, ci si chiedeva istintivamente: è mai possibile che sotto un simile cielo vivano uomini collerici e capricciosi? Anche questa, caro lettore, è una domanda da giovani, molto da giovani.
Fedor Dostoevskij, Le notti bianche. Romanzo sentimentale

Quell’autunno, l’iniziativa per la raccolta del sangue si tenne alla stazione dei pompieri di Grafton. Lo sceriffo Dan Norman era lì perlopiù in segno di buona volontà ma, siccome una delle infermiere non si era presentata, aveva acconsentito ad applicare il cotone nell’incavo del braccio dei donatori. «E grazie» diceva. Era primo pomeriggio quando arrivò Louise Darling. Dan la conosceva appena. C’era con lei anche Tiny Darling, il marito. Dan era convinto che Tiny fosse l’autore di alcuni furti con scasso avvenuti alla Westey’s Farm Home, sulla Highway 18. Non c’erano prove concrete, però.
Tom Drury, La fine dei vandalismi
L’uomo dietro il bancone dell’armeria non capiva cosa volesse Charles e chiamò la sorella dal retrobottega, ma neppure lei ci riuscì. Era il tardo pomeriggio di un venerdì di ottobre, e Charles sembrava parlare una lingua sconosciuta. Fuori, il vento soffiava a folate. La luce del sole si affacciava tra nuvole veloci e spazzava le vetrine. La sorella, con una maglia azzurra sformata, prese in mano la bacchetta di caricamento di un fucile semiautomatico, e per gioco vibrò un colpo sul braccio del fratello. Perlomeno, Charles la chiamava bacchetta di caricamento. Di certo aveva anche un altro nome. «In guardia» disse la donna. «Ti ho detto» ribattè il fratello «di starmi lontana con quella roba». A Charles pareva di aver chiesto una cosa abbastanza semplice: che i proprietari del negozio andassero dalla vedova del reverendo e le chiedessero di vendere il fucile che teneva appeso a due ganci sopra il caminetto.
Tom Drury, A caccia nei sogni
Tiny e Micah erano seduti in veranda sul retro della loro casa, ai confini della cittadina di Boris, e guardavano il sole che tramontava al di là della ferrovia e degli alberi. «Metti che devi portarti dietro qualcosa» disse Tiny. «Okay. Tipo cosa?». Micah, quattordici anni, aveva in testa un berretto verde scuro fatto a maglia. I capelli si incurvavano come piume intorno ai suoi placidi occhi castani. «Qualcosa di valore» disse Tiny. «Questo posacenere qui. Metti che è di valore». Il posacenere era di vetro verde, con conchiglie ingiallite attaccate al bordo. Veniva probabilmente da Yellowstone o da qualche altra località turistica. Forse, un tempo, era stato davvero di valore. Micah lo prese in mano e fece avanti e indietro lungo la veranda. «Bravo» disse Tiny. «Una cosa di valore devi sempre tenerla davanti a te, mai di fianco». «Io volevo solo evitare che volasse via la cenere». «Ora, metti che devi fare a botte». «Okay, anche se non capiterà». «Devi soltanto chinare la testa e colpirli all’altezza del plesso solare. Non se lo aspettano». «Io non me lo aspetterei». «Infatti, nessuno se lo aspetta» disse Tiny. «A volte svengono. Quasi sempre finiscono a terra». «Ricevuto». «E non farti mai una carta di credito». «Come farei a pagarne le spese?». «Non ce la faresti. É proprio questo il punto». Era una fresca serata di maggio. Il cielo rosso proiettava ombre sull’erba, sul capanno e sulla casa. «Sei sempre dell’idea di andare?» disse Tiny. «Puoi ripensarci in qualsiasi momento». «Papà non ho mai preso un aereo». «Possiamo chiedere a Paul Francis di farti fare un giro». «Un aereo vero, intendevo». Tiny annuì. «Dicevo per dire». Uno sparviero di Cooper dalla coda a strisce arrivò da ovest e si posò su un ramo dalle foglie nuove.«C’è il tuo sparviero» disse Tiny. «É venuto a salutarti».
Tom Drury, Pacifico

Ci sono tante cose che Melina ricorda. Tantissime. Soprattutto il giardino. Ricorda bene quando dal soggiorno uscivano in quello spazio verde e profumato. La lavanda, la cui fragranza vibrava fin dal primo istante in cui mettevano piede sull’erba. Globi di allium ovunque: un’orchestra di sfumature, dal rosa pallidissimo al viola intenso. I susini lungo il muro del giardino, i boccioli primaverili come un’esplosione sullo sfondo rosso scuro dei mattoni. E poi quelle enormi portefinestre così scomode che conducevano direttamente fuori di casa. Porte che restavano spalancate per tutta l’estate, nonostante l’inaffidabile clima irlandese. Allora era tutto più grande. Vivo. Ricco di possibilità. «Che bell’arietta fresca, Mitros» diceva la mamma, rimboccando la coperta intorno a quel corpo morbido e cedevole. Membra troppo rilassate, una testa e un collo che parevano insostenibilmente pesanti, come se rischiassero di staccarsi dallo stelo delicato della spina dorsale. «E hai ragione, sai: quest’aria pulita e frizzante ti fa molto bene. È proprio quello di cui hai bisogno.»
Catherine Dunne, Come cade la luce
Questa è la storia dei cinque anni che ho trascorso con la mia famiglia nell’isola greca di Corfù. In origine doveva essere un resoconto blandamente nostalgico della storia naturale dell’isola, ma ho commesso il grave errore di infilare la mia famiglia nel primo capitolo del libro. Non appena si sono trovati sulla pagina, non ne hanno più voluto sapere di levarsi di torno, e hanno persino invitato vari amici a dividere i capitoli con loro. Soltanto con immensa fatica, e usando una notevole astuzia, sono riuscito a salvare alcune pagine sparse che ho dedicate esclusivamente agli animali.
Gerald Durrell, La mia famiglia e altri animali
Sul lunotto ancora integro dell’auto deformata in mezzo ai frassini, la polizia trovò un adesivo che recitava: Esso è l’enigma di Dio, tanto vago e pur tanto certo. Dentro la macchina c’erano i corpi senza vita di due biologi. I giornali dissero che si trattava di una coppia che per anni aveva lavorato per la società Max Planck, cercando di interrompere il meccanismo patogeno di una rara malattia chiamata sindrome di Lanfora. Le ricerche con l’enzima di un fungo comune avevano fruttato loro un invito al più importante simposio tedesco di micologia, che a quel tempo era organizzato dall’Università di Hohenheim, a Stuttgart. Anche se l’università aveva offerto il rimborso del biglietto aereo da Berlino, la coppia aveva preferito viaggiare in macchina. Era estate e il tragitto offriva paesaggi sublimi. Alcuni giorni dopo, l’automobile comparve ribaltata su un lato dell’autostrada 71, nei boschi della Turingia. A trovarla fu l’autista di un camion che trasportava maiali provenienti da un porcile di Gotha: aveva notato le tracce di distruzione lasciate dall’auto prima di schiantarsi contro la fitta albereta. Stando alla testimonianza, l’uomo aveva fermato il camion per addentrarsi nella boscaglia in cerca di superstiti.
Orlando Echeverri Benedetti, Criacuervo
Fu allora che vidi il Pendolo. La sfera, mobile all’estremità di un lungo filo fissato alla volta del coro, descriveva le sue ampie oscillazioni con isocrona maestà. Io sapevo – ma chiunque avrebbe dovuto avvertire nell’incanto di quel placido respiro – che il periodo era regolato dal rapporto tra la radice quadrata della lunghezza del filo e quel numero “pi greco” che, irrazionale alle menti sublunari, per divina ragione lega necessariamente la circonferenza al diametro di tutti i cerchi possibili – così che il tempo di quel vagare di una sfera dall’uno all’altro polo era effetto di una arcana cospirazione tra le più intemporali delle misure, l’unità del punto di sospensione, la dualità di una astratta dimensione, la natura ternaria di “pi greco”, il tetragono segreto della radice, la perfezione del cerchio.
Umberto Eco, Il Pendolo di Foucault
In principio era il Verbo e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Questo era in principio presso Dio e compito del monaco fedele sarebbe ripetere ogni giorno con salmodiante umiltà l’unico immodificabile evento di cui si possa asserire l’incontrovertibile verità. Ma videmus nunc per speculum et in aenigmate e la verità, prima che faccia a faccia, si manifesta a tratti (ahi, quanto illeggibili) nell’errore del mondo, così che dobbiamo compitarne i fedeli segnacoli, anche là dove ci appaiono oscuri e quasi intessuti di una volontà del tutto intesa al male. Giunto al finire della mia vita di peccatore, mentre canuto senesco come il mondo, nell’attesa di perdermi nell’abisso senza fondo della divinità silenziosa e deserta, partecipando della luce inconversevole delle intelligenze angeliche, trattenuto ormai col mio corpo greve e malato in questa cella del caro monastero di Melk, mi accingo a lasciare su questo vello testimonianza degli eventi mirabili e tremendi a cui in gioventù mi accadde di assistere, ripetendo verbatim quanto vidi e udii, senza azzardarmi a trarne un disegno, come a lasciare a coloro che verranno (se l’Anticristo non li precederà) segni di segni, perché su di essi si eserciti la preghiera della decifrazione.
Umberto Eco, Il nome della rosa
Il passante che in quella grigia mattina del marzo 1897 avesse attraversato a proprio rischio e pericolo place Maubert, o la Maub, come la chiamavano i malviventi (già centro di vita universitaria nel Medioevo, quando accoglieva la folla degli studenti che frequentavano la Facoltà delle Arti nel Vicus Stramineus o rue du Fouarre, e più tardi luogo dell’esecuzione capitale di apostoli del libero pensiero come Étienne Dolet), si sarebbe trovato in uno dei pochi luoghi di Parigi risparmiato dagli sventramenti del barone Haussmann, tra un groviglio di vicoli maleodoranti, tagliati in due settori dal corso della Bièvre, che laggiù ancora fuoriusciva da quelle viscere della metropoli dove da tempo era stata confinata, per gettarsi febbricitante, rantolante e verminosa nella vicinissima Senna.
Umberto Eco, Il cimitero di Praga
L’uomo si chiamava Fred Elkins. Lavorava da venticinque anni sul treno postale della Long Island Railroad, sulla tratta di South Shore. Guadagnava quattromilaottocento dollari l’anno, meno le imposte e indennità varie, e viveva in una squallida casa di St. Albans, zona vicinissima a Jamaica, appena all’interno della linea di New York. Non aveva ancora fatto giorno quando si svegliò, la mattina del 23 dicembre e, vedendo la neve fioccare da un cielo scuro e rabbioso, capì che quello era il giorno giusto.
Max Simon Ehrlich, Una lettera dal passato
Ho fatto la parte pratica del concorso per il Capes in un liceo di Lione, sulla collina della Croix-Rousse. Una scuola nuova, con piante verdi nella sala riservata agli amministrativi e al corpo docente, una biblioteca dalla moquette color sabbia. Ho aspettato lì che mi venissero a chiamare. La prova consisteva in una lezione da tenere in presenza della commissione d’esame, un ispettore e altri due professori di lettere, tutti veterani dell’insegnamento. Una donna correggeva altezzosa gli scritti, senza esitazioni. Mi sarebbe bastato superare indenne l’ora successiva per essere autorizzata a fare come lei per il resto della vita.
Annie Ernaux, Il posto
Ci sono esseri che sono sommersi dalla realtà degli altri, dal loro modo di parlare, accavallare le gambe, accendere una sigaretta. Invischiati nella presenza degli altri. Un giorno, o piuttosto una notte, sono trascinati nel desiderio e nella volontà di un unico Altro. Ciò che credevano di essere scompare. Si dissolvono, e guardano il proprio riflesso agire, obbedire, trascinati nel corso sconosciuto delle cose. Sono sempre in ritardo sull’Altro, sulla sua volontà costantemente avanti di una mossa. Una volontà che non raggiungono mai.
Né sottomissione né consenso, soltanto lo sconcerto del reale che permette giusto di dirsi “cosa mi sta succedendo?” o “è a me che sta succedendo?”, se non fosse che un me, un io, in questa circostanza non c’è più, o non è già più lo stesso. C’è soltanto l’Altro, padrone della situazione, dei gesti, del momento successivo, che è l’unico a conoscere.
Annie Ernaux, Memoria di ragazza
Mio padre ha voluto uccidere mia madre una domenica di giugno, nel primo pomeriggio. Io ero andata alla messa di mezzogiorno meno un quarto come al solito. Dovevo essere passata a prendere dei dolci dalla pasticceria del quartiere commerciale, un gruppo di edifici provvisiori costruiti dopo la guerra in attesa che si completasse la ricostruzione. Tornata a casa mi sono tolta gli abiti della domenica per infilarmi dei vestiti più facili da lavare. Quando se ne sono andati gli ultimi clienti, e dopo aver posizionato le imposte di legno sulla vetrina della drogheria, ci siamo seduti per pranzo, probabilmente con la radio accesa perché a quell’ora andava in onda Le tribunal, una trasmissione comica con Yves Deniaud nel ruolo di un tecnico delle luci che finiva sempre per essere accusato di misfatti insignificanti e condannato a pene ridicole da un giudice dalla voce tremolante. Mia madre era di cattivo umore. Aveva cominciato a dare addosso a mio padre appena si era messa a tavola ed erano andati avanti a litigare per tutto il pranzo. Dopo aver sparecchiato e tolto le briciole dalla tovaglia cerata ha continuato a dargli contro affaccendandosi nella cucina minuscola – incastrata tra il bar, la drogheria e le scale che portavano al piano superiore -, com’era solita fare quand’era contrariata. Mio padre è rimasto seduto dov’era, senza replicare, con lo sguardo rivolto verso la finestra. Tutt’a un tratto ha iniziato a fremere convulso e a soffiare. Si è alzato e l’ho visto afferrare mia madre, trascinarla nel bar urlando con una voce roca, sconosciuta. Sono scappata di sopra e mi sono gettata sul letto, la faccia in un cuscino.
Annie Ernaux, La vergogna
La strada in cui era nato mio nonno si chiamava Nová Hospoda. Aveva preso il nome dal celebre locale gestito dai genitori dei miei nonni. Si trattava di un ristorante turistico coi tavoli sistemati sotto un grande castagno e una pista da ballo adiacente al muro. Ogni domenica suonava una banda, e le ragazze danzavano sul parquet vestite con abiti lunghi e cappelli nostalgici. Il nonno indossava sempre un elegante abito gessato, i capelli pettinati all’indietro fissati con l’acqua zuccherata. Spesso si sedeva al tavolo delle ragazze e raccontava, suscitando delle allegre risate. Sul cortile si affacciava la finestra della casa dei vicini. Era la finestra della loro cucina, a quel tempo la stanza più abitata, e proprio da lì una ragazza con le treccine si divertiva a guardare giù. All’inizio sembrava semplicemente affascinata da tutte quelle persone in ghingheri, dalla musica e dai lampioni che si accendevano la sera. Ma poi era ancora lassù il giorno dopo, mentre il nonno ripuliva il cortile dopo la serata danzante, e fu questo a destare i sospetti della madre. La madre realizzò infatti all’improvviso che sua figlia era cresciuta, e cominciò a temere che avesse preso una sbandata per il giovane vicino, il quale era sempre circondato da uno stuolo di donne. Le fu subito chiaro che si trattava di una questione altamente delicata, le ragazze della sua età sono un groviglio di sentimenti contrastanti, si ripropose dunque di parlarle alla prima occasione. I vicini avevano sicuramente una buona situazione patrimoniale e avevano trasmesso ai figli un’ottima educazione, ma alla mia bisnonna non sembrava comunque un buon partito. Guardando al futuro si preoccupava che il figlio dei vicini non avrebbe smesso di correre dietro alle donne nemmeno da sposato. Quando finalmente l’occasione di parlarle si presentò, venne a sapere che il groviglio di sentimenti contrastanti e il figlio dei vicini erano già in attesa di mio padre. E prima che riuscisse a capire come comportarsi iniziò la mobilitazione, e il figlio dei vicini, di cittadinanza ceca, fu chiamato al confine.
Martin Fahrner, Dalla parte del bene
Una sera me ne stavo a sedere sul letto della mia stanza d’albergo, a Bunker Hill, nel cuore di Los Angeles. Era un momento importante della mia vita; dovevo prendere una decisione nei confronti dell’albergo. O pagavo o me ne andavo: così diceva il biglietto che la padrona mi aveva infilato sotto la porta. Era un bel problema, degno della massima attenzione. Lo risolsi spegnendo la luce a andandomene a letto. Al mattino mi svegliai, decisi che avevo bisogno di un po’ di esercizio fisico e cominciai subito. Feci parecchie flessioni, poi mi lavai i denti. Sentii in bocca il sapore del sangue, vidi che lo spazzolino era colorato di rosa, mi ricordai cosa diceva la pubblicità, e decisi di uscire a prendermi un caffè.
John Fante, Chiedi alla polvere
Avanzava, scalciando la neve profonda. Era un uomo disgustato. Si chiamava Svevo Bandini e abitava in quella strada, tre isolati più avanti. Aveva freddo, e le scarpe sfondate. Quella mattina le aveva rattoppate con dei pezzi di cartone di una scatola di pasta. Pasta che non era stata pagata. Ci aveva pensato proprio mentre infilava il cartone nelle scarpe. Detestava la neve. Faceva il muratore e la neve gelava la calce tra i mattoni che posava. Era diretto a casa, ma che senso aveva tornare a casa?
John Fante, Aspetta primavera, Bandini
Negli anni più vulnerabili della mia giovinezza, mio padre mi diede un consiglio che non mi è mai più uscito di mente.” Quando ti vien voglia di criticare qualcuno” mi disse “ricordati che non tutti a questo mondo hanno avuto i vantaggi che hai avuto tu.” Non disse altro, ma eravamo sempre stati insolitamente comunicativi nonostante il nostro riserbo, e capii che voleva dire molto di più di questo. Perciò ho la tendenza a evitare ogni giudizio, una abitudine che oltre a rivelarmi molti caratteri strani mi ha anche reso vittima di non pochi scocciatori inveterati. (trad. Fernanda Pivano)
Francis Scott Fitzgerald, Il grande Gatsby

Eravamo in aula di studio, ed entrò il rettore, dietro gli venivano un nuovo ancora in panni borghesi e un bidello che trascinava un banco. Quelli che dormivano si svegliarono, ci tirammo su tutti, con l’aria di esser stati sorpresi nel fervore dell’attività. Il rettore fece segno che ci rimettessimo a sedere; poi si rivolse al prefetto: “Signor Roger,” gli disse a mezza voce, “vi affido questo allievo, entra in quinta. Se il suo profitto e la sua condotta saranno buoni, lo passeremo tra i grandi come vorrebbe la sua età.”
Gustave Flaubert, Madame Bovary
In venticinque anni di matrimonio Nelly Devenny aveva sempre avuto vergogna di sollevare lo sguardo a causa delle sregolatezze di Tom. Era raramente sobrio, incapace di tenersi un lavoro per più di qualche settimana e sempre in lite con qualcuno. Quando cadde dalla bicicletta, un sabato sera, e venne ucciso da una moto che passava, nessuno, nel paese di Drumeen, si meravigliò che Nelly non fosse distrutta dal dolore. Ella accettò la morte serenamente e con composta dignità, e, quando la bara venne calata nella fossa, versò persino qualche lacrima.
Brian Friel, Tutto in ordine e al suo posto
Riagganci la pesante cornetta di opaca bachelite nera. I pensieri già in un luogo diverso dall’altro capo del filo. Sei davanti a un’auto. È nera, ed è tua. L’hai ereditata da tua sorella che l’ha avuta in regalo dal suo amante. Non è nuova, ma vent’anni fa era un’auto riservata a re e primi ministri e la vernice e le parti cromate luccicano ancora. I fari sono due grandi occhi gialli sopra l’alta curva dei parafanghi. Sulle lamelle della mascherina, due V rovesciate. Il volante è bianco. In mano stringi le chiavi. Tra un attimo salirai sull’auto e percorrerai la città già svuotata dal buio. Ma rimani qui per un istante, nella breve luce color miele che precede il tramonto. La serata è afosa e immobile. Se vuoi puoi prendere il portafogli dalla cartella, estrarre la fotografia. Lasciare che lei ti sorrida, la testa leggermente inclinata a destra. Le dita fresche di manicure della mano sinistra sfiorano la clavicola. I capelli scuri, sciolti e arricciati, incorniciano il viso pallido e liscio.
Peter Fröberg Idling, Canto della tempesta che verrà
Il martedì di giugno in cui fu assassinato, l’architetto Garrone guardò l’ora molte volte. Aveva cominciato aprendo gli occhi nell’oscurità fonda della sua camera, dove la finestra ben tappata non lasciava filtrare il minimo raggio. Mentre la sua mano, maldestra per impazienza, risaliva lungo le anse del cordoncino cercando l’interruttore, l’architetto era stato preso dalla paura irragionevole che fosse tardissimo, che l’ora della telefonata fosse già passata. Ma non erano ancora le nove, aveva visto con stupore; per lui, che di solito dormiva fino alle dieci e oltre, era un chiaro sintomo di nervosismo, di apprensione.
Fruttero & Lucentini, La donna della domenica
È finita. La spiaggia di Big Sur è vuota, e io me ne sto sdraiato sulla sabbia, nel punto stesso in cui mi sono lasciato cadere. La nebbia marina addolcisce le cose; non una vela all’orizzonte; su una roccia, davanti a me, migliaia d’uccelli; su un’altra, una famiglia di foche: il padre viene fuori instancabilmente dall’acqua, lucente e indaffarato, con un pesce in bocca. Le rondini di mare mi si posano a volte così vicino, che trattengo il respiro e sento che dentro di me si risveglia e si muove il mio vecchio desiderio: tra un po’ verranno a posarmisi sul viso, a nascondere la testa sul mio collo e a rannicchiarsi tra le mie braccia; mi ricopriranno tutto…
Romain Gary, La promessa dell’alba
Per prima cosa vi posso dire che abitavamo al sesto piano senza ascensore e che per Madame Rosa, con tutti quei chili che si portava addosso e con due gambe sole, questa era una vera e propria ragione di vita quotidiana, con tutte le preoccupazioni e gli affanni. Ce lo ricordava ogni volta che non si lamentava per qualcos’altro, perché era anche ebrea. Neanche la sua salute era un granché e vi posso dire fin d’ora che una donna come lei avrebbe meritato un ascensore. Dovevo avere tre anni quando ho visto Madame Rosa per la prima volta. Prima non si ha memoria e si vive nell’ignoranza. La mia ignoranza è finita verso i tre o quattro anni e certe volte ne sento la mancanza. C’erano molti altri ebrei, arabi e neri a Belleville, ma Madame Rosa era l’unica che si doveva arrampicare fino al sesto piano. Diceva che un giorno o l’altro ci sarebbe morta per quella scala, e tutti i marmocchi si mettevano a piangere, perché si fa sempre così quando muore qualcuno.
Romain Gary, La vita davanti a sé
Garzon non capiva perché quel cadavere mi colpisse tanto, e non riusciva nemmeno a spiegarsi la natura della mia emozione. Secondo lui ormai avevamo visto più morti di Napoleone e Nelson messi insieme, e non si poteva certo dire che quella mattina il Parque de la Ciudadela fosse il campo di Waterloo dopo la battaglia. Un barbone sdraiato su una panchina, questo era tutto. Sembrava semplicemente che fosse rimasto addormentato e che, nonostante quel che gli stava capitando intorno, non si fosse ancora svegliato.
Alicia Gimenez-Bartlett, Un bastimento carico di riso
Era terribile. Mi avvicinavo a poco a poco a quella bara aperta senza vedere chi ci fosse dentro. Era un feretro imponente, di legno lucido e sontuoso. Enormi ceri e svariate corone di fiori circondavano da ogni lato il defunto. Ma più mi avvicinavo, più il mio passo si faceva sicuro, e meno intenso il timore. Quando arrivavo ai piedi del catafalco scoprivo, guardando dentro, la salma di un vecchio, in un impeccabile abito nero, con una fascia tricolore e il petto coperto di medaglie e onorificienze. Non lo avevo mai visto, non sapevo chi fosse, ma era di certo una persona importante. A quel punto, con decisione, infilavo la mano nella borsetta e tiravo fuori un lungo coltello.
Alicia Gimenez-Bartlett, Gli onori di casa
Carlos Infante notò con soddisfazione che quella mattina il cielo era sereno e splendeva il sole. Solitamente non gli importava nulla del tempo che faceva. Gli bastava avere un ombrello se pioveva o il suo vecchio giaccone se faceva freddo. Ma quel lunedì era un giorno speciale, o almeno prometteva di esserlo. Nella sua monotona vita, nella monotona vita di tutti gli spagnoli, un semplice appuntamento inaspettato poteva trasformarsi in un evento eccezionale. E lui a mezzogiorno aveva un appuntamento talmente insolito da sembrargli addirittura irreale. Aveva valutato la possibilità che si trattasse dello scherzo di uno dei suoi colleghi giornalisti, oppure di un equivoco, di un malinteso. Eppure no, il timbro postale indicava chiaramente che la lettera veniva da Parigi. La rilesse ancora una volta mentre faceva colazione con una misera tazza di caffè nella sua cucina semibuia.
Alicia Gimenez-Bartlett, Dove nessuno ti troverà
Qualche tempo dopo la mia seconda separazione decisi di cercarmi una casetta con giardino in città. Un obiettivo difficile, ma ci riuscii. Era qualcosa di più che un capriccio. Troppi anni passati in appartamenti con mobili funzionali e un gran congelatore. Ora si presentava l’occasione di abitare da sola in un posto tranquillo, e volevo che fosse un’opportunità per cambiare. La casa era a Poblenou, un quartiere non troppo lontano dal centro. Tutt’intorno c’erano case vecchie e cadenti come quella che avevo comprato, fiancheggiate da capannoni industriali, imprese di trasporti, rimesse degli autobus.
Alicia Gimenez-Bartlett, Riti di morte
Si dice che l’origine e il nome stesso di Kumasi risalgano all’epoca del grande guerriero Osei Tutu, che riuscì a riuneire sotto il suo potere in un unico popolo i clan provenienti dalla savana sub-sahariana stanziatisi già dal dodicesimo secolo sulle colline e sulle alture sparse dell’Africa occidentale, nel cuore dell’odierno Ghana, dando così vita al glorioso Regno degli ashanti. Quando Osei Tutu volle dare al suo regno una capitale, chiamò a sé il venerato stregone Okomfo Anokye, che dall’alto della sua saggezza e veneranda età fece piantare due alberi di kum a qualche miglio di distanza l’uno dall’altro in due radure pianeggianti egualmente favorevoli, e dove la pianta germogliò e crebbe più rigogliosamente la città fu edificata (kum asi significa appunto “sotto l’albero di kum“).
Francesca Giommi, Il tesoro degli ashanti. Viaggio in Ghana
Tre testi che si rispecchiano a vicenda delineano l’enigma che viene proposto al lettore: che cosa ne è stato del capolavoro di Ingres La dormiente di Napoli, dipinto per la regina Carolina Murat più o meno nello stesso periodo della celebre Odalisca? Il dipinto è sparito nel 1815. E’ da lì che trent’anni più tardi Ingres trarrà ispirazione per la sua Odalisca con la schiava? Il quadro, però, non è stato mai ritrovato. Dimenticato in qualche soffitta? Nascosto? Rubato? Ecco la posta in gioco nel romanzo.
Adrien Goetz, L’odalisca perduta
Non c’è niente di meglio della Prospettiva Nevskij, almeno a Pietroburgo, dove essa è tutto.
Nikolaj Gogol, La Prospettiva Nevskij
E’ successa una cosa terribile. Seguono la notizia alla televisione dopo cena, con una tazza di caffè appoggiata lì accanto. Bosnia, Somalia o il terremoto che come un mastino scuote tra fauci apocalittiche un’isola giapponese: uno qualsiasi dei disastri di quel periodo. Quando suona il citofono si guardano con amichevole riluttanza; vai tu, tocca a te.
Nadine Gordimer, Un’arma in casa
Adesso è morto anche tuo marito, Anna. Tuo marito, nostro marito. Mi sarebbe piaciuto che riposasse accanto a te, ma tu hai già due vicini di posto, un avvocato e una signora seppellita un paio d’anni fa. Quando arrivasti tu, l’avvocato c’era già da parecchio tempo. Ho trovato un lotto libero per Georg nella fila successiva; dalla tua tomba si vede il dietro della sua lapide. Ho scelto l’arenaria, nonostante il marmista mi abbia detto che risente delle intemperie. E allora? Il granito non mi piace. I gemelli invece lo avrebbero preferito, su questo punto una volta tanto erano d’accordo. Il granito è troppo pesante, e il nostro Georg accusava un forte senso di oppressione al petto. Forse avremmo dovuto prenderlo più sul serio, ma lui minimizzava. Prima si lamentava e poi, quando volevi condividere la sua preoccupazione, trocava il discorso. Georg era fatto così.
Jens Christian Grøndahl, Spesso sono felice
Era andata così, che qualche mese dopo che Nonna Heni fu morta e seppellita sottoterra, Momik ebbe un nuovo nonno. Questo nonno arrivò nel mese di Shevat dell’anno cinquemilasettecentodiciannove, che in lingua straniera sarebbe il mille novecento e cinquantanove, e non venne dal Dipartimento per la Ricerca dei Congiunti e Nuovi Immigrati, la cui trasmissione Momik doveva stare a sentire tutti i giorni tra l’una e venti e l’una e mezzo mentre mangiava la colazione, e star bene attento se alla radio dicevano uno dei nomi che il babbo gli aveva scritto su un foglio: no, il nonno era arrivato con un’ambulanza della Stella-di-Davide-Azzurra che si era fermata nel pomeriggio nel bel mezzo di una bufera di pioggia davanti alla Drogheria-caffè di Bella Markus, e ne era sceso un uomo grasso e abbronzato ma non uno di quelli neri bensì uno dei nostri, e aveva chiesto a Bella se conosceva qui nella strada la famiglia Neuman, e Bella si era spaventata e si era asciugata presto presto le mani al grembiule e aveva chiesto sì sì è successo qualcosa Dio liberi?
David Grossman, Vedi alla voce: amore
C’era un uomo chiamato Torsten Bergman, esile e bianco di capelli. Era un piastrellista, nato nel 1917. E quindi quel grigio mattino di novembre del 1982 in cui questa storia ha inizio, a Uppsala, aveva già sessantacinque anni. Dormiva in un letto che un tempo era stato doppio e matrimoniale. Adesso era singolo, e con lenzuola mal lavate. Vecchi giornali e qualche bottiglia vuota giacevano sparsi qua e là sul pavimento, in un angolo c’era ancora il vecchio tappeto nero pieno di peli dove usava dormire il cane. La giornata incominciò nell’unico modo possibile: l’erba già morsa dalla prima gelata, il cane sparito da due giorni, tutto vago e incerto, la sua vita più di ogni altra cosa.
Lars Gustafsson, Il pomeriggio di un piastrellista
Io sono un vincente. Ho appena compiuto ottant’anni. Un’età che si può chiaramente raggiungere senza grandi problemi, se si segue la mia ricetta. La ricetta del Dottor Kurth W. Wasser. Ormai da molto passo una quantità spropositata del mio tempo a vincere concorsi. Tutto ha avuto inizio qualche anno fa, quando sono andato in pensione. Li trovo ovunque, su volantini pubblicitari, in varie riviste più o meno raffinate, perfino nelle pagine più leggere, di intrattenimento, dei quotidiani. Sì, hanno cominciato a comparire in pratica dappertutto. Questi strani compiti. Che nessuno ha richiesto.
Lars Gustafsson, La ricetta del dottor Wasser
Siamo arrivate con il vento del carnevale. Un vento tiepido per febbraio, carico degli odori caldi delle frittelle sfrigolanti, delle salsicce e delle cialde friabili e dolci cotte alla piastra proprio sul bordo della strada, con i coriandoli che scivolano simili a nevischio da colletti e polsini e finiscono sul marciapiedi come inutile antidoto contro l’inverno. C’è un’eccitazione febbrile nella folla disposta lungo la stretta via principale, i colli che si allungano per vedere il carro fasciato di carta crespata, con i suoi nastri svolazzanti e le coccarde di cartoncino.
Joanne Harris, Chocolat
Mi stavo muovendo tra loro come se volessi trovare l’uscita da un labirinto. Avevamo letto insieme un saggio di Ricardo Piglia sul carattere doppio della forma del racconto, e non mi sorprese vedere tutti quei volti pieni di acne e della più tenera confusione.Un racconto sempre rivela due storie, avevamo letto. Un racconto visibile nasconde un racconto segreto, avevamo letto. Il racconto si costruisce per far apparire artificialmente qualcosa che era occulto, avevamo letto, e allora domandai loro se avessero capito qualcosa, qualsiasi cosa, ed era come se stessi parlando in un dialetto africano. Silenzio. E audace, impavido, continuai ad addentrarmi nel labirinto. Alcuni erano mezzi addormentati. Altri facevano disegnini. Una ragazza molto magra giocava noiosamente con la sua bionda chioma, attorcigliandosi e srotolandosi la frangetta intorno all’indice. Al suo fianco, un bel ragazzo se la stava mangiando con gli occhi. E dal più profondo mutismo, mi arrivò uno strepito di mormorii e risate contenute e gomme masticate e allora, come tutti gli anni, mi domandai se per quella merda in realtà valesse la pena continuare.
Eduardo Halfon, Il pugile polacco

Edith Goodnough non vive più in campagna. Ormai sta in città, in ospedale, in quel letto bianco, con un ago infilato nel dorso della mano e un uomo che la sorveglia in corridoio, fuori dalla sua stanza. Questa settimana compie ottant’anni: una donna linda, bella, con i capelli bianchi, che in vita sua non è mai arrivata a pesare cinquanta chili e da Capodanno pesa ancora meno di così. Eppure lo scerifo e gli avvocati aspettano che stia meglio per metterla su una sedia a rotelle e portarla in tribunale, dall’altra parte della cittadina, per iniziare il processo. Quando accadrà, sempre che accada, non so se arriveranno a metterle le manette. D’accordo, Bud Sealy, lo sceriffo, si è rivelato un figlio di puttana, ma proprio non ce lo vedo ad ammanettare una donna come Edith Goodnough. Del resto, non è che Bud Sealy avesse mai voluto diventare un figlio di puttana. Soltanto nove giorni fa era seduto su uno sgabello dell’Holt Café. Era un venerdì pomeriggio; ogni giorno, alle due e mezzo circa, finito di compilare le sue scartoffie, arrivava quel momento di calma in cui non aveva più niente da fare tranne aspettare i ragazzi delle superiori che, usciti da scuola, cominciavano i loro giri in macchina su e giù per Main Street oppure fuori città sulla US-34, correndo a zig-zag sull’asfalto.
Kent Haruf, Vincoli

Appena gli esiti dell’esame furono pronti, l’infermiere li chiamò nell’ambulatorio, e quando il medico entrò nella stanza diede loro un’occhiata e li invitò a sedersi. Capirono come stavano le cose guardandolo in faccia.
Kent Haruf, Benedizione
A Holt c’era quest’uomo, Tom Guthrie, se ne stava in piedi alla finestra della cucina, sul retro di casa sua, fumava una sigaretta e guardava fuori, verso il cortile posteriore su cui proprio in quel momento stava spuntando il giorno. Quando il sole ebbe raggiunto la sommità del mulino a vento, l’uomo rimase a guardare la luce che si faceva sempre più rossa sulle alette di acciaio e sulla coda, alte sulla piattaforma in legno. Dopo un po’ spense la sigaretta, salì al piano di sopra, passò oltre la porta chiusa dietro la quale lei giaceva a letto al buio nella camera degli ospiti, addormentata oppure no, e percorse il corridoio fino alla stanza a vetrate sopra la cucina, dove c’erano i due ragazzi.
Kent Haruf, Canto della pianura

Tornarono dalla scuderia nella luce obliqua del primo mattino. I fratelli McOheron, Harold e Raymond. Vecchi che si avvicinano a una vecchia casa alla fine dell’estate. Attraversarono il vialetto sterrato, superarono il furgone e l’automobile parcheggiata accanto alla recinzione in rete metallica e varcarono il cancello uno dopo l’altro. Fregarono la suola degli stivali contro la lama di una sega piantata nel terreno, chiazzato di letame e compatto e lucido tutt’intorno per anni e anni di calpestio, e salirono gli scalini in legno fino alla zanzariera della veranda, poi entrarono in cucina, dove la diciannovenne Victoria Roubideaux, seduta al tavolo in pino, stava dando il porridge alla figlioletta.
Kent Haruf, Crepuscolo
E poi ci fu il giorno in cui Addie Moore fece una telefonata a Louis Waters. Era una sera di maggio, appena prima che facesse buio. Vivevano a un isolato di distanza in Cedar Street, nella parte più vecchia della città, olmi e bagolari e un solo acero cresciuti sul ciglio della strada e prati verdi che si stendevano dal marciapiede fino alle case a due piani. Era stata una giornata tiepida, ma di sera aveva rinfrescato. Dopo aver camminato sotto gli alberi, la donna svoltò all’altezza della casa di Louis.
Kent Haruf, Le nostre anime di notte
Robert Cohn era stato un tempo campione di pugilato di Princeton, categoria dei pesi medi. Non crediate che questo, come titolo pugilistico, a me faccia una grande impressione, ma per Cohn significava molto. Non gli importava niente della boxe, anzi la detestava, ma l’aveva imparata, con fatica e sino in fondo, per reagire a quel senso di inferiorità e di insicurezza che gli derivava a Princeton dall’essere trattato come un ebreo. Traeva insomma una certa gioia intima dalla consapevolezza di poter mettere fuori combattimento chiunque avesse fatto lo spocchioso con lui, ma, essendo un ragazzo molto timido e assolutamente perbene, non si batté mai se non in palestra.
Ernest Hemingway, Fiesta
Il mento poggiato sulle braccia incrociate, l’uomo era disteso sulla terra bruna del bosco coperta d’aghi di pino. Sulla sua testa il vento investiva, fischiando, le cime degli alberi. In quel punto il versante del monte si addolciva ma un poco più in giù precipitava rapido, e l’uomo poteva vedere la traccia nera della strada incatramata che, serpeggiando, attraversava il valico. Parallelo alla strada correva un torrente e giù, sulla sponda del valico, l’uomo vedeva una ruota idraulica e l’acqua scrosciante della chiusa, bianca sotto il sole estivo.
Ernest Hemingway, Per chi suona la campana
A quel tempo volevamo soltanto le cose più semplici: mangiare del buon cibo, dormire sereni la notte, sorridere, ridere, sentirci bene. Ci sembrava di averne diritto, noi come chiunque altro. Certo, se ci penso adesso, capisco quanto sia stata ingenua. Ero accecata da un moto di speranza e dalla promessa del possibile, convinta che nelle nostre vite non fosse rimasto più nulla in grado di andare storto.
Cristina Henríquez, Anche noi l’America
Davanti all’arco d’ingresso, retto da colonnette gemelle, del convento di Mariabronn, sul margine della strada c’era un castagno, un solitario figlio del Sud, che un pellegrino aveva riportato da Roma in tempi lontani, un nobile castagno dal tronco vigoroso; la cerchia de’ suoi rami si chinava dolcemente sopra la strada, respirava libera ed ampia nel vento; in primavera, quando intorno tutto era già verde ed anche i noci del monastero mettevano già le loro foglioline rossicce, esso faceva attendere ancora a lungo le sue fronde, poi quando le notti eran più brevi, irradiava di tra il fogliame la sua fioritura esotica, d’un verde bianchiccio e languido, dal profumo aspro e intenso, pieno di richiami, quasi opprimente; e in ottobre, quando l’altra frutta era già raccolta ed il vino nei tini, lasciava cadere al vento d’autunno i frutti spinosi dalla corona ingiallita: non tutti gli anni maturavano; per essi s’azzuffavano i ragazzi del convento, e il sottopriore Gregorio, oriundo del mezzodí, li arrostiva in camera sua sul fuoco del camino.
Hermann Hesse, Narciso e Boccadoro
Sono diventato la persona che sono oggi all’età di 12 anni, in una gelida giornata invernale del 1975. Ricordo il momento preciso: ero accovacciato dietro un muro di argilla mezzo diroccato e sbirciavo di nascosto nel vicolo lungo il torrente ghiacciato. È stato tanto tempo fa. Ma non è vero, come dicono molti, che si può seppellire il passato. Il passato si aggrappa con i suoi artigli al presente. Sono ventisei anni che sbircio di nascosto in quel vicolo deserto. Oggi me ne rendo conto.
Khaled Hosseini, Il cacciatore di aquiloni
C’era una nebbia fittissima, quando sono uscito per avventurarmi nella città vuota e ovattata e andare alla camera ardente. È così che chiamano il crematorio ora. L’avviso diceva che dovevo presentarmi alle nove. La mia cremazione era fissata per le nove e mezza. La notte c’era stato un gran baccano, un boato dietro l’altro, come se i palazzi si accasciassero stremati. Sono rimasto nel dormiveglia con quel frastuono di sottofondo, che si è spento nell’attimo esatto in cui ho aperto la porta stamattina, come se avessi premuto io l’interruttore. È stato allora che ho notato l’avviso di cremazione con i caratteri sbavati dall’umidità; era accanto ad altri due appesi lì da più di dieci giorni, le bollette della luce e dell’acqua.
Yu Hua, Il settimo giorno
Pregavo soltanto di non rimanere in panne di notte in piena taiga e di non incappare nei banditi. Alla prima di queste disgrazie ero preparato, alla seconda: no. Probabilmente ero l’unico matto che viaggiava non armato, e oltretutto in solitaria, attraverso quello spaventoso oceano di terraferma. Lo sport prediletto dagli abitanti del posto è il tiro a segno. Guidano normalmente, cioè tenendosi sul lato destro della carreggiata, ma siccome girano su macchine giapponesi, hanno sulla destra anche il volante. Lo impugnano con la sinistra, in modo da poter allungare agevolmente il braccio destro fuori dal finestrino e scaricare raffiche di colpi contro cartelli stradali, manifesti pubblicitari e targhe informative, senza neppure prendersi la briga di rallentare. Nella Siberia orientale non vidi un solo segnale stradale che non fosse bucherellato come uno scolapasta. Si riconoscono proiettili di piccolo e grosso calibro, spari singoli e lunghe sventagliate, talvolta squarci enormi da cannoni a pallini.
Jacek Hugo-Bader, Febbre bianca
«Hai avuto paura?» «Nient’affatto. Dopo tutto sto morendo». Scoppio a ridere come uno scemo ma lui non si offende perché parecchie persone reagiscono così allo stress. A me a volte capita. Per giustificarmi aggiungo che in quel momento mi era tornata in mente una barzelletta ceca, ma anche polacca su Pepik Vondráček, il quale, quando il discorso cadeva sui comunisti, diceva: “Io non c’ho mica paura, c’ho il cancro”. Ma il cuore di Ivan Ivanovič è gravemente ammalato e la fine è vicina, vuol dire che gli rimangono poche settimane o forse qualche mese di vita. Così dicono i medici. Sta morendo, e perciò era stato l’unico a non aver paura e, così come me, non si è sbronzato, al contrario dei nostri compagni. Non sapevo che avrei dovuto averne, di paura, che avevo davanti i sette minuti peggiori della mia vita, che avrei avuto ancora più paura del giorno in cui, al tempo della Prima guerra cecena, i russi presero la città di Šali e io non feci in tempo a tagliare la corda coi civili.
Jacek Hugo-Bader, I diari della Kolyma
L’idea originaria non prevedeva una notte in bianco, ma di uscire dal Gran Duc verso mezzanotte e concedersi qualche ora di sonno alla Gare du Nord prima di prendere il treno per tornare a Tolosa. Ma ecco che – uno sguardo all’orologio – sono quasi le sei del mattino. È Montmartre a fargli quest’effetto. I jazz club, i cabaret, la calca di parigini giovani e ribelli che non si lasciano scoraggiare da nulla, neppure dalla guerra incombente, tutto questo lo inebria. Finisce il cognac e si alza, tentato da un ultimo numero; ci sarà di sicuro un altro treno che parte più tardi. Poi però ripensa alla lettera chiusa nella tasca del soprabito, e gli manca il fiato. Deve proprio andare. Prende soprabito, sciarpa e berretto, rivolge un adieu ai compari e si fa largo tra la decina di tavolini del locale ancora mezzo pieno di avventori che fumano Gitanes e ondeggiano al ritmo di Time on my hands di Billie Holiday. Non appena la porta si richiude alle sue spalle, Addy fa un respiro profondo, gustando l’aria frizzantina che gli rinfresca i polmoni. La brina su rue Pigalle comincia a squagliarsi e il selciato luccica in un caleidoscopio di grigi sotto il cielo del tardo inverno.
Georgia Hunter, Noi, i salvati
Una voce dell’Est Europa cerca di darci una sequela di informazioni rassicuranti. O almeno questa dovrebbe essere la sua funzione. Peccato che la sua intonazione evochi un irreprensibile serial killer. La litania si effonde dagli altoparlanti del boeing in cui siamo accomodati e che ci porterà a Praga in meno di due ore. Magia della tecnologia. Il destino ha deciso di organizzarmi uno scherzetto impeccabile: sono seduto accanto alla emergency exit. E sebbene il mio inglese possa essere definito propriamente come “maccheronico”, possiedo le conoscenze teoriche per tradurre il messaggio pratico. L’esistenza di una emergency exit segnala, senza reticenze, che il velivolo può esplodere. Andare in fiamme. Precipitare. Insomma, quella porta di emergenza mi ricorda che una catastrofe è sempre un’eventualità da non escludere; per quanto remota è comunque possibile, pronta a essere narrata con lacrimoso pathos-patetico da TG, giornali, blog, con immediata diffusione di informazioni riguardo alla rarità dei disastri aerei e con il commento dell’esperto di turno, felice di consumare il suo minuto di celebrità sugli schermi televisivi. Terrorizzare con le cifre e tranquillizzare con le chiacchiere. Colpire e curare.
Stefano Iannaccone, Storia di un amore all’anatra
Non ricordo il 15 ottobre 1969. Non posso ricordarlo, anche se c’è chi sostiene di ricordare la propria nascita. È probabile che nella pancia di mia madre fossi nella giusta posizione, perché il parto fu naturale. Non troppo lungo né breve, con le contrazioni che alla fine si ripetevano ogni cinque minuti. Mia madre partorì all’età di venticinque anni, quindi giovane e in salute, anche se non del tutto in realtà, come si capì in seguito. Ricordo, però, o forse l’immagino, la placida e dorata quiete di ottobre alternarsi ai presentimenti del lungo periodo di oscurità. Un mese di confine, almeno a queste latitudini, dove le stagioni si avvicendano e l’autunno a poco a poco si trasforma in inverno.
Nora Ikstena, Il latte della madre
Appare sempre più probabile che riuscirò davvero ad intraprendere la spedizione che da alcuni giorni ormai tiene completamente occupata la mia fantasia. Spedizione, vorrei aggiungere, che intraprenderò da solo nella comodità della Ford di Mr Farraday; e che, a quanto prevedo, attraverso gran parte della più bella campagna inglese, mi condurrà fino alla costa occidentale del paese e riuscirà a tenermi lontano da Darlington Hall per cinque o sei giorni almeno. L’idea di un simile viaggio era nata, mi preme sottolinearlo, da una proposta delle più cortesi avanzatami da Mr Farraday in persona un pomeriggio di quasi due settimane orsono mentre spolveravo i ritratti in biblioteca.
Kazuo Ishiguro, Quel che resta del giorno
Volge le spalle agli alberi bassi del bosco artificiale e guarda giù dalla montagna, verso il villaggio, che è azzurro nella notte d’agosto, e le pecore, simili a pietre nell’erba mossa dal vento. Più in là dorme il mare. Il fiordo di Vág è calmo, l’azzurro si confonde con quello del cielo sull’orizzonte dritto, teso tra le terre emerse, un filo su cui possono camminare solo creature mitiche e fantasmi. Chiude gli occhi. Con tutta la sua giovane volontà segue la strada azzurra: supera le isole Shetland e i massicci montuosi della Norvegia, attraversa il Kattegat e s’inoltra nel paese piatto, il paese del burro, dei campi e delle fattorie, fino alla cittadina dello Sjælland dove Fritz, ora starà dormendo come un sasso. Marita, si chiama. Presto si metterà in viaggio e questo è il punto di partenza: Suðuroy, la più meridionale delle isole Faroe. Qui i fiordi sono profondi e le montagne impervie. Il paesaggio è più scabro e ripido che nel posto dove è nata, l’isola di Vágar, ma è il primo che s’incontra arrivando dal resto del mondo. Nel paese in cui è diretta c’è una ferrovia. Marita immagina i binari che tagliano la terra abitata come un fiume. Le persone trascinate dalla corrente. Prendere un treno. Si può scendere dove si vuole. In una città, forse. In un’altra città. In un bosco.
Siri Ranva Hjelm Jacobsen, Isola


Jonna aveva la felice caratteristica di svegliarsi ogni mattina come a una nuova vita, che lei si stendeva davanti bianca e immacolata fino a sera, senza quasi mai neanche l’ombra degli errori e delle preoccupazioni del giorno prima. Un’altra sua prerogativa, o meglio dono, altrettanto sorprendente era il profluvio di idee sempre inattese e indipendenti che prosperavano e prendevano energicamente forma per un po’, finché non venivano spazzate via di colpo da un nuovo stimolo che reclamava il suo incontenibile spazio.
Tove Jansson, Fair play
Nella primavera del 1943 la principessa di via Gundulić, il numero civico non è più importante, mise in moto una malia per diventare invisibile, ma non si sa con l’aiuto di chi o di quale dio. Erano tempi così, tempi in cui le principesse non potevano aspirare ad altro se non all’invisibilità. Non bisogna nemmeno dire quanta superbia ci volesse per un simile desiderio! I soffitti erano alti quattro metri e annuvolati dal fumo di tabacco. Il papà fumava prima che lo portassero in viaggio. La mamma fumava prima che la portassero in viaggio. Fumava anche il nonno ma lui non fu portato via, perché morì prima del viaggio. Ruta Tannenbaum aveva quindici anni e nessuna colpa per i soffitti nuvolosi. Ma sentiva come di aver vissuto sempre sola sotto quei soffitti, ed era terribilmente spaventata, così che si era messa in testa di diventare invisibile. Ahimè com’era superba! Quando vennero per portarla in viaggio, di Ruta Tannenbaum era rimasto solo il suo piede destro. Ogni altra cosa era diventata invisibile. Ma anche questo non è poco, anzi, dissero quelli dell’agenzia turistica, e portarono il piede destro di Ruta Tannenbaum fino allo scalo merci della ferrovia. Sotto il bianco abito della principessa camminava un bianco piede, piccolo e scalzo.
Miljenko Jergović, Ruta Tannenbaum
Ci sono due tipi di persone al mondo, quelli che se ne vanno di casa e quelli che non lo fanno. Io sono orgoglioso di appartenere alla prima categoria. Mia moglie, Celestial, diceva sempre che in fondo sono un ragazzo di campagna, ma questa definizione non mi è mai piaciuta. Intanto non vengo dalla campagna vera e propria. Eloe è una piccola città della Louisiana. Quando senti parlare di campagna pensi ai campi coltivati, alle balle di fieno, alla mungitura delle vacche. In vita mia non ho mai raccolto nemmeno una capsula di cotone, anche se mio padre l’ha fatto. Non ho mai toccato un cavallo, una capra o un maiale, e non ho nessuna voglia di provarci. Celestial rideva sempre e puntualizzava che non mi stava dando del contadino, ma solo del campagnolo. Lei è di Atlanta e si potrebbe sostenere che è campagnola pure lei. Ma lei si definisce una «donna del Sud», da non confondersi con una «bellezza del Sud». Però le va bene farsi chiamare «Miss Georgia», e va bene anche a me, quindi a posto così.
Tayari Jones, Un matrimonio americano
Nell’aprile del 1994 mio fratello ci avvisò da Tirana che nostra madre stava rendendo l’anima. Mia moglie Helena e io partimmo con il primo aereo da Parigi, sperando di trovarla ancora in vita. La trovammo ancora viva, ma in coma. Si trovava nell’appartamento di mia zia in via Qemal Stafa, dove l’avevano portata alcune settimane prima, per accudirla nel migliore dei modi. Mio cugino di primo grado, Besnik Dobi, colui che l’aveva portata in braccio fino a casa di sua sorella, dopo avermi spiegato perché avevano scelto questo metodo di trasporto per coprire la distanza tra via Dibra all’inizio di via Qemal Stafa, aggiunse queste parole: perché era leggera. Cercando di spiegarsi meglio ripeté quasi la stessa cosa: incredibile quanto fosse leggera! Come se fosse di carta. Come una bambola di carta.
Ismail Kadare, La Bambola
Dovevano essere le dieci di sera (in seguito, avrebbe ricordato spesso quell’istante, senza poter dire se la sua convinzione che quell’ora costituisse uno di quei momenti inoffensivi dove nulla comincia o si conclude, giacché tutto ciò che ha conseguenze – naturalmente maligne, non benigne – è già avvenuto o aspetta un’ora più tarda; in seguito, dunque, rammentando quell’episodio, non avrebbe saputo dire se quel convincimento fosse stato accompagnato subito da un sordo monito – Attento! – o se questa fosse un’impressione successiva, dopo che una moltitudine di cose ebbero cambiato posto nella sua mente). Era una notte banale, di una sobria oscurità, con, ai suoi margini, un chiarore diffuso distillato dalle stelle, una notte tale che perfino il monito Attento! – qualora fosse stato effettivamente proferito come uscendo dai suoi strati più densi – non avrebbe prodotto l’effetto scontato.
Ismail Kadare, L’aquila
La prima volta che incontrai Dean fu poco tempo dopo che mia moglie e io ci separammo. Avevo appena superato una seria malattia della quale non mi prenderò la briga di parlare, sennonché ebbe qualcosa a che fare con la triste e penosa rottura e con la sensazione da parte mia che tutto fosse morto. Con l’arrivo di Dean Moriarty ebbe inizio quella parte della mia vita che si potrebbe chiamare la mia vita lungo la strada.
Jack Kerouac, Sulla strada
L’odore del vecchio armadio mi ha fatto venire la smania di aprire ante e cassetti, di mettermi a frugare dappertutto alla ricerca delle fotografie che un giorno avevo messo in ordine con grande cura. La fotografia di mia madre, che raccoglie i limoni dall’unica pianta del cortile e ci sono anch’io accanto a lei, con gli occhi luccicanti di gioia, quella di mio padre nella sua uniforme militare, sbarbato di fresco e con lo sguardo fisso sull’obiettivo, e quella di mio fratello Hussam che, tutto sorridente e con il grembiule della scuola, tiene in braccio Humam, il nostro fratellino ancora avvolto in una copertina azzurra. E poi quella fotografia in cui ci sono io nel mio vestito nero, lungo. Il mio viso è contornato dall’ampio velo che mi copre i capelli e ricade sulle spalle. Del mio corpo non si distingue nulla. Sullo sfondo, il quadro di due cacciatori che inseguono con i cani da caccia una gazzella in fuga. Quel quadro era appeso nello studio del fotografo dove mi aveva accompagnato mio padre. Dopo essere entrati, papà rispose alle domande dell’uomo, ma io non capii nulla, ero troppo emozionata.
Khaled Khalifa, Elogio dell’odio
L’idea dell’eterno ritorno è misteriosa e con essa Nietzsche ha messo molti filosofi dell’imbarazzo: pensare che un giorno ogni cosa si ripeterà così come l’abbiamo già vissuta, e che anche questa ripetizione debba ripetersi all’infinito! Che significato ha questo folle mito? Il mito dell’eterno ritorno afferma, per negazione, che la vita che scompare una volta per sempre, che non ritorna, è simile a un’ombra, è priva di peso, è morta già in precedenza, e che, sia stata essa terribile, bella o splendida, quel terrore, quello splendore, quella bellezza non significano nulla. Non occorre tenerne conto, come di una guerra fra due Stati africani del quattordicesimo secolo che non ha cambiato nulla sulla faccia della terra, benché trecentomila negri ci abbiano trovato la morte fra torture indicibili.
Milan Kundera, L’insostenibile leggerezza dell’essere
Forse a questo mondo ci sono persone che riescono a leggere nel pensiero anche senza volerlo, e se esistono persone così è molto probabile che mio marito sia uno di loro. Lo penso per via di quello che successe la settimana in cui io sapevo che presto me ne sarei andata, ma lui non lo sapeva; sapevo che dovevo dirglielo, ma non riuscivo a immaginare un modo plausibile di far pronunciare quelle parole alla mia bocca e siccome mio marito riesce a leggere nel pensiero involontariamente, quella settimana bevve parecchio più del solito, grossi barattoli pieni di gin principalmente, ma anche birre grandi comprate in rosticceria. Arrivava sorseggiando una lattina nascosta in un sacchetto di carta, sorrideva come fosse uno scherzo.
Catherine Lacey, Nessuno scompare davvero
Per quanto vecchio diventasse, Jan Andersson di Skrolycka non potè mai stancarsi di raccontare di quel giorno in cui la sua bimbetta era venuta al mondo. Era uscito presto quel mattino per andare a cercare la levatrice e altra gente che potesse aiutarlo; poi per tutto il resto della mattinata e per un buon tratto del pomeriggio era rimasto a sedere sul ceppo della legnaia, senza aver altro da fare che aspettare. Fuori pioveva a dirotto; e non mancò di prendersi anche lui la sua parte di pioggia, benché si potesse dire che stava seduto al coperto. L’umidità filtrava dalle pareti e le gocce cadevano sopra di lui dal tetto sconnesso; sul più bello, il vento gli rovesciò addosso un intero scroscio attraverso l’apertura senza porta della legnaia.
Selma Lagerlöf, L’imperatore di Portugallia
Polvere sei e polvere tornerai. Martin Brenner ripeté silenziosamente tra sé le parole che sua madre gli aveva chiesto di pronunciare per il suo ultimo viaggio, quello senza destinazione. Non che sarebbe importato molto se anche si fosse sbagliato. Maria se n’era andata, e non c’era nessun cielo da cui potesse starlo ad ascoltare di nascosto. Sara e Cristina, mano nella mano al suo fianco, non avrebbero certo badato a qualche lapsus. Già a nove anni Sara aveva dichiarato di non credere in Dio ma nel Big Bang, e non sembrava aver poi cambiato idea. La Bibbia per ragazzi illustrata che la nonna le aveva regalato per Natale era rimasta intonsa. Cristina, la sua amata moglie, credeva, è vero, in una specie di Dio, ma era più che altro per uso domestico, perché non si può mai sapere, diciamo. Comunque nei quindici anni che avevano vissuto insieme una particolare familiarità con la Bibbia non l’aveva mai lasciata trasparire. Dei tre in effetti era lui, grazie ai suoi occasionali studi di filosofia delle religioni, il più versato nelle sacre scritture. Ma in Dio non credeva. Per lui la fede era come uno di quei salvagenti che si appendono sul bordo della banchina per dare un senso di sicurezza … finché non viene portato via da una mareggiata o buttato in acqua da adolescenti sbronzi un sabato sera. Non c’è nessuna vita dopo questa, fine della storia. Ognuno di noi non ha che una vita da vivere, una sola. Cosa cambiava dunque per Maria che lui esaudisse o meno il suo ultimo desiderio: tornare alla terra da cui proveniva, senza preti e senza lapidi! Aveva chiesto di essere cremata e che le sue ceneri venissero sparse al vento, con lui, Sara e Cristina come unici testimoni.
Björn Larsson, La lettera di Gertrud
Il nostro tempo è essenzialmente tragico, quindi ci rifiutiamo di prenderlo tragicamente. Il cataclisma s’è abbattuto, siamo tra le rovine; cominciamo a ricostruire nuovi piccoli centri di vita, a nutrire nuove piccole speranze. E’ un lavoro piuttosto duro; la strada verso l’avvenire non è agevole: bisogna aggirare gli ostacoli o cercare di scavalcarli.
D.H. Lawrence, L’amante di Lady Chatterley
Il confine estremo dell’Europa. Qui ogni falesia mette a nudo l’osso giallo della pietra e la terra colore ocra o rosseggiante che sembra carne; la pietra si sminuzza sotto gli assalti delle onde, la carne viene erosa dalle maree. L’oceano è talmente immenso da non poterlo abbracciare con lo sguardo; si ha l’impressione che sia sul punto di piombare sull’osservatore e sfondarne le pupille, quasi fossero oblò, per riversarsi all’interno e inondarne la mente. E allora, a mo’ dei picchi vulcanici di Madera e delle isole Canarie, emergeranno dai flutti solo rari pensieri sulla grande attrazione dell’assenza, la vacuità dell’orizzonte; pensieri che esortano a essere trascesi, a sollevare con l’immaginazione dalle acque un nuovo continente, una nuova Atlantide, dove tutto è ignoto e lo spazio non conosce né la bussola né il compasso del cartografo. Qui finisce l’Europa. La riva si riduce, il continente pare rattrappirsi e ci si rende conto per la prima volta come l’Isola-Mondo non sia la trovata romantica di un geopolitico inglese d’inizio secolo scorso. Percepisci il suo confine che coincide con la linea della riva.
Sergej Lebedev, Il confine dell’oblio
Jem, mio fratello, aveva quasi tredici anni all’epoca in cui si ruppe malamente il gomito sinistro. Quando guarì e gli passarono i timori di dover smettere di giocare a football, Jem non ci pensò quasi più. Il braccio sinistro gli era rimasto un po’ più corto del destro; in piedi o camminando, il dorse della sinistra faceva un angolo retto con il corpo, e il pollice stava parallelo alla coscia, ma a Jem non importava un bel nulla: gli bastava poter continuare a giocare, poter passare o prendere la palla al volo. Poi, quando di anni ne furono trascorsi tanti da poterli ormai ricordare e raccontare, ogni tanto si discuteva di com’erano andate le cose, quella volta. Secondo me tutto cominciò a causa degli Ewell, ma Jem, che ha quattro anni più di me, diceva che bisognava risalire molto più indietro, e precisamente all’estate in cui capitò da noi Dill e per primo ci diede l’idea di far uscire di casa Boo Radley.
Harper Lee, Il buio oltre la siepe
Se si fissa a lungo una cosa ben illuminata e poi si chiudono gli occhi, davanti all’occhio interiore si vedrà comparire la stessa identica immagine, una sorta di impronta persistente in cui ciò che in realtà era chiaro appare scuro e ciò che in realtà era scuro appare chiaro. Se ad esempio si segue con lo sguardo un uomo che cammina per strada e che continua a girarsi per fare un ultimo, ultimissimo, ultimissimissimo saluto, e alla fine si chiudono gli occhi, dietro alle palpebre si vedrà il movimento cristallizzato di quell’ultimissimissimo saluto, il sorriso cristallizzato, e i capelli scuri dell’uomo saranno chiari, e gli occhi chiari scurissimi. Se l’oggetto di questa lunga osservazione è qualcosa di significativo, qualcosa – diceva Selma – che con un solo movimento può ribaltare la vita in tutta la sua vastità, allora l’immagine riaffiora di continuo. Anche a distanza di decenni, d’un tratto è di nuovo lì, qualunque cosa stessimo guardando prima di chiudere gli occhi.
Mariana Leky, Quel che si vede da qui

Come scorrere una garza sul passato, una tenda bruciacchiata che sventola alla finestra aperta di quella casa nella primavera dell’86. Un anno marchiato a fuoco dai copertoni fumanti per le strade di Santiago, schiacciata dal pattugliamento. Una Santiago che si svegliava al suono delle pentole sbattute nei cortei, ai lampi del black out, per i cavi elettrici scoperti, esposti alle catene, alle scintille. Poi il buio pesto, le luci di un camion blindato, i Fermo lì stronzo, gli spari e le corse a perdifiato, come nacchere di metallo che frantumavano le notti di feltro. Quelle notti funeree, trafitte dalle grida, dall’incessante “Cadrà”, e da tanti, tanti comunicati dell’ultimo minuto, sussurrati dall’onda sonora del “Diario de Cooperativa”.
Pedro Lemebel, Ho paura torero
E proprio oggi, quando il paese è saltato nel futuro con uno zaino pieno di cadaveri che sgocciola la traccia del suo riconciliato progresso. Quando i giorni di spavento sembrerebbero svaporati e rimane indietro nell’ieri l’aureola mestruata di quel tempo. Notti di irruzioni, mattine con camion verde oliva alla porta, in attesa di passeggeri destinati al confino. Verso il Sud, fino a un’isola sperduta sulla carta geografica. Verso il Nord, fino a qualche sezione delle miniere di salnitro trasformata in campo di concentramento. E lì, nel momento di abbandonare il passato, la vita familiare e la casa, con la soldataglia che obbligava a partire, con i militi, mitragliette in mano, che spintonavano gli arrestati, i quali, isterici, non sapevano cosa buttare nella valigia dell’esilio.
Pedro Lemebel, Le esequie della carogna
E da quaggiù, dall’altra parte del mondo, dove l’estate finlandese fa tremare le mie pallide e fragili ossa cilene. In questo paradiso di albini, uno non riesce proprio a godersi un sano relax turistico mentre solca i canali verde scuro su lance e barchette bianche dondolate dalla tormenta polare. Sì, perché qui anche i poveri hanno la barca, mi dice una ispano-americanista finlandese che ha sposato un cileno esiliato. Ed è chiaro che solo il cileno ha fatto centro, assicurandosi i privilegi di quel matrimonio con la bionda impietosita da come allora ce la passavamo male noi cileni.
Pedro Lemebel, Parlami d’amore
Quando l’anno 1900 arrivò trionfalmente a inaugurare il nuovo secolo fra luminarie e simboliche danze, Amos Segre si trovò a fare una solenne promessa a sé stesso. Al compimento dei trent’anni, non un minuto dopo, avrebbe dovuto assolutamente vedere già realizzati due sogni fondamentali. Primo, una ricchezza solida e riconoscibile. Secondo, una moglie con cui dividere una dimora degna di tanta conquista.
Lia Levi, La sposa gentile
Argon. Ci sono, nell’aria che respiriamo, i cosiddetti gas inerti. Portano curiosi nomi greci di derivazione dotta, che significano “il Nuovo”, “il Nascosto”, “l’Inoperoso”, “lo Straniero”. Sono, appunto, talmente inerti, talmente paghi della loro condizione, che non interferiscono in alcuna reazione chimica, non si combinano con alcun altro elemento, e proprio per questo motivo sono passati inosservati per secoli: solo nel 1962 un chimico di buona volontà, dopo lunghi ed ingegnosi sforzi, è riuscito a costringere lo Straniero (lo xenon) a combinarsi fugacemente con l’avidissimo, vivacissimo fluoro, e l’impresa è apparsa talmente straordinaria che gli è stato conferito il premio Nobel.
Primo Levi, Il sistema periodico
Il giorno del mio ritorno, trovo riparo accanto a un vecchio congelatore, vicino a un cespuglio di ortiche, e guardo le nuvole avanzare sul mare. Il fragore delle onde non è molto diverso dal traffico di Londra. La fattoria si trova sul versante occidentale dell’isola più grande e importante delle Orcadi, alla stessa latitudine di Oslo e San Pietroburgo, separata dal Canada solo da scogliere e oceano. Con il modificarsi delle pratiche agricole si sono aggiunti edifici e macchinari nuovi, ma i capanni e gli attrezzi vecchi sono rimasti qui, a corrodersi nell’aria salmastra. Un escavatore rotto adesso fa da abbeveratoio per le pecore. Le stalle in cui un tempo veniva legato il bestiame sono piene di utensili e mobili defunti che tenevamo in casa. In quel fienile avevo fissato alle travi un’altalena di corda da cui penzolavo a testa in giù, tenendomi con le gambe, sopra un cancello che adesso è per terra ad arrugginire.
Amy Liptrot, Nelle isole estreme
Per molto tempo ho fatto finta che mia madre fosse ancora viva. E adesso mi sforzo di ristabilire la verità nella speranza di liberarmi di una bugia che finora non è servita ad altro che a ritardare il lutto. Ho ancora sulla faccia la cicatrice della sua scomparsa e, anche se di solito cerco di coprirla con uno strato di allegria artificiale, quella riaffiora ogniqualvolta la mia fragorosa risata si interrompe, e in mezzo ai miei pensieri si leva la sagoma di questa donna che non ho visto invecchiare, che non ho visto morire e che, nei miei sogni più tormentati, mi volta le spalle per nascondermi le lacrime. In qualsiasi parte del mondo mi trovi, non appena sento un gatto miagolare nella notte o un concerto di cani in calore, alzo la testa al cielo e ripenso a una leggenda della mia infanzia, la leggenda della vecchia che ci sembrava di intravedere dentro la luna e che portava sempre una pesante gerla sulla testa.
Alain Mabanckou, Le luci di Pointe-Noire
Nessuno dei presenti quel giorno al cimitero riuscì a capire perché Abdel Nasser si fosse comportato in quel modo così violento. Neppure il fatto di essere sconvolto per la morte di hajj Mahmud sembrava una giustificazione sufficiente. La sensazione generale era quella del fuoco sotto la cenere. Che fine avevano fatto la signorilità di hajj Mahmud, l’eleganza della sua jubba e del suo fez, o del suo completo con tanto di cravatta e cappello a bombetta, se paragonate all’aria trasandata di suo figlio Abdel Nasser in jeans e giacca da operaio, con i capelli in disordine e la barba incolta? Persino l’avvenenza del ragazzo, che racchiudeva in sé il fascino delle origini andaluse di sua madre e sua nonna e l’alterigia della bellezza turca di suo padre e suo nonno, si era dissolta in quel suo aspetto che lo faceva assomigliare agli scaricatori di porto e ai malavitosi del quartiere, i quali non avevano ricevuto un briciolo d’istruzione neanche per sbaglio.
Shukri al-Mabkhout, L’italiano
Un ragazzo ho mandato alla camera a gas di Huntsville. Uno e soltanto uno. Su mio arresto e mia testimonianza. Sono andato a trovarlo due o tre volte. Tre volte. L’ultima volta il giorno dell’esecuzione. Non ero tenuto ad andarci, ma ci sono andato lo stesso. E non avevo certo voglia. Aveva ammazzato una ragazzina di quattordici anni e posso dirvi subito che non ho mai avuto questa gran voglia di andarlo a trovare né tantomeno di assistere all’esecuzione però ci sono andato lo stesso. I giornali scrissero che era un crimine passionale e lui mi disse che la passione non c’entrava niente. Lui con quella ragazzina ci usciva insieme, anche se era così piccola. Il ragazzo aveva diciannove anni. E mi disse che da quando si ricordava aveva sempre avuto in mente di ammazzare qualcuno.
Cormac Mc Carthy, Non è un paese per vecchi
Quando si svegliava in mezzo ai boschi nel buio e nel freddo della notte allungava la mano per toccare il bambino che gli dormiva accanto. Notti più buie del buio e giorni uno più grigio di quello appena passato. Come l’inizio di un freddo glaucoma che offuscava il mondo. La sua mano si alzava e si abbassava a ogni prezioso respiro. Si tolse di dosso il telo di plastica, si tirò su avvolto nei vestiti e nelle coperte puzzolenti e guardò verso est in cerca di luce ma non ce n’era. Nel sogno da cui si era svegliato vagava in una caverna con il bambino che lo guidava tenendolo per mano. Il fascio di luce della torcia danzava sulle pareti umide piene di concrezioni calcaree. Come viandanti di una favola inghiottiti e persi nelle viscere di una bestia di granito.
Cormac Mc Carthy, La strada
Da quando hanno tagliato il carruggio, il marciapiede è un insulto al pedone: due palmi scarsi di pietra sbeccata e cemento, che al passaggio di una macchina Leo deve tirare in dentro la pancia. Trascorre i pomeriggi sulla curva, ogni tanto si porta alle labbra la piccola batteria che tiene in tasca e allunga il collo per vedere se spunta qualcosa, un ciclista con la bici da corsa, il collo rosso, la faccia da piemontese, la 600 multipla col disegnino dei biscotti, un Motom, motocarri pieni di sabbia. Non è una valle dalla quale si va da qualche altra parte e di solito chi sale dopo un po’ ripassa. Le batterie sono quelle della radio di Sagoma, il barbiere, e una volta usate Leo se le fa dare per buttarle nella spazzatura assieme al secchio dei capelli tagliati. Però le batterie non le getta e, se ce n’è una che non è del tutto scarica, si diverte a passare la lingua sui poli. Quest’anno all’esame di seconda elementare è stato rimandato in italiano. La prova consisteva nell’elencare nomi di frutta, ma la frutta che toglie la sete Leo la sa solo in dialetto. A conoscere i risultati c’è andato con la madre e la maestra è stata chiara. «Sa, signora, il bambino non è ancora passato dal dialetto alla lingua italiana.» Messa così a Leo è parsa una cosa grave, e a volte, quando avvicina i poli della batteria alla lingua per sentirsela come paralizzata, gli viene in mente la questione della lingua italiana. Nel basso carruggio, dopo che all’interno di una finestra al primo piano ha suonato la sigla di chiusura del comunicato radio – il tempo di chiudere la porta e scendere in strada -, i colpetti del bastone sull’asfalto annunciano l’arrivo di Audace.
Marino Magliani, Prima che te lo dicano altri
Erano i primi di novembre e all’alba l’oscurità della notte durava ancora nella via, ma il vento, con meraviglia del negoziante, imperversava già. Gli sbatté con violenza il grembiule in faccia mentre si chinava a raccogliere le due cassette di latte dal bordo del maciapiede. Ansimando, Morris Bober trascinò fino alla porta i pesanti recipienti. Nel vano, un voluminoso sacco marrone pieno di panini di pasta dura e la testa grigia, il volto stizzoso della Poilisheh che se ne stava rannicchiata là ad aspettare di farsene dare uno.
Bernard Malamud, Il commesso
Sull’edizione del giovedì del Riverdale Press c’era un articolo che cominciava con Ieri notte un uomo bianco non identificato è stato travolto da un treno della Metro-North che entrava nella stazione di Riverdale in West 254th Street. L’uomo è morto sul colpo. Il macchinista aveva dichiarato alla polizia che l’uomo era solo e si era buttato sui binari. La polizia aveva rimosso il corpo e cercato i documenti, invano. I 425 passeggeri erano stati trasferiti su un altro treno, che era ripartito con una ventina di minuti di ritardo.
Sarah Manguso, Il salto
Ho iniziato a tenere il diario venticinque anni fa. Ora è di ottocentomila parole. Non volevo perdermi niente, era quello il mio problema. Non potevo affrontare la fine di una giornata senza annotare tutto quello che era successo. Scrivevo di me stessa per non restare lì immobile a rimuginare – per smettere di pensare a quello che accadeva e a cosa farne. Ma soprattutto, scrivevo per poter dire che stavo prestando davvero attenzione. L’esperienza in sè non era sufficiente. Con il diario mi difendevo dalla paura di svegliarmi alla fine della vita accorgendomi che mi era sfuggita. Immaginare la vita senza il diario, anche per una sola settimana, mi gettava nel panico, perchè era come essere morta.
Sarah Manguso, Andanza
In mattinata il generale si soffermò a lungo nella cantina del vigneto. Vi si era recato all’alba insieme al vignaiolo perché due botti del suo vino avevano cominciato a fermentare. Quando finì di imbottigliarlo e fece ritorno a casa, erano già le undici passate. Ai piedi delle colonne, sotto il portico lastricato di pietre umide ricoperte di muffa, lo attendeva il guardiacaccia, che porse una lettera al padrone appena arrivato. “Cosa vuoi?” disse il generale, e si arrestò con aria seccata. Spinse indietro sulla fronte il cappello di paglia a tesa larga che gli ombreggiava il viso arrossato. Da anni ormai non apriva né leggeva lettere. La corrispondenza veniva aperta e selezionata da un impiegato dell’ufficio dell’intendente.
Sandor Marai, Le braci
Anche quella sera i clienti se ne andarono almeno mezz’ora prima della chiusura. Rimanevo solo io nel locale, visto che hernan, il barista, già da qualche minuto era sparito in cucina. Stavano trasmettendo un film con John Travolta e lui non sarebbe stato tanto stupido da perderselo. Terminai la birra e posai la bottiglia sul tavolo, con le altre già svuotate. Le contai. Ero comodamente in doppia cifra e, per dirla tutta, non era il primo bar che visitavo quella sera. Questi non sono record di cui andare fieri, lo so. Ma voglio essere onesto fin da subito. A quel tempo avevo dei problemi con l’alcol. O meglio, i problemi ce li avevo senza l’alcol.
Stefano Marelli, Altre stelle uruguayane
Il sole è appena spuntato, ma siamo in strada già da un po’. Ho un sonno terrificante. Il barile di nescafé trangugiato a occhi chiusi non fa nessun effetto. Sulla panchetta laterale del Land, imbambolato dalla rotta serpeggiante che Miller è costretto a tracciare per evitare di farsi intrappolare dalle dune, rischio di addormentarmi. Vorrei evitarlo, giusto per educazione. Allegra e Miller, davanti, dall’alba di bovidiano: teste rotonde, bubalino, tamacheq, Mori, Monod e Lhote. Vedo che ne sapete quanto me. Tranquilli, è tutta roba relativa a campagne di scavi, pitture e incisioni rupestri, lingua e scrittura tuareg. Inserirmi nella conversazione, neanche per scherzo. Niente da fare, sto per crollare. Oltretutto, qui dietro c’è una puzza di benzina, gasolio, cazzonesò, che pare di stare su un traghetto della Tirrenia. Il serbatoio perde. Sono state le prime parole di Miller ieri, quando è venuto a prendere me e Allegra all’aeroporto di Tozeur. Una cosa da niente.
Stefano Marelli, A dime a dozen


Molti anni dopo, di fronte al plotone di esecuzione, il colonnello Aureliano Buendia si sarebbe ricordato di quel remoto pomeriggio in cui suo padre lo aveva condotto a conoscere il ghiaccio. Macondo era allora un villaggio di venti case di argilla e di canna selvatica costruito sulla riva di un fiume dalle acque diafane che rovinavano per un letto di pietre levigate, bianche ed enormi come uova preistoriche. Il mondo era cosí recente, che molte cose erano prive di nome, e per citarle bisognava indicarle col dito.
Gabriel Garcia Marquez, Cent’anni di solitudine
La zia Leonor aveva l’ombelico più bello che si fosse mai visto. Un piccolo punto affondato proprio al centro del ventre piattissimo. Aveva la schiena lentigginosa e le natiche rotonde e sode, come le brocche da cui beveva l’acqua da bambina. Aveva le spalle dolcemente sollevate, camminava adagio, come su un filo teso. Chi le ha viste racconta che le sue gambe erano lunghe e dorate, che sul pube aveva un ciuffo rossiccio e altero, che era impossibile guardarle i fianchi senza desiderarla tutta.
Angeles Mastretta, Donne dagli occhi grandi
Ci sono volte in cui l’assenza di mio padre mi pesa sul petto come se ci stesse seduto sopra un bambino. Altre volte riesco a malapena a evocare i lineamenti precisi del suo viso e devo tirar fuori le fotografie che conservo in una vecchia busta nel cassetto del comodino. Non c’è stato giorno, dalla sua improvvisa e misteriosa scomparsa, che io non lo abbia cercato, rovistando nei posti più improbabili. Tutto e tutti, lo stesso esistere, sono diventati un’evocazione, una possibilità di somiglianza. Forse è questo che si intende con quella parola breve e ormai quasi arcaica: elegia. Non lo vedo nello specchio ma avverto i suoi aggiustamenti, come se si stesse infilando in una camicia che gli va quasi bene. Mio padre è sempre stato intimamente misterioso, anche quando c’era. Provo a immaginarmi come avrebbe potuto essere avvicinarlo da pari a pari, da amico, ma non ci riesco del tutto.
Hisham Matar, Anatomia di una scomparsa
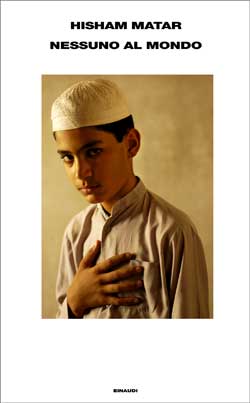
Mi torna in mente l’ultima estate prima che mi mandassero via. Era il 1979 e il sole era dappertutto. Tripoli giaceva immobile e abbagliante nella canicola. Ogni persona, animale o formica vagava alla disperata ricerca d’ombra, quelle occasionali chiazze grigie di misericordia scavate nell’onnipresente biancore. Ma la vera misericordia arrivava solo di notte, una brezza che il vacuo deserto rendeva gelida, che il mare mormorante inumidiva, un’ospite restia e silente che sfilava per le strade vuote, incerta su quanto le fosse concesso vagare nel regno della stella assoluta. Ed ecco che sorgeva, la stella, fedele nei tempi, a scacciare la brezza benedetta. Era quasi mattina.
Hisham Matar, Nessuno al mondo
Farid non ha mai visto il mare, non c’è mai entrato dentro. Lo ha immaginato tante volte. Punteggiato di stelle come il mantello di un pascià. Azzurro come il muro azzurro della città morta. Ha cercato le conchiglie fossili sepolte milioni di anni fa, quando il mare entrava nel deserto. Ha rincorso i pesci lucertola che nuotano sotto la sabbia. Ha visto il lago salato e quello amaro e i dromedari color argento avanzare come logore navi di pirati. Abita in una delle ultime oasi del Sahara.
Margaret Mazzantini, Mare al mattino
Un momento assoluto, quello era stato – il calore e l’odore del bagno attaccati alla pelle, la spugna che l’abbracciava, i piedi nudi dal tappeto raccontavano quanto era soffice il mondo – e per questo non se ne era accorta. In tivù l’indossatrice si stava chinando sul neonato e delle farfalle variopinte gli volavano via dal pannolino; in una luce che esiste solo nella pubblicità e nei congelatori per gelati, il carosello girevole sopra la culla aveva oscillato e luccicato. Lei aveva abbassato la mano e si era aggrappata alla ringhiera. Una monotona melodia preannunciava le ultime notizie. Prese il telecomando e schiacciò il tasto rosso. Si osservò nello schermo spento e sorrise.
Miha Mazzini, I cancellati
Scorrono le dita tra i dischi. Scorrono e lasciano intravedere appena, nello spazio tra unpo e l’altro, un frammento di fotografia o una scritta – sufficienti perché la parte restante della copertina faccia breccia nella mia memoria. Subito la sostituisce una nuova immagine, a volte un pezzo musicale, un riff di chitarra, una frase vocale. «Light all the fires…». Di nuovo. Estraggo il disco e lo fisso. Inghiotto saliva. Mi guardo attorno, nel negozio. I contenitori, colmi di dischi in vinile, e dietro al bancone una mocciosa dal taglio cherokee che appiccica i codici a barre su un mucchio di dischi che qualcuno ha appena lasciato lì.
Miha Mazzini, Il giradischi di Tito
Call me Ishmael. Alcuni anni fa – non importa quanti esattamente – avendo pochi o punti denari in tasca e nulla di particolare che mi interessasse a terra, pensai di darmi alla navigazione e vedere la parte acquea del mondo. E’ un modo che ho io di cacciare la malinconia e di regolare la circolazione.
Herman Melville, Moby Dick
Un maiale che corre! David de Vriend lo vide mentre apriva una finestra del soggiorno per far scivolare un’ultima volta lo sguardo sulla piazza prima di lasciare l’appartamento per sempre. Non era un tipo sentimentale, lui. Aveva abitato lì per sessant’anni, per sessant’anni aveva guardato quella piazza, e adesso era venuta l’ora di voltare pagina. Tutto qui. Era la sua espressione preferita – quando gli chiedevano di raccontare, riferire, riportare qualcosa, metteva insieme due o tre frasi e poi: «Tutto qui». Quell’espressione costituiva per lui la sola sintesi legittima di ogni momento e di ogni capitolo della sua vita. La ditta di traslochi aveva preso le poche carabattole da portare al nuovo indirizzo. Carabattole – parola strana che a lui, però, non faceva nessun effetto. Poi erano arrivati gli uomini dell’impresa di sgomberi per prendersi il resto, avevano staccato, smontato, rimosso tutto, anche i chiodi dai muri, finché l’appartamento non era stato, come si suol dire, «ripulito». Dato che i fornelli e la caffettiera erano ancora lì, de Vriend si era preparato un caffè ed era rimasto a guardare quegli uomini badando solo a non stargli fra i piedi, la tazza ormai vuota da un pezzo sempre in mano, finché non l’aveva lasciata cadere in un sacco della spazzatura. Poi gli uomini se n’erano andati, l’appartamento era vuoto. Ripulito. Tutto qui. Un ultimo sguardo fuori dalla finestra. Di sotto, niente che non conoscesse, e ormai era venuta l’ora di sloggiare, i tempi erano cambiati – e fu a quel punto che vide … incredibile ma vero: per strada c’era un maiale! In Sainte-Catherine, nel cuore di Bruxelles. Veniva probabilmente da Rue de la Brai e ora correva lungo la recinzione del cantiere davanti a casa, de Vriend si sporse dalla finestra e lo vide mentre all’angolo con Rue du Vieux Marché aux Grains svoltava a destra e, dopo aver schivato alcuni passanti, stava per infilarsi sotto un taxi.
Robert Menasse, La capitale
So una filastrocca. La canticchio tra me e me quando la testa comincia a giocarmi strani scherzi. Credo che la cantassimo da bambini saltellando da un rettangolo di gesso all’altro, ma può essere che me la sia inventata o l’abbia soltanto sognata. Certe volte la recito in silenzio, solo muovendo le labbra, altre mi metto a canticchiarla e nemmeno me ne accorgo perché mi ballano in testa i ricordi, no, non dei ricordi qualsiasi, ma quelli dopo la magnifica caduta del Muro, quando siamo, come dire … venuti in contatto. In contatto con tutte quelle auto colorate, con la birra Holsten e lo Jägermeister. All’epoca avevamo quindici anni, la Holsten Pilsener era troppo amara e quindi, almeno nel bere, eravamo conservatori. Leipziger Premium Pils. Costava anche meno perché ce la procuravamo direttamente nel cortile della fabbrica, la Leipziger Premium Brauerei. In genere di notte. Il birrificio era il fulcro del quartiere e della nostra vita. L’origine di notti etiliche nel cimitero di periferia, di infinite orge vandaliche e di balli sui tetti delle macchine nella stagione della Bock, la birra forte.
Clemens Meyer, Eravamo dei grandissimi
Ero Leon Termen prima di diventare il dottor Theremin, e prima di Leon ero Lev Sergeevič. Lo strumento ora noto come theremin avrebbe potuto chiamarsi anche leon, lëva o sergeevič. O clara, in onore della sua più virtuosa musicista. A Pash piaceva termenvox. Gli piaceva la connotazione scientifica di quella parola, gli trasmetteva autorità. A me invece quel nome ha sempre fatto ridere. Termenvox – la voce di Termen. Come se lo strumento riproducesse la mia voce. Come se il soprano vibrante del theremin fosse il canto di uno scienziato di Leningrado. L’idea mi faceva ridere, eppure in un certo senso ci credevo anch’io. Non al fatto che il theremin emulasse la mia voce, ma che desse voce a qualcosa. All’invisibile. All’etere. Io, Lev Segeevič Termen, portavoce dell’universo.
Sean Michaels, L’eco delle balene
Um Raquba, un puntino sulla carta del Sudan meridionale, ottantamila “abitanti” in questo campo di profughi, vestiti di stracci, mezzi nudi, sfiancati, luogo di morte fra molti altri sulla Terra in questo XX secolo. Qui sono a migliaia ad aspettare non si sa cosa, anche la speranza appare vana. Oggi il medico avrà nuovi medicinali? Domani ci sarà l’acqua, qualcosa da mangiare, si vedrà comparire il camion col telone con sopra un logo colorato, scritto con i segni di una lingua lontana che qui nessuno di quelli che hanno fame sa leggere? Arriverà finalmente la clemenza della natura? Queste le domande che ossessionano i rifugiati ammassati nell’accampamento dal colore ocra spento del deserto.
R. Mihaileanu-A. Dugrand, Vai e vivrai
… andare, le diceva. Devo andare. Accadeva così, all’improvviso, durante l’ora della passeggiata. Lo diceva col suo tono dolce ma irremovibile, come se fosse un sussurro. Devo andare. La suora la guardava severa. Poi, come sempre, le faceva un sorriso e la seguiva con gli occhi mentre si allontanava via veloce. Si era ormai abituata a vedere quella sagoma correre ogni volta verso il mare come una bambina. Raggiunta la riva si tirava su la gonna ed entrava in acqua, rimanendo lì ad annusare l’aria, con il vento tra i capelli e i piedi a mollo. La suora le andava dietro lenta, e ogni volta pensava che se non fosse stata per l’ombra che proiettava se la sarebbe persa di sicuro, perché lei era fatta della stessa materia di quel mare. Era acqua nell’acqua, schiuma nella schiuma, come se fosse un’onda caduta un po’ troppo in là. Quando la ragazza trovava quello che stava aspettando, si chinava, la apriva e ne tirava fuori il messaggio.La suora non riusciva a spiegarsi il perché, ma la ragazza sapeva che sarebbe arrivata proprio lì, proprio in quel giorno. Lo sapeva ancora prima che arrivasse, quando diceva Devo andare, col suo tono dolce ma irremovibile, come se fosse un sussurro. Devo andare.
Peppe Millanta, Vinpeel degli orizzonti
Pilastri e pareti portanti si spezzarono in due bruscamente; un frastuono assordante in cui si mescolavano lo scricchiolio di travi e montanti, lo schianto di scale, soffitti, tramezzi e volte, vetri in frantumi, mattoni, tegole e piastrelle sbriciolate, rimbombò lungo baixada de la Ferradura mentre la casa crollava senza scampo. Subito una nuvola di polvere, la prima di quelle che avrebbero accompagnato la lunga agonia che aveva inizio allora, si sollevò sull’abitato e si sfilacciò a poco a poco nell’aria tersa del mattino primaverile.
Jesús Moncada, Il testamento dei fiumi
Le prime avvisaglie dell’autunno spingono Adelmo Farandola a scendere in paese per fare provviste. La mattina, uscendo dalla baita, vede attorno alla malga l’erba dei prati intrisa di brina che stenta a sciogliersi. Venti gelidi insistono lungo il vallone, si insinuano fin tra le pareti della baita, sembrano battere alla porta, di giorno e di notte. Le nuvole si ingrossano, gravano sulle cose, e niente le sfilaccia più dalle pareti di roccia.
Claudio Morandini, Neve, cane, piede
Oggi li invidiamo i nostri vecchi, che fino a mezzo secolo fa andavano e venivano giusto una volta l’anno tra Sostigno, il villaggio a valle, e Testagno, il villaggio a monte, e d’estate erano su, tra i pascoli più alti, quelli sotto le cime, gli ultimi con l’erba buona, mentre d’inverno stavano in basso, nelle case vicino al fiume, tra i campi e i sassi della piana. Una volta era così, la sera i più vecchi lo raccontano fino alla noia, e pure noi ci ricordiamo di quando eravamo bambini e la vita era più semplice e priva di ambiguità, sei mesi su, sei mesi giù. Ma cos’è successo poi? Ce lo chiediamo un po’ tutti, la sera, fino alla noia, e proviamo a tornare indietro nel tempo con il pensiero per vedere se troviamo il punto esatto in cui la bella, facile linearità della vita di una volta si è ingarbugliata e tutto è diventato instabile.
Claudio Morandini, Le pietre


Un giorno di gennaio dell’anno 1941, un soldato tedesco di passaggio, godendo di un pomeriggio di libertà, si trovava, solo, a girovagare nel quartiere di San Lorenzo, a Roma. Erano circa le due del dopopranzo, e a quell’ora, come d’uso, poca gente circolava per le strade. Nessuno dei passanti, poi, guardava il soldato, perché i Tedeschi, pure se camerati degli Italiani nella corrente guerra mondiale, non erano popolari in certe periferie proletarie. Né il soldato si distingueva dagli altri della sua serie: alto, biondino, col solito portamento di fanatismo disciplinare, e, specie nella posizione del berretto, una conforme dichiarazione provocatoria.
Elsa Morante, La storia
Entrò Carla; aveva indossato un vestitino di lanetta marrone con la gonna così corta, che bastò quel movimento di chiudere l’uscio per fargliela salire di un buon palmo sopra le pieghe lente che le facevano le calze intorno alle gambe; ma ella non se ne accorse e si avanzò con precauzione guardando misteriosamente davanti a sé, dinoccolata e malsicura; una sola lampada era accesa e illuminava le ginocchia di Leo seduto sul divano; un’oscurità grigia avvolgeva il resto del salotto.
Alberto Moravia, Gli indifferenti
-E così il denaro sei riuscito a trovarlo? – chiede il ragazzo chiamato Corvo. Il modo di parlare è il solito, un po’ strascicato. Come di uno che si è appena svegliato dopo una lunga dormita e ha i muscoli della bocca ancora intorpiditi. Ma il suo è solo un atteggiamento: in realtà è perfettamente sveglio. Come sempre.
Haruki Murakami , Kafka sulla spiaggia
Da qualche tempo accarezzo l’idea di raccogliere alcuni episodi della vita di Abdul Bashur, amico e complice del Gabbiere per buona parte della sua vita, e protagonista, in ruoli niente affatto secondari, di molte delle imprese in cui Maqroll era solito compromettersi con una facilità sospetta. In molte di esse Bashur svolse il ruolo del salvatore, aiutando Maqroll nei momenti critici, grazie a quella astuta pazienza che costituisce uno dei tratti predominanti del carattere levantino. Ora ho deciso di intraprendere questo compito di cronista, che stavo rimandando all’infinito. Lo spunto per farlo nacque da un avvenimento caratteristico delle vicissitudini e delle sorprese che hanno popolato l’esistenza del Gabbiere.
Álvaro Mutis, Abdul Bashur, sognatore di navi
Che pesante, pensavano i parigini. L’aria di primavera. Una notte di guerra, l’allarme. Ma la notte se ne va, la guerra è lontana. Quelli che non dormivano, i malati accoccolati nei loro letti, le madri con i figli al fronte, le donne innamorate con gli occhi pesti per il pianto, sentivano il primo sibilo della sirena. Era ancora soltanto un respiro profondo simile al sospiro che esce da un petto oppresso. Trascorsi pochi istanti, il cielo intero si sarebbe riempito di clamori. Giungevano da lontano, dall’orizzonte estremo, senza fretta si sarebbe detto!
Irene Nemirovsky, Suite francese
Guardare un neonato mentre dorme significa contemplare la fragilità dell’essere umano. Sentire il suo respiro delicato e armonioso suscita un misto di calma e di sgomento. Osservo il neonato che ho davanti a me, la faccia distesa e polposa, il filo di latte che scorre da un angolo delle labbra, le palpebre perfette, e penso che ogni giorno uno dei bambini che dormono in tutte le culle del mondo smette di esistere. Si spegne senza fare rumore come una stella persa nell’universo, tra migliaia di altre che continuano a illuminare l’oscurità della notte, senza che la sua morte sconvolga nessuno eccetto i suoi parenti più stretti. Sua madre rimane sconsolata per tutta la vita, a volte anche suo padre. Gli altri lo accettano con una rassegnazione stupefacente. La morte di un bambino appena nato è una cosa talmente comune che non sorprende nessuno, ma come si può accettare quando si è toccati dalla bellezza di quell’essere intatto? Vedo questo neonato che dorme avvolto nella sua tutina verde, con il corpo completamente rilassato, la testa di lato sul piccolo guanciale bianco, e desidero che rimanga vivo, che nulla perturbi il suo sonno e neanche la sua vita, che tutti i pericoli del mondo stiano lontani da lui, e che il vento impetuoso delle catastrofi lo ignori nel suo passaggio distruttivo.
Guadalupe Nettel, La figlia unica

È stata un’idea di Amichai. Aveva sempre idee del genere, anche se ufficialmente fra noi il creativo era Ofir. Ofir però sprecava tutta la sua inventiva nelle agenzie di pubblicità, per vendere banche e patatine, perciò quando la compagnia si riuniva ne approfittava per essere banale; spesso taceva, parlava poco, con le parole semplici che ancora si usano a Haifa. Ogni tanto, se aveva alzato un po’ il gomito, ci abbracciava tutti e diceva: che fortuna esserci l’uno per l’altro, non vi rendete conto di che fortuna abbiamo. Amichai, invece, vendeva abbonamenti per Buon Cuore, un servizio medico speciale per cardiopatici, e malgrado di tanto in tanto riuscisse a carpire una storia straordinaria da un cliente, di solito un superstite della Shoah, certo non si poteva dire che il lavoro gli riservasse grandi emozioni. Ogni tanti mesi dichiarava che ormai era fatta, avrebbe mollato Buon Cuore per mettersi a studiare shiatsu, ma succedeva sempre qualcosa che lo cotringeva a rimandare. Una volta gli avevano offerto un bonus. Un’altra macchina. Poi c’era stato il matrimonio con Ilana la piagnona. Dopo di che era stata la volta dei gemelli. Così tutta la vitalità che gli ribolliva dentro, e che difficilmente poteva esprimere durante gli incontri alle case di riposo, o a letto con Ilana, la riversava su di noi, i suoi tre migliori amici, con ogni genere di iniziative solenni, tipo andare insieme alla spiaggia di Golan per festeggiare i dieci anni dalla nostra prima visita al parco acquatico dei divertimenti, o iscriversi a una gara di karaoke dopo essersi allenati per benino nell’esecuzione a cappella di una canzone dei Beatles.
Eshkol Nevo, La simmetria dei desideri
Sono una spia, un dormiente, un fantasma, un uomo con due facce. E un uomo con due menti diverse, anche se questo probabilmente non stupirà nessuno. Non sono un mutante incompreso, saltato fuori da un albo a fumetti o da un film dell’orrore, anche se c’è chi mi ha trattato come se lo fossi. Sono semplicemente in grado di considerare qualunque argomento da due punti di vista antitetici. A volte, per adularmi da solo, mi dico che si tratta di un talento vero e proprio, e benché non valga poi tanto, è anche l’unico talento che possiedo. Altre volte, quando rifletto più a fondo sul fatto di non poter fare a meno di osservare il mondo da questa doppia prospettiva, mi domando se in realtà lo si possa davvero considerare un talento. Dopo tutto, il talento è qualcosa che si sfrutta, e non qualcosa dal quale si viene sfruttati. Il talento che non sei in grado di sfruttare, e dal quale anzi sei posseduto… devo confessare che lo definirei piuttosto un rischio. Ma durante il mese dal quale parte questa mia confessione, il modo in cui vedevo il mondo mi sembrava ancora una virtù più che un pericolo, e spesso è proprio per questo che si finisce nei guai. Il mese in questione era aprile, il mese più crudele. Il mese nel quale una guerra che andava avanti da tempo immemorabile cominciò a perdere i pezzi, come succede regolarmente a tutte le guerre. Un mese fondamentale per gli abitanti della nostra piccola parte di mondo, e irrilevante per quasi tutti gli altri, in qualunque angolo della terra si trovassero. Un mese che segnò sia la fine di una guerra che l’inizio di una… be’, “pace” non è il termine corretto da usare, non crede, mio caro Comandante?
Viet Thanh Nguyen, Il simpatizzante
A qualcuno capitava di diventare famoso, di solito per motivi che le persone sane di mente avrebbero preferito evitare, come essere rapiti e tenuti prigionieri per anni, finire invischiati in uno scandalo sessuale, con le umiliazioni che ne conseguivano, o sopravvivere a un evento che, di norma, sarebbe risultato fatale. Questi sopravvissuti avevano bisogno di qualcuno che li aiutasse a scrivere le loro memorie, e gli agenti finivano sempre per rivolgersi a me. «Se non altro, il tuo nome non appare mai» mi aveva detto mia madre in un’occasione. E quando avevo ribattuto che non mi sarebbe dispiaciuto figurare almeno nei ringraziamenti, aveva aggiunto, «Lascia che ti racconti una storia».
Viet Thanh Nguyen, I rifugiati
Mi sveglio in uno sconfinato silenzio. Il mondo attende di essere creato. L’oscurità e il cielo mi circondano. Resto disteso, gli occhi fissi sull’universo come due pozzi profondi, ma lassù non c’è niente, nemmeno l’aria. Nel silenzio il mio petto è scosso da un tremito, sempre più forte. Gli spasmi si fanno più intensi, qualcosa là dentro sta crescendo e minaccia di evadere. Mi divarica le costole, come le sbarre di una gabbia. Non c’è niente che io possa fare. Solo cedere a questa forza spaventosa, come un bambino che striscia a terra in balìa di un padre infuriato, senza mai sapere dove affonderà il prossimo colpo. Quel bambino sono io. E sono anche il padre. Prima che il mondo assuma la sua forma definitiva m’incammino di buon passo, nel chiarore dell’alba. In spalla ho la mia gerla di corteccia, in mano l’accetta. Mi fermo poco lontano dalla stalla riparandomi dietro gli arbusti al limitare del bosco. Fingo di rassettarmi gli abiti nel caso qualcuno mi vedesse e si insospettisse, slaccio e riallaccio una scarpa, tolgo pidocchi invisibili dal berretto e faccio finta di gettarli in un formicaio. E intanto non perdo mai di vista l’aia. Dalla stufa del pörte si alza il primo fumo del mattino, segno che gli abitanti sono già in piedi.
Mikael Niemi, Cucinare un orso
Nel salone Tattoo da Tryggvi, il banco da lavoro è gremito di vasetti di vetro contenenti inchiostro di vari colori. Il ragazzo vuole sapere come procede la scelta, se pensavo a un motivo personalizzato oppure a qualche simbolo in particolare. Il suo corpo è praticamente tutto un tatuaggio, mi colpisce il disegno di un serpente che gli si snoda sinuoso tutto intorno al collo ed è a sua volta avvoltolato a un teschio nero. Tra i ghirigori d’inchiostro di cui è ricoperto, sull’avambraccio della mano che impugna l’ago come un’arma spicca una gran spirale di triplo filo spinato.
Sa, sono tanti quelli che vengono per nascondere le cicatrici, – dice il tatuatore, parlandomi attraverso lo specchio. Quando si volta, non posso fare a mano di notare che sono gli zoccoli di un cavallo imbizzarrito quelli che gli spuntano fuori dalla parte posteriore della canottiera. Si allunga verso una pila di raccoglitori plastificati, ne prende uno e comincia a sfogliarlo alla ricerca di disegni che potrebbero fare al caso mio.
Auður Ava Ólafsdóttir, Hotel Silence
Fu quando Peter si ammalò che Hortensia prese l’abitudine di camminare. Non all’inizio, ma dopo, quando le sue condizioni si aggravarono e lui fu costretto a letto. Era un mercoledì. Se lo ricordava perché il mercoledì era il giorno libero di Bassey, il cuoco, e in frigorifero c’erano dei medaglioni di agnello in un contenitore ermetico, pronti per essere riscaldati nel forno ventilato e serviti con un contorno di tuberi arrosto spennellati con l’olio d’oliva. Ma non aveva fame. La casa le andava stretta, cosa che sembrava impossibile visto che c’erano sei camere da letto. Eppure era così. «Sto uscendo» aveva gridato Hortensia dalle scale. Secondo gli infermieri, non avrebbe mai dovuto lasciarlo da solo, ma Hortensia disprezzava gli infermieri e le loro opinioni. Non vedeva nemmeno la necessità di bussare alla sua porta per avvertirlo che stava andando via. Si era convinta che l’udito di Peter, a differenza del corpo che si stava deteriorando, fosse intatto. Che fosse in grado di sentire perfino quando era sepolto sotto le coperte, perfino attraverso la porta chiusa di quella che lei chiamava infermeria, di sentire i rumori dal fondo delle scale, di sentire la porta d’ingresso che si chiudeva dietro di lei. Era uscita passando dal cancello pedonale, aveva guardato da una parte e dall’altra di Ketterijn Avenue e aveva svoltato a destra, verso il Koppie.
Yewande Omotoso, La signora della porta accanto

Si alza in piedi nel giardino in cui ha lavorato e guarda in lontananza. Ha avvertito il mutamento del tempo. Un’altra folata di vento, un fremito nell’aria, e gli alti cipressi ondeggiano. Si volta e si incammina su verso la villa, scavalca un basso muretto, mentre sente le prime gocce di pioggia sulle braccia nude. Attraversa la loggia ed entra rapidamente. Percorre la cucina senza fermarsi e sale le scale buie procedendo lungo l’ampio salone in fondo al quale un cuneo di luce fuoriesce da una porta aperta. Entra nella stanza che è un altro giardino con alberi e pergolati dipinti su pareti e soffitto. L’uomo giace sul letto, è esposto alla ventilazione, e al suo ingresso volge lentamente il capo verso la donna.
Michael Ondaatje, Il paziente inglese
E adesso salgo le scale, esco sulla terrazza e sento l’aria secca dell’alba che mi ripulisce la faccia dal dormiveglia dovuto all’alcol e all’ora tarda. Un pipistrello vola sopra le teste dei miei amici, come se li ispezionasse inquieto dall’alto, e scompare di nuovo tra le ombre. È notte, a Madrid, sulla mia terrazza, siamo ubriachi, in quel momento che tanto mi piace, quando le persone discutono senza troppa prudenza, in cui tutti sono più allegri o più tristi di quanto si consentano ogni giorno, senza arrivare a essere violenti nè a scoppiare a piangere o a cantare. La notte (più esattamente l’alba, perchè un filo rosa ricama il cielo laggiù, dall’altra parte di Madrid, oltre la stazione di Atocha, oltre Vallecas, oltre i parallelepipedi allineati su quelli che, da qui, sembrano i confini della città) si è fatta lenta, come le nostre lingue, come le nostre palpebre, tutti i movimenti leggermente rallentati; la mano di Fran che si ravvia i capelli mentre dice: “Non so, amico, non so” probabilmente perchè si è persino già dimenticato di cosa stavamo parlando e gli rimane soltanto quella pena che si trascina giorno dopo giorno, che trapela in ogni battuta o a volte, quando diventa malinconico, pretende che sia dovuta allo stato delle cose e non al lutto per se stesso, per le proprie illusioni defunte, che si porta dietro da tanto tempo.
José Ovejero, L’invenzione dell’amore
Sono le sette di sera e lui è seduto sul balcone di casa, al terzo piano. Guarda il giorno che muore e aspetta: chissà che cosa promette l’ultima luce, che cosa ha in serbo.
Ha davanti il cortile deserto con la sua striscia di erba, qualche oleandro, una panchina e un pergolato di buganvillea abbandonato a se stesso. Il cortile finisce con un muro di pietra su cui si delinea il profilo di una porta successivamente murata. Le pietre nel buco della porta sono più chiare, adesso gli sembrano persino un po’ meno pesanti delle altre. Oltre il muro si ergono due cipressi. Nella luce della sera hanno un colore che è nero, non verde. Oltre si dispiegano colline desolate: laggiù c’è il deserto. Laggiù un mulinello grigio s’alza a tratti, freme un istante, si contorce, corre, cala. Torna in qualche altrove.
Il ciclo ingrigisce. Qualche nuvola ferma, una di esse riflette debolmente la luce del sole che cala. Del resto dal balcone non si vede. Sul muro di pietra in fondo al cortile un uccellino s’agita come se avesse appena scoperto qualcosa d’incontenibile. E tu?
Cala la notte. In città s’accendono i lampioni e le finestre: fra un lembo e l’altro di buio. Il vento aumenta e con lui arriva odore di cenere e polvere. Il chiaro di luna distende una maschera mortuaria sulle colline nei pressi, come se non fossero più colline ma note basse. Questo posto è per lui la fine del mondo. Non che ci stia male, alla fine del mondo. Ha ormai fatto quel che poteva fare, d’ora in poi aspetterà.
Amos Oz, Non dire notte

Sull’automobile viaggiavano due uomini depressi. Il sole al tramonto, battendo sul parabrezza polveroso, infastidiva i loro occhi. Era l’estate di San Giovanni. Lungo la strada sterrata il paesaggio finlandese scorreva sotto il loro sguardo stanco, ma nessuno dei due prestava la minima attenzione alla bellezza della sera. Erano un giornalista e un fotografo in viaggio di lavoro, due persone ciniche, infelici. Prossimi alla quarantina, erano ormai lontani dalle illusioni e dai sogni della gioventù, che non erano mai riusciti a realizzare. Sposati, delusi, traditi, entrambi con un inizio d’ulcera e una quotidiana razione di problemi di ogni genere con cui fare i conti.
Arto Paasilinna, L’anno della lepre
La schiuma alla bocca, dieci tori impazziti passarono al galoppo davanti all’umile dimora del lattoniere Vaino Volotinen. Il temporale più violento dell’estate si era appena abbattuto sulla mandria. “Mamma, corri, vieni a vedere!” gridarono i bambini rivolgendosi alla camera dove la moglie di Vaino Volotinen stava partorendo l’ultimo rampollo. Nonostante le doglie del parto, Siiri Volotinen si alzò e, spinta dalla curiosità, si trascinò fino alla finestra. “I lampi li avranno fatti impazzire”, constatò, e se ne tornò al suo travaglio.
Arto Paasilinna, La prima moglie e altre cianfrusaglie
E’ una sera d’inverno. Le vie della grande città sono deserte, a parte uno spazzaneve solitario che sgombra i marciapiedi dalla neve appena caduta. Dalle finestre delle case i televisori a colori proiettano sul cielo nero le loro luci cangianti. Su un tavolo arde una candela. Nel suo alone caldo, due figure: un uomo e una donna. Protesi l’uno verso l’altra, si tengono la mano e si guardano negli occhi.
Arto Paasilinna, Il liberatore dei popoli oppressi
L’incidente scosse tutta Tattarisuo. L’esplosione di idrogeno scagliò come un proiettile Aadam Rymättylä, in tuta fumante, fuori dal deposito di batterie della sua officina. Il capannone di lamiera tremava da cima a fondo, dentro si sentiva un terribile fracasso di vetri rotti e dalla doppia porta spalancata uscivano nubi di vapore e fumo. Aadam sputò la fuliggine che aveva in gola. La sua faccia rossa era chiazzata di nero, le orecchie ronzavano rintronate e il cuore non sapeva più se fermarsi o battere all’impazzata. Superato il primo choc, si sedette sui gradini del deposito, estrasse dalla tasca un pacchetto verde di nazionali senza filtro, ne accese una e diede un lungo tiro. Chiuse gli occhi e dichiarò: «Che primavera di merda!» In effetti era aprile, era cominciato il disgelo, le pozzanghere oleose dei tristi viali della zona industriale di Tattarisuo scintillavano di tutti i colori dell’arcobaleno. I primi boccioli spuntavano sui cespugli polverosi lungo il bordo dei fossi. Gli uccelli migratori non avevano ancora fatto la loro apparizione, ma si sentiva il gracchiare delle cornacchie nei boschi dietro i depositi di rottami. Anche quella era una musica primaverile, dopo tutto, in sintonia con lo scenario. Aadam Rymättylä era un piccolo imprenditore sulla quarantina, d’aspetto e carattere ruvido, un tipico finlandese. Grande, massiccio, già visibilmente segnato da non poche prove della vita. L’inverno e la primavera erano stati tempi duri, per lui. Il fatturato della sua rivendita di batterie non aveva fatto che calare, la crisi aveva limato i ricavi, già di per sé modesti. Le uniche cose che ancora crescevano regolarmente erano i debiti e gli interessi.
Arto Paasilinna, Aadam ed Eeva

Dolore. Nonna Mencía soffre accanto a me. Ha un braccio rotto e novant’anni. Ha anche ricordi, immagini, voci e nomi che a volte confonde con cose che non ha vissuto. E tenerezza. E silenzio, anche. Due letti. Su uno giace la nonna, vecchia e smemorata. Quando si alza, perde i denti. A volte la mamma li ritrova nella pattumiera. Allora Mencía la guarda e sorride, anche se non sa perché. Due letti. Sull’altro ci sono io, a contorcermi per il dolore. Herpes zoster. Un’artigliata che mi copre il busto dall’ombelico alla spina dorsale. Ero andata in ospedale pensando di avere una costola rotta. la dottoressa ha riso quando mi ha visto la schiena.
Alejandro Palomas, Tanta vita

Mamma aveva detto che i fiori li avrebbe comprati lei, ma nel trambusto generale si è dimenticata di passare dal fioraio e siamo rimasti senza. Adesso sta contando i chicchi d’uva vicino a me. Li strappa delicatamente dal grappolo mentre ascolta la radio che risuona, moltiplicata per tre, nel piccolo appartamento, dall’apparecchio che sta sul piano cottura della cucina, da quello che ha lasciato acceso nella sua camera e, infine, dall’altro che ha sistemato in bagno, e che spegne molto di rado. Seduti al tavolo della sala da pranzo, lei conta i chicchi d’uva e io piego i tovagliolo rossi con fantasie natalizie, mentre nel forno si raffreddano la crema di asparagi e una specie di arrosto che dovrebbe essere di tacchino, ma che sembra qualcos’altro.
Alejandro Palomas, Capodanno da mia madre
Adesso io sono un morto, un cadavere in fondo a un pozzo. Ho esalato l’ultimo respiro ormai da tempo, il mio cuore si è fermato, ma, a parte quel vigliacco del mio assassino, nessuno sa cosa mi sia successo. Lui, il disgraziato schifoso, per essere sicuro di avermi ucciso ha ascoltato il mio respiro, ha tastato il mio polso, mi ha dato un calcio nel fianco, mi ha portato al pozzo e mi ha preso in braccio per poi buttarmici dentro.
Orhan Pamuk, Il mio nome è rosso
Volevo fare lo scrittore. Ma, dopo i fatti che mi accingo a raccontare, sono diventato un geologo e un costruttore. Non credano i miei lettori che questi eventi siano morti e sepolti, che questi fatti appartengano al passato solo perché ho deciso finalmente di narrarli. Ogni volta che torno a pensarci, ogni volta, sento addosso il peso di quei momenti. Per questo sono sicuro che anche voi, come me, vi lascerete trascinare nella spirale dei misteri del rapporto tra padre e figlio.
Orhan Pamuk, La donna dai capelli rossi
Andavano e sempre camminando cantavano “eterna memoria”, e a ogni pausa era come se lo scalpiccio, i cavalli, le folate di vento seguitassero quel canto. I passanti facevano largo al corteo, contavano le corone, si segnavano. I curiosi, mescolandosi alla fila, chiedevano: “Chi è morto?” La risposta era: “Zivago.” “Ah! Allora si capisce.” “Ma non lui. La moglie.” “È lo stesso. Dio l’abbia in gloria. Gran bel funerale.” Scoccarono gli ultimi minuti, scanditi, irrevocabili. “La terra del Signore e la sua creazione, l’universo e ogni cosa vivente.” Il prete nel gesto della benedizione gettò un pugno di terra su Màrija Nikolàevna. Fu intonato “Con gli spiriti giusti.” Poi tutto prese un ritmo spaventoso. La bara fu chiusa, inchiodata, calata nella fossa. Tambureggiò la pioggia delle palate di terra, rovesciata in fretta, con quattro vanghe, sulla cassa, finché non si formò un piccolo tumulo. Sopra vi salì un ragazzo di dieci anni. Soltanto quello stato d’inebetito torpore, che di solito prende alla fine d’ogni imponente funerale, poté creare l’impressione che il bambino volesse tenere un discorso sulla tomba della madre.
Boris Pasternak, Il dottor Zivago
A quei tempi era sempre festa. Bastava uscire di casa e traversare la strada, per diventare come matte, e tutto era così bello, specialmente di notte, che tornando stanche morte speravano ancora che qualcosa succedesse, che scoppiasse un incendio, che in casa nascesse un bambino, e magari venisse giorno all’improvviso e tutta la gente uscisse in strada e si potesse continuare a camminare fino ai prati e fin dietro le colline. – Siete sane, siete giovani, – dicevano, – siete ragazze, non avete pensieri, si capisce-. Eppure una di loro, quella Tina che era uscita zoppa dall’ospedale e in casa non aveva da mangiare, anche lei rideva per niente, e una sera, trottando dietro gli altri, si era fermata e si era messa a piangere perché dormire era una stupidaggine e rubava tempo all’allegria.
Cesare Pavese, La bella estate

Da parecchio tempo eravamo intesi con l’amico Doro che sarei stato ospite suo. A Doro volevo un gran bene, e quando lui per sposarsi andò a stare a Genova ci feci una mezza malattia. Quando gli scrissi per rifiutare di assistere alle nozze, ricevetti una risposta asciutta e baldanzosa dove mi spiegava che, se i soldi non devono neanche servire a stabilirsi nella città che piace alla moglie, allora non si capisce più a che cosa devano servire. Poi, un bel giorno, di passaggio a Genova, mi presentai a casa sua e facemmo la pace. Mi riuscì molto simpatica la moglie, una monella che mi disse graziosamente di chiamarla Clelia e ci lasciò soli quel tanto ch’era giusto, e quando alla sera ci ricomparve innanzi per uscire con noi, era diventata un’incantevole signora cui, se non fossi stato io, avrei baciato la mano.
Cesare Pavese, La spiaggia
Già in altri tempi si diceva la collina come avremmo detto il mare o la boscaglia. Ci tornavo la sera, dalla città che si oscurava, e per me non era un luogo tra gli altri, ma un aspetto delle cose, un modo di vivere. Per esempio, non vedevo differenza tra quelle colline e queste antiche dove giocai da bambino e adesso vivo: sempre un terreno accidentato e serpeggiante, coltivato e selvatico, sempre strade, cascine e burroni.
Cesare Pavese, La casa in collina
Ci sarà tepore nella stanza e odore di cibi fritti. Verranno tutti, con i vestiti della festa, le scarpe rinfrescate da una spazzolata. Arriveranno alle nove e, l’uno dopo l’altro, prenderanno posto intorno alla tavola. Non porteranno regali, non lo fanno mai, ma non importa: ne ho preparati io per loro, davanti ai quali spalancheranno gli occhi, ma io guarderò altrove.
Entrando non si saluteranno, né saluteranno me, ma a poco a poco prenderanno confidenza con le sedie impagliate di fresco, con la tovaglia di macramè che uso solo una volta all’anno. Si guarderanno intorno scrutando la casa silenziosa; quindi cederanno all’impulso di annusare l’aria e aggrotteranno le sopracciglia: non sono venuti per mangiare, ma allora perché sono qui? Dopodiché si metteranno a sedere e aspetteranno. Io porterò in tavola ravioli di ricotta, poi fagotti di castagne che quest’anno son venuti meglio, infine fichi secchi che con cura ho riempito di noci.
Carmen Pellegrino, Cade la terra
La voce femminile si diffonde dall’altoparlante, leggera e piena di promesse come un velo da sposa. – Il signor Malaussene è desiderato all’Ufficio Reclami. Una voce velata, come se le foto di Hamilton si mettessero a parlare. Eppure, colgo un leggero sorriso dietro la nebbia di Miss Hamilton. Niente affatto tenero, il sorriso. Bene, vado. Arriverò probabilmente la settimana prossima. E’ il 24 dicembre, sono le 16 e 15, il Grande Magazzino è strapieno. Una fitta folla di clienti gravati dai regali ostruisce i passaggi. Un ghiacciaio che cola impercettibilmente, in un cupo nervosismo. Sorrisi contratti, sudore lucente, ingiurie sorde, sguardi pieni d’odio, urla terrorizzate di bambini acciuffati da Babbi Natale idrofili.
Daniel Pennac, Il paradiso degli orchi
Il pirata informatico si infiltrò nel sistema centrale del Vaticano undici minuti prima di mezzanotte. Trentacinque secondi dopo, uno dei computer collegati alla rete principale dette l’allarme. Solo una spia luminosa intermittente sullo schermo segnalava l’inserimento automatico del controllo di sicurezza in seguito ad una intrusione esterna.
Arturo Pérez-Reverte, La pelle del tamburo
Squillò il telefono e lei seppe che l’avrebbero uccisa. Lo seppe con una tale sicurezza che rimase immobile, il rasoio alzato, i capelli appiccicati alla faccia nel vapore dell’acqua calda che gocciolava sulle piastrelle. Drin. Rimase fermissima, trattenendo il respiro come se l’immobilità o il silenzio potessero cambiare il corso degli eventi già accaduti. Drin. Era nella vasca da bagno e si stava depilando la gamba destra, con l’acqua insaponata che le arrivava alla vita, e le venne la pelle d’oca come se avesse appena aperto il rubinetto dell’acqua fredda. Drin. Nello stereo della camera da letto Los Tigres del Norte cantavano le storie di Camelia la Texana. Tradimento e contrabbando, dicevano, non possono andare d’accordo. Aveva sempre temuto che certe canzoni fossero presagi, e di colpo si erano trasformate in realtà cupa e minacciosa. Il Biondo ci scherzava sopra; ma quello squillo dava ragione a lei e torto al Biondo.
Arturo Pérez-Reverte, “La regina del Sud”

I sogni in molte occasioni si trasformano in incubi. Quando avevo sognato con due miei colleghi di costruire nel paese un hotel, una residenza, nel caso che un giorno, divenuto ormai anziano, avessi avuto necessità di un luogo dove terminare il mio viaggio terreno, non pensavo certo sarebbe finita così. Sono tornato nel villaggio dove ero stato felice, nel ricordo di un’estate senza fine vissuta tra luglio e agosto, che crebbe con me fin dall’adolescenza. Tutte quelle vacanza non furono altro che un miraggio, con il tiepido sole che si stiracchiava ogni mattina, sorgendo sullo specchio color piombo del mare. Le sere del dolce far niente che rivivevo durante tutto l’inverno, le chiacchiere senza tempo cercando di convincere i miei amici che gli angeli avevano un sesso, passeggiare di notte sul ponte, lasciando che l’acqua scegliesse uno dei cinque archi che portavano il fiume a sfociare nel mare.
Ramón Pernas, Hotel Paradiso
Bepy sentì di non avere scampo diverse ore dopo aver incassato la diagnosi di tumore alla vescica, quando tra il novero sterminato d’interrogativi agghiaccianti scelse: Potrò ancora scopare una donna o tutto finisce qui? Sebbene tale dilemma possa apparire una patologica inversione delle priorità, per lui, nell’estremo frangente, risultò più spaventoso lo spettro della compromessa mascolinità che l’orrore del nulla: forse perché nel suo immaginario impotenza e morte coincidevano, anche se la seconda era preferibile alla prima, se non altro per il conforto dell’assenza eterna … O forse il salto nel buio che aveva condotto quest’uomo di successo alla bancarotta finanziaria era stato troppo fulmineo per non scalfirgli l’integrità emotiva.
Alessandro Piperno, Con le peggiori intenzioni
Per molto tempo, mi son coricato presto la sera. A volte, non appena spenta la candela, mi si chiudevan gli occhi così subito che neppure potevo dire a me stesso: “M’addormento”. E, una mezz’ora dopo, il pensiero che dovevo ormai cercar sonno mi ridestava; volevo posare il libro, sembrandomi averlo ancora fra le mani, e soffiare sul lume; dormendo avevo seguitato le mie riflessioni su quel che avevo appena letto, ma queste riflessioni avevan preso una forma un po’ speciale; mi sembrava d’essere io stesso l’argomento del libro: una chiesa, un quartetto, la rivalità tra Francesco I e Carlo V. La convinzione sopravviveva per qualche attimo al mio risveglio, e non offendeva la mia ragione, ma mi pesava sugli occhi come scaglie, ed impediva loro di rendersi conto che la candela non era più accesa.
Marcel Proust, La strada di Swann
Quando si trattò di avere per la prima volta a pranzo il signor di Norpois, siccome mia madre diceva che era proprio un peccato che il professor Cottard fosse in viaggio e che lei avesse smesso del tutto di frequentare Swann, perché l’uno e l’altro avrebbero certamente interessato l’ex ambasciatore, mio padre rispose che un convitato eminente, un illustre scienziato come Cottard non poteva mai sfigurare in un pranzo, ma Swann, con la sua ostentazione, e quel suo modo di strombazzare le conoscenze più trascurabili, era un volgare sbruffone che il marchese di Norpois avrebbe di sicuro giudicato, secondo la sua espressione, “pestifero”.
Marcel Proust, All’ombra delle fanciulle in fiore
Il pigolar mattutino degli uccelli sembrava insulso a Françoise. Ogni parola delle “donne” la faceva sussultare; intrigata da ogni lor passo, era sempre a domandarsene la direzione: avevamo cambiato casa. Non era che ci fosse minor movimento di domestici nel “sesto piano” della nostra casa di prima; ma quelli li conosceva, e i loro andirivieni le eran divenuti cosa nota ed amica.
Marcel Proust, I Guermantes
E’ noto come quel giorno (il giorno che c’era la festa della principessa di Guermantes), molto prima di recarmi a fare al duca e alla duchessa la visita che ho narrata, io avevo spiato il loro ritorno, e, stando di scolta, avevo fatto una scoperta che riguardava in particolare il signor di Charlus, ma così importante in sé che fino ad oggi, fino al momento di poterle dare lo spazio e l’ampiezza dovuti, mi sono astenuto dal raccontarla.
Marcel Proust, Sodoma e Gomorra
Sin dal mattino, la testa ancora vòlta verso la parete, e prima ancora d’aver visto, sopra i grandi tendaggi della finestra, di qual colore fosse la striscia luminosa del giorno, sapevo già che tempo era. Me lo avevano appreso i primi rumori della strada, secondo che mi giungevano smorzati e deviati dall’umidità o vibranti come frecce nell’area risonante e vuota d’un mattino spazioso, gelido e puro; sin dal rotolio del primo tram, avevo intuito se se ne stava intirizzito nella pioggia o se era in partenza per l’azzurro.
Marcel Proust, La prigioniera
“La signorina Albertine se n’è andata!” Come, più della psicologia stessa, la sofferenza la sa lunga in materia di psicologia! Un momento prima, mentre mi stavo analizzando, avevo creduto che una separazione senza esserci riveduti fosse appunto quella che desideravo; e, paragonando la mediocrità dei piaceri che Albertine mi dava con la ricchezza dei desideri che mi impediva di soddisfare ( e ai quali la certezza della sua presenza in casa mia, pressione della mia atmosfera morale, aveva permesso di occupare nel mio animo il primo posto, ma che, non appena ricevuta la notizia della partenza di Albertine, neppur potevano porsi in concorrenza con lei, svaniti com’erano, tutt’a un tratto), mi ero stimato molto acuto, concludendo che non volevo più vederla, che non l’amavo più.
Marcel Proust, La fuggitiva
Non avrei ragione d’intrattenermi sul soggiorno che feci nei pressi di Combray, e che fu forse il momento della mia vita in cui meno pensai a Combray, se, proprio per questo, esso non avesse apportato una verifica almeno provvisoria a certe idee che m’eran venute dapprima dalla “parte di Guermantes” e anche ad altre venutemi dalla “parte di Méséglise”. Ricominciai ogni sera, ma in un altro senso, le passeggiate che facevamo, di pomeriggio, a Combray, quando si andava verso Méséglise.
Marcel Proust, Il tempo ritrovato
Alla fine degli anni Trenta del XX secolo, nella Repubblica Cecoslovacca, solo un paio di città potevano vantare una piscina. Levice era tra quelle. Poiché il primo settembre del 1938 era una giornata di sole, in piscina c’erano praticamente tutti. Adulti con bambini e senza bambini, giovani e vecchi, gente di Levice e anche dei paesi vicini, ungheresi, slovacchi, cechi, ebrei, zingari, la famiglia del tedesco Barthel e quella del bulgaro Rankov. C’erano democratici, liberali, conservatori, monarchici, socialisti, nazionalisti, comunisti e fascisti. Solo l’anarchico Varga si trovava in Spagna. In piscina non mancavano neppure Peter, Honza e Gabriel. erano seduti su un muretto di cemento, con gli occhi socchiusi contro i raggi del sole, e dondolavano le gambe.
Pavol Rankov, Accadde il primo settembre
Si svegliò col suono della stessa musica tonda, dal ritmo sciocco. Come tutte le mattine, ascoltò l’elenco delle ipertrofie del traffico, fra Sala Consilina e Lagonegro Nord fra Brogeda e Como e Chiasso. Levò una mano senza aprire gli occhi, palpò la superficie liscia della radio. La radio tacque. Un piccolo sollievo subito annullato dal peso degli oscuri riferimeti notturni. Sentendosi stanco si alzò. Si guardò i piedi. Uniti, nudi, magri. Gli parvero estranei al suo corpo.
Lidia Ravera, Le seduzioni dell’inverno
Ero un fiore ancora in boccio, ma già smaniosa di essere un’altra, anzi svariate altre, a seconda dei casi. Creatura di carta, sfogliavo pagine in continuazione pretendendo di entrarci dentro per farmi personaggio a mia volta, entità immaginaria come i miei eroi: ehi, adesso dovete fare i conti con me!
Lo dicevo al maschile: da grande farò il libraio, venderò storie, avventure, tormenti e tutto il resto. Mi arrampicavo su scale traballanti per raggiungere gli scaffali più alti, incuriosita dai dorsi dei classici che quasi toccavano il soffitto. Era tutto così bianco in quella intelligent room di don Arturo Mastrocinque, un bianco quasi accecante nel quale ogni volta rischiavo di precipitare assieme a una pioggia di romanzi con le ali aperte come uccelli. L’ho sognato almeno due volte: ero io stessa un libro che cadeva con le ali aperte.
Ermanno Rea, Il sorriso di don Giovanni
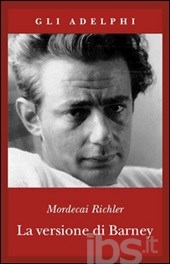
Tutta colpa di Terry. E’ lui il mio sassolino nella scarpa. E se proprio devo essere sincero, è per togliermelo che ho deciso di cacciarmi in questo casino, cioè di raccontare la vera storia della mia vita dissipata. Fra l’altro mettendomi a scribacchiare un libro alla mia veneranda età violo un giuramento solenne, ma non posso non farlo. Non posso lasciare senza risposta le volgari insinuazioni che nella sua imminente autobiografia Terry Mc Iver avanza su di me, le mie tre mogli ( o come dice lui la troika di Barney Panofsky), la natura della mia amicizia con Boogie e, ovviamente, lo scandalo che mi porterò fin nella tomba.
Mordecai Richler, La versione di Barney
Muove le dita dei piedi. Dita lunghe, storte, dalla unghie spesse. Le muove sulla sabbia sporca, godendosi la sensazione di fresco al tatto, la brezza della sera che arriva dal fiume e che gli fa il solletico sulla pelle indurita. Muove le dita dei piedi ma senza guardarle. Quello che guarda, con apprensione, amore, sollievo e tristezza, sono le scarpe che ha accanto a sé. Sono scarpe nere e vecchie, dalla punta arrotondata, screpolate dall’uso ma curate da una lustratura quotidiana. Roque Rey guarda le scarpe e non sa bene che cosa dovrebbe pensare, che cosa potrebbe dire in un momento simile. Perché il problema è che l’uomo che è diventato sa che momenti simili non esistono. Roque Rey è un uomo sulla quarantina, alto e biondo, che sa che ci sono momenti che non esistono ma che sa, pure, che ci sono decisioni che possono essere prese soltanto in quei momenti. È un uomo dai movimenti compassati e sicuri, che indossa vestiti chiari, puliti e ordinari, e che si è appena tolto le scarpe. La cura, la delicatezza con cui le ha appoggiate sulla radice contorta del salice che gli fa ombra, rivela che quelle scarpe non sono scarpe qualsiasi. E nemmeno il gesto. Le scarpe sono uniche e lo è, anche, l’atto di togliersele.
Ricardo Romero, Storia di Roque Rey
Lo Svedese. Negli anni della guerra, quando ero ancora alle elementari, questo era un nome magico nel nostro quartiere di Newark, anche per gli adulti della generazione successiva a quella del vecchio ghetto cittadino di Prince Street che non erano ancora così perfettamente americanizzati da restare a bocca aperta davanti alla bravura di un atleta del liceo. Era magico il nome, come l’eccezionalità del viso. Dei pochi studenti ebrei di pelle chiara presenti nel nostro liceo pubblico prevalentemente ebraico, nessuno aveva nulla che somigliasse anche lontanamente alla mascella quadrata e all’inespressiva maschera vichinga di questo biondino dagli occhi celesti spuntato nella nostra tribù con il nome di Seymour Irving Levov.
Philip Roth, Pastorale americana
Il treno per Odessa fila a centocinquanta orari nella luce verde della sera, scavalca fiumi color rame, scende verso il Mar Nero sul lungo piano inclinato dell’Ucraina. Lo scompartimento trema, pare indemoniato: sul tavolino è franata ogni cosa, e sulla cuccetta di sopra un tipo di centocinquanta chili russa e sussulta così paurosamente che temo precipiti anche lui. Intanto mi sono già caduti addosso il suo zaino, una pioggia di monetine e una bottiglia d’acqua minerale. Alla partenza mi ha chiesto: “Di dove sei?”. Gli ho detto “italiano”, e lui, ridendo incredulo, ha detto: “Ma che ci vieni a fare in questo paese?”. Gli ho risposto con un sospiro, “La vostra è una terra meravigliosa”, ma lui si era girato su un fianco col suo corpaccione da plantigrado per piombare in un letargo istantaneo, come sotto anestesia, in una notte profondissima dei sensi.
Paolo Rumiz, Trans Europa Express
“Voi non capite niente dell’amore.”/ Così tagliava corto il nostro Max / quando il discorso cadeva sul tema / della passione che il mondo consuma. / “Über die Liebe was glaubt ihr zu wissen” / erano proprio queste le parole / che ripeteva con aria di sfida / e un po’ con questo tono della voce. / Faceva un gesto largo con la mano / per esprimere il suo compatimento / ed era quello il segnale che noi / aspettavamo per farci coraggio / e chiedergli un’altra volta / della cotogna venuta da Istanbul / quella sua storia d’amore e di morte / che si giocò tra Bosforo r Danubio / quando ebbe fine al centro dei Balcani / una cosa che noi chiamiamo guerra / e invece fu, lo posso garantire / io che l’ho vista molto da vicino / nient’altro che un imbroglio vergognoso.
Paolo Rumiz, La cotogna di Istanbul
Randeep Sanghera era in piedi di fronte alla cartina verde e azzurra attaccata alla parete. L’aveva trovata nell’appartamento e, benché grande e sgualcita, con un arcipelago di bruciature di sigaretta in mezzo all’Atlantico, l’aveva tenuta, a ricordo del mondo esterno. Lo convincevano meno i fiori dall’aria colpevole, acquistati dopo lunghe riflessioni alla stazione di servizio. Buttali via, si era detto, ma poi aveva sentito il rumaore dell’auto e il pensiero gli era fuggito di mente. Con passo nervoso scese uno dopo l’altro i gradini delle scale strette, deglutendo a fatica, aggiustandosi i polsini della camicia. Scorse una sagoma dietro la porta di vetro smerigliato. Quando la aprì si ritrovò di fronte Narinder Kaur, la figura brillante incisa nel buio, il cappotto sbottonato nonostante il freddo. Persino in Inghilterra copriva il capo con il kesri. Era di un verde intenso, abbinato al salwaar kameez. Una ciocca ribelle le si arricciava intorno all’orecchio. Aveva scordato quanto fossero grandi e vispi i suoi occhi. Alle sue spalle il taxi fece inversione e si avviò giù per la discesa.
Sunjeev Sahota, L’anno dei fuggiaschi
Se davvero avete voglia di sentire questa storia, magari vorrete sapere prima di tutto dove sono nato e com’è stata la mia infanzia schifa e che cosa facevano i miei genitori e compagnia bella prima che arrivassi io, e tutte quelle baggianate alla David Copperfield, ma a me non mi va proprio di parlarne. Primo, quella roba mi secca, e secondo, ai miei genitori gli verrebbero un paio di infarti per uno se dicessi qualcosa di troppo personale sul loro conto.
J.D. Salinger, Il giovane Holden
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, l’illustrissimo monsignor vescovo-arcivescovo di Palma di Maiorca, con un gesto della veneranda mano su cui brilla l’anello pastorale, indica ai carnefici il petto dei poveri “cattivi”. Ce lo dice George Bernanos. Ce lo dice un fervente cattolico.
Spagna, 1936. La guerra civile sta per scoppiare, e mia madre è una povera cattiva. Una povera cattiva è una povera che non tiene la bocca chiusa. Il 18 luglio 1936 mia madre apre bocca per la prima volta. Ha quindici anni. Abita in un paesino sperduto in cui, da secoli, un pugno di latifondisti costringe tante famiglie come la sua a vivere nella miseria più nera.
Lydie Salvayre, Non piangere
Quando il signore, noto anche come dio, si accorse che ad adamo ed eva, perfetti in tutto ciò che presentavano alla vista, non usciva di bocca una parola né emettevano un sia pur semplice suono primario, dovetta prendersela con se stesso, dato che non c’era nessun altro nel giardino dell’eden cui poter dare la responsabilità di quella mancanza gravissima, quando gli altri animali, tutti quanti prodotti, proprio come i due esseri umani, del sia-fatto divino, chi con muggiti e ruggiti, chi con grugniti, cinguettii, fischi e schiamazzi, godevano già di voce propria.
José Saramago, Caino
Thusandi sapeva che gli strani rumori che squarciavano il silenzio della mattina tropicale erano la fine del sogno. Il momento che aspettavano da anni era arrivato. Attenta a non svegliare le figlie addormentate nella metà del letto che di solito occupava suo marito, aprì dolcemente la zanzariera. Dal balcone vide che centinaia di soldati birmani circondavano il palazzo. Avevano trasformato le solide mura di pietra che racchiudevano l’East Haw in un mostro vivente: dietro la cinta spuntavano infatti schiere di uomini in uniforme ed elmetto verde. A brevi comandi abbaiati nella solitudine del primo mattino seguiva un fruscio di stivali nel sottobosco secco.
Inge Sargent, Il tramonto birmano
Come ragazzina degli anni Cinquanta sei consapevole dei tuoi complessi di inferiorità e preferiresti essere maschio. Questo desiderio fa sì che non sposerai mai la causa del femminismo più intransigente. Gli uomini sono gli attori più importanti dell’umanità. Si potrebbe mai immaginare un de Gaulle donna? Il Grand Pic de la Meije, 3983 m, è stato scalato da due uomini audaci, Emmanuel Boileau de Castelnau e Pierre Gaspard. E poi i padri stravedono per i figli maschi, che possono fare ginnastica mezzi nudi sotto il sole, non devono portarsi dietro accessori ridicoli come le borsette, nè mettersi il rossetto sulle labbra o tenere la pancia in dentro, non devono neanche indossare un corsetto, come invece fa tua madre, una specie di strumento di tortura con stecche che lasciano sull’addome impronte verticali. Una maschera addominale. Da quel coso pendono dei gancetti metallici ai quali vanno fissate le calze di nylon. Come si chiama questa maschera?, domandi a tua sorella maggiore. Sex appeal, risponde lei.
Sylvie Schenk, Veloce la vita
«Non le darà disturbo, le piace soprattutto starsene in piedi a guardare». La vicina, a cui la madre lasciò la figlia, all’inizio stentava a crederci, invece era proprio così: la bambina, un anno appena, se ne stava lì in cucina a guardare, uno dopo l’altro, il tavolo con le quattro sedie, la credenza, i fornelli con le padelle e i mestoli, il lavello munito di specchio per servire anche da lavandino, la finestra, le tende e, infine, la lamapada appesa al soffitto. Poi fece qualche passo verso la porta che si apriva sulla camera da letto e anche qui esaminò tutto: il letto, il comodino, l’armadio, il comò, la finestra e le tende e, ancora per ultima, la lampada. Il suo sguardo era attento, anche se gli spazi nella casa della vicina non erano distribuiti o arredati in maniera così diversa rispetto a quella dei suoi genitori. Quando la vicina pensò che la piccola taciturna avesse ormai visto tutto quello che c’era da vedere in quell’appartamento di due stanze – il gabinetto era sulle scale – la aiutò a salire sulla sedia accanto alla finestra. Il quartiere era povero, e dietro a ognuno degli alti caseggiati si apriva un cortile stretto, seguito da un altro caseggiato. La viuzza era affollata di persone che uscivano dalle tante case intorno; poi c’erano il tram e i carretti che vendevano frutta, verdura e patate; gli ambulanti, uomini e donne, con le cassette appese al collo, che vendevano sigarette, fiammiferi e cianfrusaglie varie; i ragazzini che vendevano giornali e le donne che vendevano se stesse. Gli uomini agli angoli delle strade sembravano aspettare un’occasione, una qualunque.
Bernhard Schlink, Olga
All’età di quindici anni mi venne l’itterizia. Mi ammalai durante l’autunno e potei considerarmi guarito solo quando era già iniziata la primavera. Più l’anno vecchio si faceva freddo e scuro, più io m’indebolivo. Solo con l’arrivo dell’anno nuovo la situazione cominciò a migliorare. A gennaio fece caldo e mia madre spostò il mio letto in direzione del balcone. Vedevo il cielo, il sole, le nuvole e sentivo i bambini che giocavano in cortile. In un tardo pomeriggio di febbraio udii un merlo cantare. La mia prima uscita mi portò da Blumenstraße, dove vivevamo al secondo piano di una massiccia palazzina del primo Novecento, fino in Bahnofstraße. Lì, un lunedì di ottobre, di ritorno da scuola, ero stato assalito dai conati di vomito. Già da alcuni giorni mi sentivo di una debolezza estrema: ogni passo mi costava un grosso sforzo e, quando salivo le scale a casa o a scuola, le gambe mi reggevano a malapena. Non avevo appetito e, persino quando mi sedevo a tavola affamato, il cibo mi dava subito il disgusto. La mattina mi alzavo con la bocca secca e la sensazione che i miei organi fossero pesanti e fuori posto. Essere così debole mi imbarazzava, ma soprattutto mi imbarazzò vomitare.
Bernhard Schlink, Il lettore
La lettera arrivò con la distribuzione del pomeriggio. Il postino posò prima sul banco, come al solito, il fascio versicolore delle stampe pubblicitarie; poi con precauzione, quasi ci fosse il pericolo di vederla esplodere, la lettera: busta gialla, indirizzo a stampa su un rettangolino bianco incollato alla busta.
Leonardo Sciascia, A ciascuno il suo
L’autobus stava per partire, rombava sordo con improvvisi raschi e singulti. La piazza era silenziosa nel grigio dell’alba, sfilacce di nebbia ai campanili della Matrice: solo il rombo dell’autobus e la voce del venditore di panelle, panelle calde panelle, implorante ed ironica. Il bigliettaio chiuse lo sportello, l’autobus si mosse con un rumore di sfasciume.
Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta
Non maledire ciò che viene dal cielo. Inclusa la pioggia. Non importa cosa ti precipiti addosso, non importa quanto violento il nubifragio o gelida la grandine: non rifiutare quello che il cielo ti manda. Lo sanno tutti. Inclusa Zeliha. Eppure, quel primo venerdì di luglio, eccola affrettarsi sul marciapiede soffocato dal traffico, verso un appuntamento per il quale è già in ritardo, imprecando come uno scaricatore e sibilando una bestemmia dietro l’altra contro le pietre rotte del selciato, contro i tacchi alti, contro l’uomo che la segue, contro ogni singolo autista che pesta frenetico sul clacson quando è assodato che non serve a niente, contro l’intera dinastia ottomana che nella notte dei tempi ha conquistato Costantinopoli, e sì, contro la pioggia … quella stramaledetta pioggia estiva.
Elif Shafak, La bastarda di Istanbul
Fu in una normale giornata di primavera a Istanbul, un lungo e plumbeo pomeriggio come tanti altri, che Peri scoprì, con un senso di vuoto allo stomaco, di essere in grado di uccidere. Aveva sempre sospettato che persino le donne più tranquille e amabili, in una situazione di tensione, fossero capaci di scoppi di violenza; visto poi che lei non si riteneva né tranquilla né amabile, le era chiaro che le sue potenzialità di perdere il controllo erano ben maggiori. Ma “potenzialità” era una parola infida: una volta dicevano tutti che la Turchia aveva grandi potenzialità, e guarda com’era andata a finire. Perciò si era convinta che anche le sue oscure potenzialità, in definitiva, non avrebbero portato a nulla.
Elif Shafak, Tre figlie di Eva
Il 13 giugno, giorno di Sant’Antonio da Padova, il presidente decretò un’amnistia per i delinquenti comuni. Prima di liberare il giovane Ángel Santiago, il direttore del carcere chiese che glielo portassero. Giunse con l’arroganza e la brutale bellezza dei suoi vent’anni, il naso altero, una ciocca di capelli che gli cadeva sulla guancia sinistra, e rimase in piedi sfidando l’autorità con lo sguardo. La grandine colpiva i vetri attraverso le sbarre e scioglieva lo spesso strato di polvere accumulata.
Antonio Skármeta, Il ballo della Vittoria
A quel tempo io facevo il redattore culturale per un quotidiano minore. La sezione di cui dovevo occuparmi era contrassegnata dall’idea di arte che aveva il nostro direttore, il quale, orgoglioso delle sue amicizie nell’ambiente, mi obbligava a rincorrere e a intervistare esponenti di compagnie di teatro leggero, a recensire libri scritti da ex investigatori, a scrivere articoli riguardanti circhi ambulanti o a fare elogi sperticati ai successi della settimana che avrebbe potuto buttare giù anche il primo che passa.
Antonio Skármeta, Il postino di Neruda
Non ho mai visto mio padre e mia madre. Ricordo che una volta, al tempo dell’infanzia, c’erano ospiti in casa e a tavola il discorso toccò quel tema, il nonno disse che Ausma se n’era andata di là dal mare con la troupe di un circo, ed era come se fosse caduta in un pozzo. Da allora guardai spesso con terrore l’acqua scura in fondo alle pareti umide del pozzo, temendo di vedere una donna affogata. La questione su padre e madre tornò a farsi bruciante al terzo anno di scuola, quando l’insegnante assegnò il tema: «La mia famiglia.» Il nonno fece solo un breve sorriso: scrivi che tua madre è la principessa del Siam e tuo padre Charlie Chaplin. Scrissi poi qualcosa del genere. Nel restituire i quaderni l’insegnante disse scherzando che un giorno sarei diventato uno scrittore, un secondo E.T.A. Hoffmann. Ma durante l’intervallo Fabians, il figlio del console Egle e mio acerrimo nemico, espresse il caustico dubbio che i figli di quel tipo di signore potessero avere un padre.
Zigmunds Skujiņš, Come tessere di un domino
Mia madre mi cominciò una sera del 1968 su un tavolo del bar dell’unico cinema della città. Solo una rampa di scale più su, dietro il velluto rosso spelacchiato della tenda della galleria, la maschera sbadigliava, appoggiata con il gomito sopra i rumori di lingue e vestiti che si strusciavano nell’ultima fila, giocherellando con la torcia spenta; staccava piccole schegge dal tramezzo di legno e le tirava sulle teste provinciali, al buio. Il film che scorreva sullo schermo sopra di loro era Poor Cow, con Terence Stamp, un attore talmente divino che mia madre, giovane, chic, snella e imperiosa, mentre guardava il film per la terza volta quella settimana, si alzò lasciando richiudere il sedile dietro di lei con un leggero tonfo, si fece largo tra le gambe della gente seduta nella sua fila e proseguì per il sudicio corridoio verso l’uscita, oltre la tenda e fuori, alla luce.
Ali Smith, Voci fuori campo
Le pagine che seguono raccontano la storia di Ásta, che un tempo è stata giovane, e che ormai è piuttosto anziana nel momento in cui queste righe vengono scritte, o meglio, scribacchiate, perché qui accade tutto di fretta, anche quando, a volte, la storia procede con tale lentezza che il tempo è quasi sul punto di fermarsi. Tra poco spiegherò perché è stata chiamata Ásta. Perché i suoi genitori hanno scelto questo nome, e non Sigríður, María, Gunnþórunn, Auður, Svava, Jóhanna, Guðrún oppure Fríða, perché tutti nasciamo senza nome e immediatamente, o poco dopo, ce ne assegnano uno, perché la morte faccia più fatica a trovarci. Dammi un nome, e la morte mi troverà meno facilmente. Ma com’è possibile raccontare la storia di una persona senza toccare anche le vite che la circondano, l’atmosfera che sostiene il cielo – e soprattutto, è legittimo farlo?
Jón Kalman Stefánsson, Storia di Ásta


Nemmeno il sole poteva porvi un freno, e nemmeno qualche bella parola come «arcobaleno» o «amore», erano del tutto vane, le potevi anche buttare via – tutto ebbe inizio con la morte. Abbiamo così tante cose; Dio, le preghiere, la musica, la tecnologia, la scienza, ogni giorno nuove scoperte, telefoni cellulari sempre più sofisticati, telescopi più potenti, ma poi qualcuno muore e tu non hai più nulla, brancoli nel vuoto in cerca di Dio, afferri la disperazione, la tazza di chi non c’è più, la spazzola con i suoi capelli ancora aggrovigliati, la conservi come un conforto, come un incantesimo, una lacrima, come chi non torna più. Cosa possiamo dire, probabilmente niente, la vita è incomprensibile, è ingiusta, eppure viviamo, non possiamo evitarlo, non sappiamo fare altro, la vita è l’unica cosa che abbiamo per certo, questo tesoro, questo ciarpame senza valore. Dopo la vita probabilmente non c’è nulla. Eppure tutto ebbe inizio con la morte. No, non regge, perché la morte è la fine, ciò che ci mette a tacere, che ci toglie la matita di mano nel bel mezzo di una frase, che spegne il computer, fa sparire il sole, incenerire il cielo, la morte è l’inanità stessa, non dobbiamo attribuirle nessun inizio, non si può. La morte è l’ultima risorsa di Dio, che si è concretizzata quando Dio, forse per disperazione, ha impastato insieme crudeltà e rimpianto perché il solitario della creazione sembrava non volergli venire. Ma in ogni morte, comunque, risiede una nuova vita.
Jón Kalman Stefánsson, I pesci non hanno gambe
Nella regione rossa e in parte della regione grigia dell’Oklahoma le ultime piogge erano state benigne, e non avevano lasciato profonde incisioni sulla faccia della terra, già tutta solcata di cicatrici. Gli aratri avevano cancellato le superficiali impronte dei rivoletti di scolo. Le ultime piogge avevano fatto rialzare la testa al granturco e stabilito colonie d’erbacce e d’ortiche sulle prode dei fossi, così che il grigio e il rosso cupo cominciavano a scomparire sotto una coltre verdeggiante. Agli ultimi di maggio il cielo impallidì e perdette le nuvole che aveva ospitate per così lungo tempo al principio della primavera. Il sole prese a picchiare e continuò di giorno in giorno a picchiar sempre più sodo sul giovane granturco finché vide ingiallire gli orli d’ogni singola baionetta verde.
John Steinbeck, Furore
Nel 1985 Lidočka compì cinque anni e la sua vita andò a rotoli. Era la prima volta che si incontranvano tanto da vicino, Lidočka e la sua vita, e fu per questo che entrambe fissarono nella mente con un’intensità vertiginosa ogni piccolo, salato, umido dettaglio della loro ultima estate felice. Il Mar Nero (nero perché non si lava mai le mani, giusto?), la pensione che ricordava un ammasso di scatole di fiammiferi, la spiaggia disseminata di coppette accartocciate di gelato alla frutta (papà diceva alla “brutta”) e di enormi corpi arroventati. La camminata del mattino fino al cantuccio prescelto, il movimento preciso dei piedi per non urtare con il tallone o con il telo carni estranee, abbondanti, rilassate. Lidočka si spazientiva subito, e non appena la mamma si distraeva per un attimo con la vicina al tavolo della mensa o col venditore ambulante del proibito zucchero filato, lei sfuggiva al rigido controllo visivo e, pestando indiscriminatamente i calcagni rotondi e grassocci, si lanciava con strilli acuti verso il mare. In allerta come foche, i villeggianti si sollevavano, si scrollavano la sabbia grossa come chicchi d’orzo da solchi umidi e pieghe sintetiche, replicavano sorridenti alle litanie di scuse dei genitori.
Marina Stepnova, Le donne di Lazar’
Sostiene Pereira di averlo conosciuto in un giorno d’estate. Una magnifica giornata d’estate, soleggiata e ventilata, e Lisbona sfavillava. Pare che Pereira stesse in redazione, non sapeva che fare, il direttore era in ferie, lui si trovava nell’imbarazzo di mettere su la pagina culturale, perché il “Lisboa” aveva ormai una pagina culturale, e l’avevano affidata a lui. E lui, Pereira, rifletteva sulla morte. Quel bel giorno d’estate, con la brezza atlantica che accarezzava le cime degli alberi e il sole che splendeva, e con una città che scintillava, letteralmente scintillava sotto la sua finestra, e un azzurro, un azzurro mai visto, sostiene Pereira, di un nitore che quasi feriva gli occhi, lui si mise a pensare alla morte. Perché? Questo a Pereira è impossibile dirlo. Sarà perché suo padre, quando lui era piccolo, aveva un’agenzia di pompe funebri che si chiamava Pereira La Dolorosa, sarà perché sua moglie era morta di tisi qualche anno prima, sarà perché lui era grasso, soffriva di cuore e aveva la pressione alta e il medico gli aveva detto che se andava avanti così non gli restava più tanto tempo, ma il fatto è che Pereira si mise a pensare alla morte, sostiene.
Antonio Tabucchi, Sostiene Pereira
Il ragazzo ha iniziato a parlare tardi. È timido, cauto; sa aspettare. Ora ha undici anni. Undici e mezzo direi, quasi dodici. Vive con sua madre nei pressi del parco, nella parte occidentale della città. L’affitto è troppo alto per lo stipendio di lei. Gli amici le consigliano di cambiare casa; lei ribatte elencando i pregi di quella sistemazione. C’è una scuola vicino e per arrivare alla fermata della metro ci vogliono appena sei minuti a piedi; il supermercato è praticamente dietro l’angolo, il quartiere non è ancora stato sommerso dalle ondate di violenza; ci sono il garage, il citofono e il verde. Altre motivazioni, di natura più intima, le nomina di rado. Un trasloco equivarrebbe alla disfatta. Ben sedici anni trascorsi nello stesso luogo. Un’eroica impresa di resistenza. Sedici! La durata di una giovinezza. Le domeniche d’estate, verso l’ora del crepuscolo, esce sul terrazzo con un bicchiere di vino in mano. «Vado al parco» dice al figlio, se capita che lui sia a casa. Ogni due fine settimana, e una parte delle vacanze estive, il ragazzo sta dal padre. Lui è più benestante. Un parvenue: il ragazzo potrebbe scommettere di aver sentito pronunciare quella parola dalla madre una volta. Lui gli compra fronzoli di ogni tipo, certe magliette con le scritte spiritose, aggeggi tecnologici che invecchiano con una fretta inspiegabile e spaventosa. «Non tutto risiede nei soldi» lo ammonisce sua madre. Quell’appartamento, il terrazzo, tre o quattro piante di ibisco sono più che sufficienti, o almeno potrebbero esserlo.
Vladimir Tasić, Il muro di vetro
Un gatto curiosa in giardino, passa spesso di qui. La bestiola non immagina di suscitare un’emozione nella donna che sta alla finestra della cucina, reminiscenza profonda di un tempo primordiale, di animali selvatici nella savana. Tra il fogliame dipinto di colori autunnali si intravede un manto tigrato, una delizia per i suoi occhi. Una sottile tensione in questa donna di città, un brivido di benessere dietro il doppio vetro. Ecco il gatto che torna. Sembra in costante perlustrazione. Adesso punta dritto verso oriente. Al di sopra delle chiome degli alberi che scolorano appare l’Esja, che sua madre trovava più bella dei monti a sud. Una scultura poderosa, cangiante, cosparsa d’ombre. Una salda zavorra che ricorda la musica di Bach.
Halldóra Thoroddsen, Doppio vetro
Avevo otto anni quando la casa è precipitata nel silenzio. Sotto il ventilatore d’appoggio appeso al muro bianco della sala da pranzo, c’era un blocco con trecentosessantacinque fogli incollato su un grande cartoncino rigido color rosso vivo. Ogni foglio indicava l’anno, il mese, il giorno della settimana e due date: una secondo il calendario solare e l’altra secondo quello lunare. Non appena sono stata in grado di arrampicarmi su una sedia, mi hanno concesso il piacere di staccarne una pagina al risveglio. Ero la custode del tempo. Quando i miei fratelli maggiori Long e Lộc hanno compiuto diciassette anni, ho perso questo privilegio. Dal giorno di quel compleanno, che non abbiamo festeggiato, tutte le mattine mia madre piangeva davanti al calendario. Avevo l’impressione che, strappando la pagina del giorno, si lacerasse anche lei.
Kim Thúy, Il mio Vietnam
Ebbe inizio in biblioteca. Mentre il giovane aspettava in silenzio che qualcuno si occupasse di lui io me ne stavo immobile, schiava del mondo fuori dalla finestra. La stagione del momijigari volgeva al termine: le foglie cadevano dai rami fitte come raffiche di neve. Le capinere mangiavano gli alberi, colpivano la corteccia col becco per poi masticarla rapidamente in quell’annuale e parodistica esibizione di appetito che ho sempre trovato volgare. Quando mi voltai lui si schiarì la voce e mi chiese una tessera.
Jennifer Tseng, Mayumi e il mare della felicità
Lish era una veterana ben prima che scoppiasse il casino con il Serenity Place. Aveva quattro figlie, due avute con lo stesso uomo e le altre due, gemelle, con un artista di strada spensierato che si era innamorato delle sue mani. Perfette per le palle, aveva detto, per palleggiarle in aria, intendo. I giocolieri non scherzano mai sulle palle, mi spiegava Lish, ecco il punto. Lish ne sapeva a pacchi di teatro, di come accogliere il pubblico, di come attrarlo, di coreografia e conduzione, delle superstizioni della gente di teatro. Aveva sempre amato il palcoscenico. O la strada, o dovunque si faccia uno spettacolo. Aveva conosciuto il giocoliere nella sala riunioni dell’albergo dove alloggiavano tutti gli artisti. Fare volontariato, per Lish, era un buon modo per frequentare gente di teatro senza violare le regole del welfare, ed era un piacevole diversivo dalle bambine. Questo busker, padre assente delle gemelle, aveva detto a Lish che l’amava e le aveva proposto di vivere per la strada insieme a lui. Le avrebbe insegnato a mangiare il fuoco, a lanciare coltelli, a camminare sui trampoli. Le aveva mostrato un ritaglio di giornale su di lui, dal «Miami Herald», si intitolava “Magia, musica e follia”, poi c’era una foto di lui che spezzava una catena con il torace. Proprio come Zampanò nella Strada, aveva detto. Lish era euforica per la proposta e per i superalcolici offerti nella sala dell’albergo, e aveva accettato di seguirlo per la strada, a condizione di poter portare le sue figlie, che all’epoca erano due. “Nessun problema, nessun problema” aveva risposto lui “raccoglieremo più soldi” e poi aveva fatto sparire un fazzoletto rosso nel naso di Lish. E poi, naturalmente, riapparire. Cosa che lui invece aveva mancato di fare dopo aver messo Lish incinta quella notte nella sua camera d’albergo, mentre le bellissime, lunghe mani di lei accarezzavano la sua schiena lucida, e la calda notte d’estate diventava bollente.
Miriam Toews, La mia estate fortunata
Algren era la città più piccola del Canada. Proprio così. La città più piccola del Canada. Era scritto a chiare lettere su un vecchio cartello appena fuori del confine urbano e quando knute aveva controllato presso uno di quegli uffici che si trovano sulle pagine azzurre, le era stato detto che millecinquecento è il numero minimo di abitanti che deve avere una città. E tanti ne aveva Algren. Ne avesse avuto uno in meno sarebbe stata un paese e anche solo uno in più sarebbe stata una città più grande. Al pari di ogni altra piccola città, del resto. Essere la più piccola costituiva il suo diritto alla celebrità. Knute era venuta ad Algren da Winnipeg per occuparsi di suo padre, che aveva avuto un infarto. E per dare il cambio alla madre, la quale diceva che se avesse trascorso un giorno in più in quella casa sarebbe diventata matta. Knute aveva ventiquattro anni.
Miriam Toews, Un tipo a posto
Mmm, e così butta male. Qualche settimana fa in piena notte ricevo una telefonata a carico di mia nipote Thebes: le serve aiuto, per favore, con min. Dice che ci ha provato a tenere botta ma non ce n’è. Min è inchiodata a letto, tira avanti a siluretti blu, convinta che un milione di automobili metallizzate stiano per piombare su di lei (buio totale su cosa mai intendesse Thebes), Logan passava guai a scuola per via di certe storie inquietanti che scriveva, Thebes si era spacciata per Min al telefono con il preside, la casa cadeva a pezzi, la controporta del cortile era volata via, una famiglia di topi feroci si era installata dietro il pianoforte, i vicini erano stufi di ritrovarsi asce in cortile ogni due per tre, (ancora qualcosa di incomprensibile in cui c’entrava Logan) … in sostanza, le cose stavano sfuggendo di mano. E Thebes ha soltanto undici anni.
Miriam Toews, In fuga con la zia
Portarono via la nostra casa sul pianale di un camion un pomeriggio di fine estate del 1979. In strada, i miei genitori, mia sorella maggiore e io la guardammo scomparire, un basso bungalow di legno, mattoni e gesso che si allontanava lento su First Street, superava l’A&W e il Deluxe Bowling Lanes per poi imboccare la statale 12, dove finimmo col perderlo di vista. Lo vedo ancora, continuava a ripetere mia sorella Elfrieda, finchè a un certo punto non lo vide più. Lo vedo ancora. Lo vedo ancora. Lo vedo… Ok, no, è andato, disse.
Miriam Toews, I miei piccoli dispiaceri
Abito con mio padre, Ray Nickel, in quella casa di mattoni a un piano sulla statale dodici. Persiane azzurre, porta marrone, una finestra rotta. Niente di che. I mobili continuano a sparire, però. E’ l’unica cosa interessante. Manca metà della famiglia, la metà più bella. Io e Ray ci alziamo la mattina e facciamo svariate cose finché è ora di andare a dormire. Tutte le sacrosante sere verso le dieci Ray mi comunica che lui va a far riposare le ossa. Prima di entrare in camera da letto si ferma nell’ingresso e piazza dei foglietti sopra le sue scarpe per ricordarsi quello che deve fare il giorno dopo. Ci piace guardare insieme l’aurora boreale. Gli ho riferito, parola per parola, quello che ci ha spiegato il professor Quiring in classe. Su come funziona il fenomeno. Lui ha trovato la spegazione abbastanza interessante. Ha sempre avuto un certo interesse per le opinioni di Quiring, probabilmente perchè è un insegnante anche lui.
Miriam Toews, Un complicato atto d’amore
Jorge ha detto che non sarebbe tornato finché non imparavo a essere una moglie migliore. Ha detto che quando dormiamo posso toccarlo con un braccio, una gamba o un piede, purché siano puliti, ma non stargli appiccicata addosso come una seconda pelle. Gli ho chiesto come faceva a dire una cosa simile dato che non lo vedevo quasi più ormai e lui ha detto questo è un bene per te. Ha detto che nessuno dice mai la verità quando deve spiegare i motivi per cui ha deciso d’andarsene e dunque che differenza fa? Io mi sono messa nel vano della porta per impedirgli di uscire e l’ho implorato di non andar via. Lui ha posato le mani sulle mie spalle e poi mi ha sfregato le braccia come per scaldarmi e io gli ho messo le mani sui fianchi. Gli ho chiesto come avrei fatto a diventare una buona moglie se non avevo un marito con cui far pratica e lui ha detto che erano proprio le domande come questa ad alimentare la mia solitudine. Gli ho chiesto perché cercava di confondermi con delle risposte che servivano solo a classificare le mie domande e come mai era diventato così strano da qualche tempo in qua e da dove era saltato fuori questo problema riguardo al mio modo di dormire con una gamba sulla sua e cos’aveva da andarsene sempre via e perché cercava a ogni costo di fare il duro invece di limitarsi a essere se stesso e allora lui mi ha tirato a sé e mi ha chiesto di smetterla di parlare, per favore, di smetterla di tremare, di smetterla di bloccare la porta, di smetterla di piangere e di smetterla di amarlo.
Miriam Toews, Mi chiamo Irma Voth







Tutte le famiglie felici si assomigliano fra loro, ogni famiglia infelice è infelice a modo suo. Tutto era sossopra in casa degli Oblonskije. La moglie era venuta a sapere che il marito aveva avuto un legame con una governante francese ch’era stata in casa loro, e aveva dichiarato al marito che non poteva vivere con lui nella stessa casa. Questa situazione durava già da tre giorni ed era sentita tormentosamente e dagli stessi coniugi, e da tutti i membri della famiglia, e dai familiari.
Lev Tolstoj, Anna Karenina
Jorge ha detto che non sarebbe tornato finché non imparavo a essere una moglie migliore. Ha detto che quando dormiamo posso toccarlo con un braccio, una gamba o un piede, purché siano puliti, ma non stargli appiccicata addosso come una seconda pelle. Gli ho chiesto come faceva a dire una cosa simile dato che non lo vedevo quasi più ormai e lui ha detto questo è un bene per te. Ha detto che nessuno dice mai la verità quando deve spiegare i motivi per cui ha deciso d’andarsene e dunque che differenza fa? Io mi sono messa nel vano della porta per impedirgli di uscire e l’ho implorato di non andar via. Lui ha posato le mani sulle mie spalle e poi mi ha sfregato le braccia come per scaldarmi e io gli ho messo le mani sui fianchi. Gli ho chiesto come avrei fatto a diventare una buona moglie se non avevo un marito con cui far pratica e lui ha detto che erano proprio le domande come questa ad alimentare la mia solitudine. Gli ho chiesto perché cercava di confondermi con delle risposte che servivano solo a classificare le mie domande e come mai era diventato così strano da qualche tempo in qua e da dove era saltato fuori questo problema riguardo al mio modo di dormire con una gamba sulla sua e cos’aveva da andarsene sempre via e perché cercava a ogni costo di fare il duro invece di limitarsi a essere se stesso e allora lui mi ha tirato a sé e mi ha chiesto di smetterla di parlare, per favore, di smetterla di tremare, di smetterla di bloccare la porta, di smetterla di piangere e di smetterla di amarlo.
Miriam Toews, Mi chiamo Irma Voth
Dentro non si vede niente. Si solleva sulle punte, appiccica il naso al vetro per sbirciare al di sopra della tenda, appesa a metà finestra. Tra i rigogliosi cespi di gerani che di solito pendono all’esterno e oggi, per motivi incomprensibili, sono intrappolati dietro i vetri, è tutto buio. Ma è quasi sempre così. Attraverso quelle finestrelle la luce filtra in casa solo nelle giornate di sole. Si gira a guardare la strada. Surmena si trascina quasi, ha sempre fatto fatica a camminare e Jakub non le agevola certo il compito. È pesante e Dora lo sa bene, ormai lei stessa riesce a portarlo in braccio a malapena. Torna a voltarsi verso la finestra, le sembra di vedere delle gambe. Spuntano da dietro la stufa, solo dalle ginocchia in giù, ma sono due gambe di sicuro, e calzano dei pesanti stivali neri.
Kateřina Tučková, L’eredità delle dee
Qui è la Cina comunista. Io la Cina non l’ho mai vista, ma penso che sia un posto proprio come il nostro quartiere. Anzi, no. È il nostro quartiere ad essere come la Cina, strapieno di gente. Dicono che nelle strade della Cina non si vedono animali. Solo esseri umani. Ovunque. Allora il nostro quartiere è un po’ meglio della Cina. Almeno abbiamo un gatto randagio sdraiato sul muretto del cortile, e sembra che quelli del terzo piano allevino un pappagallo. All’inizio della strada c’è anche un negozio che vende uccelli. Quando ci siamo trasferiti in questa casa, ho deciso che dovevo amare questo posto. Senza questa decisione, difficilmente sarei riuscita a farmelo piacere. C’era un chiasso tremendo e il primo giorno, forse per farci conoscere meglio l’ambiente, il signor Hashemi si è messo a picchiare la figlia quattordicenne urlandole addosso, in un miscuglio di lingue, insulti che rotolavano giù come sassi. Mia madre dice: – Il vostro quartiere è come un rispostiglio. Dentro ci trovi di tutto -. Ha ragione. In strada c’è ogni ben di Dio e ci sono tanti di quei forni e negozi di alimentari che all’inizio non sapevo come fare per comprare da uno senza offendere gli altri. Per non parlare dei negozi di frutta e verdura! A dare un duro colpo al mio amore, però, ci pensano i marciapiedi, talmente stretti che non si riesce nemmeno a camminare fianco a fianco: bisogna per forza andare uno avanti e uno dietro, avanzare in fretta oppure cedere il passo. Se guardi in basso, vedi solo macchie. I marciapiedi sono pieni di macchie: macchie d’acqua, di sputo, di olio, di verdura spiaccicata. Gli studenti di psicologia potrebbero usarle per i loro studi sull’inconscio umano.
Fariba Vafi, Come un uccello in volo
Aprì gli occhi alle quattro del mattino e pensò: “Oggi inizi a cambiare il mondo, Florita”. Non era intimorita dalla prospettiva di mettere in moto la macchina che in qualche anno avrebbe trasformato l’umanità, facendo scomparire l’ingiustizia. Si sentiva tranquilla, con le forze necessarie ad affrontare gli ostacoli che avrebbe trovato sulla propria strada.
Mario Vargas Llosa, Il paradiso è altrove
Quella fu un’estate favolosa. Venne Pérez Prado con la sua orchestra di dodici professori ad animare i balli di carnevale del Club Terrazas de Miraflores e del Lawn Tennis di Lima, fu organizzato un campionato nazionale di mambo in plaza de Acho, che ottenne un grande successo malgrado la minaccia del cardinale Juan Gualberto Guevara, arcivescovo di Lima, di scomunicare tutte le coppie che vi avessero partecipato, e il mio quartiere, il Barrio Alegre delle strade miraflorine Diego Ferré, Juan Fanning e Colón, disputò olimpiadi di fulbito, di ciclismo, di atletica e di nuoto con il quartiere di calle San Martín, che, naturalmente, vincemmo.
Mario Vargas Llosa, Avventure della ragazza cattiva
Di nuovo sul luogo del delitto, disse a se stesso. Se i pensieri fossero visibili, sarebbe un inferno! Lei era seduta accanto a lui. Pensierosa e assente. Il taxi svoltò nella ripida via Mikó, in direzione della fortezza. Le chiome appena fiorite degli alberi con la loro ombra proteggevano dal sole insolitamente caldo di aprile. «Qui da qualche parte ha vissuto Sándor Márai» disse lui pentendosi subito per aver pronunciato quella frase. Lei gli rivolse uno sguardo tagliente. «E allora? Chi sarebbe questo Sándor Márai?» «Uno scrittore ungherese …» «Non giapponese?» «Sì, fa’ la spiritosa! Due, anzi tre anni fa, ti ho dato da leggere il suo diario …» «Ah sì, me lo ricordo, un seccatore pazzesco. Uno simile a te, che ogni primo del mese sparisce da qualche parte, senza mai costruire nulla di concreto. Proprio come te!» «Non esagerare» rispose lui meccanicamente, pur sapendo che lei aveva ragione. Il taxi superò la salita e svoltò prima a destra, poi a sinistra passando davanti a una schiera di case con dei gerani alle finestre, seguite da ristoranti, caffè, negozi di souvenir. Attraverso gli ampi portoni si intravedevano i cortili interni. Il suo sguardo divorava ogni dettaglio. Marija percepiva la sua eccitazione. Era così ogni volta che arrivavano da qualche parte. Poteva persino indovinare i suoi pensieri: “Come sarebbe bello rifugiarsi in questo sogno, sprofondare in quel groviglio di magia e banalità, per sempre”.
Dragan Velikić, Bonavia
Il quartiere Trieste di Roma è, si può ben dire, un centro di questa storia dai molti altri centri. È un quartiere che ha sempre oscillato tra l’eleganza e la decadenza, tra il lusso e la mediocrità, tra il privilegio e l’ordinarietà, e per adesso tanto basti: inutile descriverlo oltre, perché una sua descrizione potrebbe risultare noiosa, all’inizio della storia, addirittura controproducente. Del resto, la migliore descrizione che si può dare di qualunque posto è raccontare cosa vi succede, e qui sta per succedere qualcosa di importante.
Mettiamola così: una delle cose che succedono in questa storia dalle molte altre storie succede nel quartiere Trieste, a Roma, in una mattina di metà ottobre del 1999, in particolare all’angolo tra via Chiana e via Reno, al primo piano di uno di quei palazzi che appunto non staremo qui a descrivere, dove sono già successe migliaia di altre cose. Solo che la cosa che sta per accadervi è decisiva e, si può ben dire, potenzialmente esiziale per la vita del protagonista di questa storia. Dott. Marco Carrera, dice la targa apposta sulla porta del suo ambulatorio, specialista in oculistica e oftalmologia – quella porta che ancora per poco lo separa dal momento più critico della sua vita dai molti altri momenti critici.
Sandro Veronesi, Il colibrì
È il paese dove non si muore mai. Fortificati da interminabili ore passate a tavola, annaffiati dal rachi, disinfettati dal peperoncino delle immancabili olive untuose, qui i corpi raggiungono una robustezza che sfida tutte le prove. La colonna vertebrale è di ferro. La puoi utilizzare come ti pare. Se capita un guasto, ci si può sempre arrangiare. Il cuore, quanto a lui, può ingrassare, necrosarsi, può subire un infarto, una trombosi e non so cos’altro, ma tiene maestosamente. Siamo in Albania, qui non si scherza. Di polvere e fango è fatto questo paese; il sole brucia a tal punto che le foglie della vigna si arrugginiscono e la ragione comincia a liquefarsi. Da ciò nasce una specie d’effetto secondario (temo irrimediabile): la megalomania, delirio che in questa flora germoglia come un’erba pazza. Da ciò anche l’assenza di paura – a meno che questa non sia dovuta alla forma del cranio storto e piatto, dimora regale dell’insofferenza, se non dell’incoscienza.
Ornela Vorpsi, Il paese dove non si muore mai
Ci sono canzoni che nascono dall’erba punteggiata d’azzurro, dalla polvere di migliaia di strade di campagna. Questa ne incarna la poesia. È un tardo pomeriggio dell’autunno del 1989, io sono seduto alla mia scrivania, guardando il cursore che ammicca sul video del computer davanti a me, quando squilla il telefono. All’altro capo del filo c’è un ex abitante dell’Iowa, di nome Michael Johnson, che ora vive in Florida. Un amico gli ha inviato uno dei miei libri. Michael Johnson l’ha letto, l’ha letto anche sua sorella Carolyn, e hanno da propormi una storia che credono possa interessarmi.
Robert James Waller, I ponti di Madison County
Nessun cliente al caffè, quella mattina. Lui era stato il primo. Portava un cappello marrone da pescatore, che entrando non aveva avuto il tempo di togliersi, quasi sconvolto dal fatto che lì dentro ci fossi solo io, che il bar fosse gestito unicamente da me, senza nemmeno un aiutante. Si era dunque sistemato in qualche modo sulla sedia accanto alla porta, sempre col cappello in testa, lo sguardo fisso sulla bicicletta da cui era appena sceso. Il tutto aveva qualcosa di irreale, poi un colpo di vento aveva fatto tremare il vetro della finestra, come quando c’è il terremoto. In quel silenzio non interrotto da un’ordinazione né da una conversazione, come un automa presi una tazza. Dopo il breve gracchiare della macchina macinacaffè, il bar ripiombò in un silenzio mortale. Ne bevve sì e no mezza tazza e si alzò. Pur di non sentirgli dire niente né vederlo pagare il conto, mi spinsi fuori fino all’incrocio, aspettando che uscisse. Dopo un bel po’ ancora non spuntava. Mi voltai a guardare e mi accorsi che era uscito dalla porta a vetri, ma si era seduto sul bordo della fioriera davanti all’ingresso e fumava avidamente una sigaretta ormai consumata fino al filtro, con una foga tale che le guance gli si erano incavate, e tirava disperato come un giocatore che abbia perso tutto ma non voglia mollare.
Ting-Kuo Wang, Il ciliegio del mio nemico
China si è rivoltata contro se stessa. Se non lo sapessi, penserei che sta cercando di mordersi le zampe. Penserei che è impazzita. E lo è, in un certo senso. Non si lascia toccare da nessuno a parte Skeet. Quando era una cucciola di pitbull con un gran testone, rubava tutte le scarpe che trovava in casa, le scarpe da tennis nere che ci comprava mamma perché tengono bene lo sporco e resistono a lungo prima di sfasciarsi. Di diverso c’erano solo i sandali lasciati da lei, col tacco sottile e macchiati di rosa per tutto il fango rosso che avevano assorbito. China nascondeva scarpe e sandali sotto i mobili, dietro il water, poi li ammucchiava uno sull’altro e ci dormiva sopra. Quando è cresciuta abbastanza per correre e trotterellare giù per i gradini da sola, ha cominciato a portarle fuori, le scarpe, e a infilarle nei canaletti di scolo sotto la casa. Se provavamo a portargliele via, lei si piazzava davanti, rigida come un palo. Adesso per China è arrivato il momento di dare invece di prendere, di offrire e non di rubare. Sta partorendo.
Jesmyn Ward, Salvare le ossa


Io lo so com’è la morte, almeno credo. È qualcosa che potrei guardare in faccio: almeno credo. Quando Pop mi dice che gli serve il mio aiuto e vedo quel suo coltello nero infilato nella cintura dei pantaloni, lo seguo fuori di casa, e cerco di tenere la schiena dritta, le spalle aperte come un attaccapanni: è così che cammina Pop. Faccio finta sia tutto normale, quasi noioso, così Pop penserà che questi tredici anni me li sono guadagnati, così Pop penserà che sono pronto a fare quello che bisogna fare, separare le budella dai muscoli, gli organi dalle cavità. Pop deve sapere che posso coprirmi di sangue. Oggi è il mio compleanno. Tengo la porta così non sbatte, la accompagno piano verso il montante. Non voglio che Mam o Kayla si sveglino mentre non c’è nessuno in casa. Meglio se dormono. Meglio se mia sorella Kayla dorme, perché è piccola e le sere che Leonie va a lavorare si sveglia ogni ora, si mette a sedere sul letto e urla. Meglio se nonna Mam dorme, perché la chemio l’ha prosciugata e svuotata come fanno il sole e l’aria alle querce d’acqua.
Jesmyn Ward, Canta, spirito, canta

Il fiume era giovane e smilzo. Al principio affiorava dalla rossa terra argillosa tra i boschi di pini del Mississipi, e poi si snodava, bruno e lento, sopra un letto di minuscoli ciottoli grigi e ocra, in mezzo agli alberi, non più alto di una mano, profondo come tre uomini in piedi l’uno sull’altro, fino alle pianure verdi e sabbiose del golfo del Messico. Avanzava strisciando, ampio e stretto, attraversato da ponticelli di legno e cemento, orlato di sottili frammenti di spiaggia bianca, dentro e fuori dai boschi, prima di dividersi nel bayou e svuotarsi nel mare. Verso la fine del suo corso, su uno di questi ponti, ritti là dove si inarcava, c’erano due adolescenti, gemelli. Scavalcato il parapetto, si tenevano aggrappati al metallo caldo e sudato alle loro spalle. Sotto di loro, l’acqua del fiume Wolf era scura e profonda, attraversata dalla corrente. Si preparavano a saltare.
Jesmyn Ward, La linea del sangue
La prima volta che Caesar propose a Cora di scappare al Nord, lei disse di no. Era sua nonna a parlare. La nonna di Cora non aveva mai visto il mare prima di quel pomeriggio di sole nel porto di Ouidah, e dopo tutto il tempo passato nelle segrete del forte l’acqua le abbagliò la vista. Li avevano tenuti nelle segrete fino a quando non erano arrivate le navi. I predoni del Dahomey avevano rapito prima gli uomini, poi erano tornati nel suo villaggio, alla luna successiva, per prendere le donne e i bambini, facendoli marciare a due a due in catene fino al mare. Mentre fissava l’imbocco buio della segreta, Ajarry pensò che laggiù nell’oscurità avrebbe ritrovato suo padre. I sopravvissuti del villaggio le dissero che, siccome il padre non riusciva a tenere il passo durante le lunghe marce, i mercanti di schiavi gli avevano spaccato la testa e avevano lasciato il cadavere lungo il sentiero.
Colson Whitehead, La ferrovia sotterranea
Mio padre era un comunista. Non era sempre stato comunista, certo che no, e quando morì non lo era più. A guardar bene restò iscritto al Partito comunista solo per pochi anni, dal 1944 al 1950 circa. Dopo, la sua indignazione travalicò i confini di partito e investì tutti i politici indistintamente, o quasi tutti. “Rintronati! Cretini! Assassini!” – Il Comunismo non glielo avevano instillato sin dalla culla. Suo padre lesse per tutta la vita un unico libro, la Bibbia (sua madre conosceva solo per sentito dire persino quella), e la politica non gli interessava, se si esclude una vaga infatuazione per l’imperatore Guglielmo II. E in effetti a dieci anni mio padre andò in caserma con suo padre, sul campo di esercitazione retrostante, perchè l’imperatore di tutti i tedeschi, facendo visita allo stato vicino e alla sua città più bella, avrebbe assistito a una parata delle truppe locali.
Urs Widmer, Il libro di mio padre
Il grande amore di mia madre è morto oggi. Era una vecchia quercia, sano fino al midollo anche in punto di morte. È crollato per terra mentre sfogliava, chino sul leggio, una pagina della Sinfonia in Sol minore di Mozart. Quando lo hanno trovato, stringeva nella mano rigida un brandello della partitura, gli squilli dei corni all’inizio dell’Adagio. Una volta aveva detto a mia madre che la Sinfonia in Sol minoreè il più bel brano musicale mai composto. – Leggeva da sempre le partiture come altri leggono i libri. Di qualsiasi opera gli capitasse tra le mani, arcaica o frivola che fosse. Ma soprattutto andava a caccia del nuovo. Solo in età avanzata, verso i novant’anni, sentì il bisogno di rivivere un’altra volta quel che già conosceva, in modo diverso, alla luce di un sole che si andava spegnendo. Rilesse dunque il Don Giovanni che aveva divorato con occhi affamati da ragazzino, e La creazione. – Era musicista, direttore d’orchestra. Tre giorni prima di morire aveva diretto il suo ultimo concerto alla Stadt-halle. György Ligeti, Bartók, Conrad Beck. – Mia madre lo ha amato per tutta la vita. Né lui né gli altri se ne sono mai accorti. Nessuno sapeva della sua passione, lei non ne fece mai parola. «Edwin» sussurrava però in riva al lago da sola, con il suo bambino per mano. Circondata da anatre starnazzanti sulla sponda in ombra, guardava la riva opposta, splendente di sole. «Edwin». Il direttore d’orchestra si chiamava Edwin.
Urs Widmer, Il grande amore di mia madre
William Stoner si iscrisse all’Università del Missouri nel 1910, all’età di diciannove anni. Otto anni dopo, al culmine della prima guerra mondiale, gli fu conferito il dottorato in Filosofia e ottenne un incarico presso la stessa università, dove restò a insegnare fino alla sua morte, nel 1956. Non superò mai il grado di ricercatore, e pochi studenti, dopo aver frequentato i suoi corsi, serbarono di lui un ricordo nitido. Quando morì, i colleghi donarono alla biblioteca dell’università un manoscritto medievale, in segno di ricordo. Il manoscritto si trova ancora oggi nella sezione dei “Libri rari”, con la dedica: “Donato alla biblioteca dell’Università del Missouri in memoria di William Stoner, dipartimento di Inglese. I suoi colleghi”.
John Williams, Stoner
In questo sogno in cui era senza peso né vita, in cui era un velo di coscienza diffuso che vibrava e fremeva in una vasta distesa di tenebre, dapprima non sentiva nulla, se non un’oscura specie di appercezione, priva di vista e d’intelletto, e remota, in grado solo di distinguere tra sè e il buio. Poi una consapevolezza più decisa cominciava a farsi strada in lui, una sorta di gratitudine per la forma insensibile che aveva in sogno. Senza riuscire a esprimerlo con parole o pensieri, la cosa gli piaceva talmente che, potendo scegliere, sarebbe rimasto per sempre in quell’oscuro ventre di non essere.
John Williams, nulla, solo la notte
Mi spaventò all’alba di ogni giorno, nell’estate che trascorsi con lei. Si sedeva sul bordo del letto, i lunghi capelli sciolti, sciolti fino a terra e ondeggianti mentre li spazzolava senza posa, e nella stanza si ritiravano le ombre e dalle due finestre fluiva la prima luce. I capelli erano lunghi come la sua storia e non avrebbe potuto camminare se non li avesse raccolti in folte trecce e fissati attorno e in cima alla testa con degli spilloni. Altrimenti avrebbero spazzato il pavimento come lo strascico di una veste medievale, e le sarebbe toccato radunarli in un fascio e avvolgerli più volte al braccio per non inciampare. Era nata contadina, poi aveva lavorato per mezzo secolo come cameriera, dunque non avrebbe potuto dormire dopo l’alba nemmeno per scommessa, e ogni mattina che passai con lei alla prima luce si metteva a sedere e spazzolava i suoi lunghi capelli da strega, li spazzolava a ciocche, più e più volte, lisciando quei capelli che da decenni non vedevano un paio di forbici, e da cui non si sarebbe separata nonostante l’assurdità di tempo che ogni giorno le serviva per tenerli in ordine.
Daniel Woodrell, La versione della cameriera
Notte di emicrania e cassa toracica che a ogni respiro si abbatteva sui polmoni chiamando in causa muscoli intercostali già provati, notte di gola vetrificata dall’aria fredda e secca, naso tappato, tipica notte in bianco all’Austrian Hit, 4790 metri sul livello del mare. Cecilia e Roberto non hanno dormito meglio di me, come già nelle nottate precedenti, all’Old Moses e allo Shipton Camp.
Alle quattro sono uscito per svuotare la vescica e il cielo era come dicono tutti, un marasma primordiale di stelle e nebulose: la Croce del Sud, il Centauro, il Cane maggiore, i Gemelli … La striscia della Via Lattea, gambe piene di acido lattico, vento gelido a frustare la nuca.
Wu Ming 1/Roberto Santachiara, Point Lenana
e noi nell’ultima guerra abbiamo perso un amante. Avevamo un amante, e da quando è cominciata la guerra non lo si trova più, è sparito. Lui e la vecchia “Morris” di sua nonna. Da allora sono passati già più di sei mesi, e di lui non abbiamo saputo più nulla. Noi diciamo sempre: questo è un paese piccolo, una specie di grande famiglia, se uno ci si mette può scoprire legami persino tra le persone più lontane – e invece, come se si fosse spalancato un abisso, una persona è scomparsa senza lasciare traccia, e tutte le ricerche sono state inutili. Se fossi sicuro che è rimasto ucciso, rinuncerei. Che diritto abbiamo noi di ostinarci per un amante ucciso, quando c’è gente che ha perso tutto quello che aveva di più caro – figli, padri e mariti?
Abraham Yehoshua, L’amante
Ora la ferita era pronta per la sutura. L’anestesista si tolse impaziente la mascherina, e come se non gli bastasse più il grande respiratore con le sue cifre lampeggianti in continua mutazione, si alzò, prese con delicatezza la mano inerte per sentire il polso e poi sorrise con simpatia verso la donna nuda e dormiente, e mi strizzò l’occhio. Io feci finta di nulla: stavo fissando il professor Hishin per cercare di capire se aveva intenzione di ricucire da solo o avrebbe lasciato finire uno di noi. Tremai pensando che mi mettessero da parte ancora una volta per affidare il lavoro al mio rivale, l’altro medico che si stava specializzando.
Abraham Yehoshua, Ritorno dall’India
Nonostante il responsabile delle risorse umane non si fosse cercato questa missione, adesso, nella luce soffusa e radiosa del mattino, ne capiva il significato sorprendente. E quando, accanto al falò ormai moribondo, gli era stata tradotta – e aveva compreso – la richiesta incredibile della vecchia in abito da monaca, aveva provato un fremito di gioia e la Gerusalemme tormentata e ferita da cui era partito una settimana prima gli era riapparsa in tutto il suo splendore: quello dei giorni dell’infanzia.
Abraham Yehoshua, Il responsabile delle risorse umane
Mio caro Marco, Sono andato stamattina dal mio medico, Ermogene, recentemente rientrato in Villa da un lungo viaggio in Asia. Bisognava che mi visitasse a digiuno ed eravamo d’accordo per incontrarci di primo mattino. Ho deposto mantello e tunica; mi sono adagiato sul letto. Ti risparmio particolari che sarebbero altrettanto sgradevoli per te quanto lo sono per me, e la descrizione del corpo d’un uomo che s’inoltra negli anni ed è vicino a morire di un’idropisia del cuore. Diciamo solo che ho tossito, respirato, trattenuto il fiato, secondo le indicazioni di Ermogene, allarmato suo malgrado per la rapidità dei progressi del male, pronto ad attribuirne la colpa al giovane Giolla, che m’ha curato in sua assenza. È difficile rimanere imperatore in presenza di un medico; difficile anche conservare la propria essenza umana; l’occhio del medico non vede in me che un aggregato di umori, povero amalgama di linfa e di sangue. E per la prima volta, stamane, m’è venuto in mente che il mio corpo, compagno fedele, amico sicuro e a me noto più dell’anima, è solo un mostro subdolo che finirà per divorare il padrone.
Marguerite Yourcenar, Memorie di Adriano
Ti dicono Mita e io ti dico mami. Sei così tanto bella e tanto mia. Conosco i tuoi capelli, sono castani e a volte brillano di rosso. Succede quando su di essi splende il sole. Conosco la tua pelle, la forma dei denti e della bocca e le linee sul palmo delle tue mani. So come respiri e come ti gonfia la vena del collo quando ridi a voce alta. E conosco i tuoi occhi, tutti i tuoi occhi. So quale è il disegno della tua borsetta che a volte prendo in prestito davanti allo specchio, e come sono le tue scarpe, che mi metto in quel momento. So come sono fatti i tuoi bigodini e qual è la sfumatura di azzurro sul casco asciugacapelli sotto il quale siedi ogni domenica sera, mentre ci facciamo il bagno, uno dopo l’altro, tutti noi. Io me lo faccio per prima, Rok deve farlo per secondo perché è mio fratello e perché è stato a lungo un lattante e con lui non era possibile fare a gara. Con lui per tanto tempo non si poteva neanche giocare. Potevo solo adagiarlo su un tavolo e giocare al dottore. Gli toglievo i pantaloni e frugavo cercando il suo pisellino. A volte chiamavo anche la vicina Lina perché guardasse anche lei il pisellino, visto che suo fratello, che era pure un lattante, non glielo lasciava fare.
Bronja Žakelj, Il bianco si lava a novanta
La violenza inaudita della pioggia torrenziale risuonava sul tetto in lamiera della precaria sistemazione che avevamo trovato a poca distanza dalla riva del Lago Chini in Malesia. La corrente elettrica, in maniera beffarda, svaniva proprio quando ce n’era più bisogno, al calare del sole. La signora minuta, dagli occhi tristi e i modi gentili, prima di darci il lucchetto per chiudere la porta ci aveva messo in guardia. Non c’era molto da fare. E così ci mettemmo a parlare distesi su un letto scomodo avvolto dal buio totale. Eravamo ancora distanti dall’Australia ma le ultime settimane avevano rafforzato l’idea di raggiungere Melbourne come ipotizzato nove mesi prima, non era una chimera. “Sì, ce la possiamo fare.”
Paolo Zambon, Inseguendo le ombre dei colibrì
Matteo era a letto e stava sognando tra i presagi di un’alba che, appena iniziata, sembrava già finita. Spesso le sue notti erano percorse da incubi che lo terrorizzavano con minacce confuse. Talvolta aveva la sensazione di essere sbeffeggiato nel sonno. Dormire era uno dei pochi doveri al quale avrebbe voluto rinunciare – invidiava gli squali sempre in movimento, con il loro mezzo cervello a fare la guardia sull’altra metà che riposava silenziosa. Il sogno di quella mattina aveva qualcosa di tellurico: scosse superficiali increspavano acque scure, petrolifere, creando cerchi che si estendevano per chilometri e che infine lo investivano. Ogni tanto si fermavano, ma la quiete era solo l’attesa dell’onda successiva, come un conto alla rovescia.
Paolo Zardi, La passione secondo Matteo



