Addiaccio e tabarro stanno bene insieme, come due comparse silenziose della stessa scena. Entrambe appartengono a un mondo di passaggi, di soste provvisorie, di vite esposte. L’addiaccio è il fuori senza riparo, il tabarro è il minimo riparo possibile. Uno nomina l’assenza, l’altro la risposta. Sono parole nate per dire condizioni concrete, fisiche, prima ancora che sensazioni: la notte all’aperto, il viaggio, l’attesa, il muoversi leggeri. Portano con sé un lessico del camminare e del fermarsi, della necessità più che del comfort, e per questo oggi suonano lontane ma non inutili. Anzi: ci ricordano che la lingua, come chi la parla, si è formata anche lì, tra il cielo scoperto e una piega di stoffa sulle spalle.
Esaminiamole da vicino.
Addiaccio, /ad·diàc·cio/: s. m. [der. del lat. adiacēre «giacere accanto»]. Spazio cinto di rete nel quale il gregge è tenuto di notte allo scoperto. Stazionamento di truppe, di quadrupedi, di mezzi e materiali varî all’aperto e allo scoperto; per estensione, di persone in genere che dormono allo scoperto o sostano sotto il cielo della notte.
Ci sono parole che sembrano chiare a prima vista e invece giocano a nascondino. Addiaccio è una di quelle: ti guarda serio, con l’aria di chi parla di gelo, e intanto racconta tutt’altro.
L’inganno è comprensibile. Dormire all’addiaccio significa dormire all’aperto, e dormire all’aperto spesso vuol dire patire il freddo. Da lì il collegamento immediato col ghiaccio, rafforzato dal fatto che in alcuni vernacoli toscani diaccio è davvero una variante di ghiaccio. Insomma, l’equivoco ha ottime credenziali.
Eppure, se togliamo l’addiaccio dalla sua locuzione più famosa e lo guardiamo in faccia, scopriamo una storia diversa. Addiaccio non nasce per dire freddo. Nasce per dire assenza di riparo. L’immagine originaria è concreta, quasi pastorale: il recinto dove il gregge viene tenuto per la notte, senza tetto, esposto. Non il gelo, ma il cielo sopra la testa. Non la temperatura, ma la vulnerabilità.
È questo il cuore semantico della parola. Dormire all’addiaccio non significa necessariamente tremare. Significa dormire senza protezione. Può succedere in una sera d’estate, dopo aver perso l’ultimo treno. Può capitare durante una scalata, quando il tempo rallenta e costringe a fermarsi. Può essere una scelta tattica, come per le truppe che devono muoversi in fretta e rinunciano a montare il campo. Il freddo può esserci o no. L’addiaccio resta.
Ed è proprio per questa precisione che sarebbe un peccato lasciar scivolare via una parola così. Addiaccio dice in una sola mossa ciò che altrimenti richiederebbe un giro più lungo. Porta con sé un’immagine, una situazione, una postura nel mondo. È una parola che non alza la voce, ma sa indicare esattamente dove sei: fuori, esposto, senza ripari.
Tabarro è una parola che sembra uscita da un baule, con l’odore della lana e della strada addosso. La senti e vedi subito una figura avvolta, un passo lento, un bordo di stoffa che ondeggia. Ma anche qui, come spesso accade, vale la pena fermarsi un momento e guardare meglio.
Tabarro, /ta·bàr·ro/: s.m. [dal fr. ant. tabard (forse di origine germ.), da cui anche lo spagn. tabardo]. – Ampio e pesante mantello da uomo, indossato, nei secoli scorsi (e ancora talvolta nella Bassa Padana), sopra il cappotto o direttamente sopra l’abito. A Venezia, nel sec. 18°, designava in particolare un mantello portato dai nobili, di panno scuro o di scarlatto e di seta bianca nell’estate, tagliato in un rotondo perfetto, adottato anche dalle donne. Nell’uso antico e ancora in usi regionali e scherzosi, significa pastrano, cappotto da uomo molto pesante. Avete mai detto che per ripararvi dal freddo vi siete intabarrati? Beh, io sì.
Il tabarro non è un cappotto qualsiasi. È un indumento preciso, riconoscibile: ampio, pesante, senza maniche, spesso circolare, pensato per essere gettato sulle spalle e chiudere il corpo in un solo gesto. Un oggetto nato per stare fuori, per il viaggio, per l’attesa. Più che vestire, il tabarro copre.
L’etimologia che ho riportato ci porta lontano e non in linea retta. Il termine passa dal francese tabard, che indicava una sopravveste, a sua volta legato a voci germaniche. Nel medioevo il tabard era l’abito araldico, quello che mostrava i segni di appartenenza. Il tabarro, però, perde presto ogni funzione simbolica e resta ciò che è: pura utilità. Stoffa contro le condizioni avverse.
E qui arriva il punto interessante. Il tabarro non serve solo a scaldare. Serve a proteggere. Dal vento, dalla pioggia fine, dalla polvere, dallo sguardo. È un indumento che crea una soglia: chi lo indossa è un po’ dentro e un po’ fuori, separato ma non isolato. Per questo lo trovi addosso a contadini, viandanti, soldati, figure che stanno spesso in transito.
Oggi la parola sopravvive soprattutto nei testi letterari o storici, e a volte come vezzo stilistico. Ma funziona ancora benissimo, io stessa la uso. Dire tabarro non è dire “mantello” né “cappotto”. È evocare un certo modo di stare al mondo, raccolto e resistente. È dare peso e forma a un gesto antico, quello di avvolgersi quando il fuori diventa troppo. E poi si adatta benissimo ad un uso ironico, giocoso.
Che mi dite di questi due vocaboli? Vi piacciono? Li utilizzate? Sono curiosa di leggere i vostri commenti!

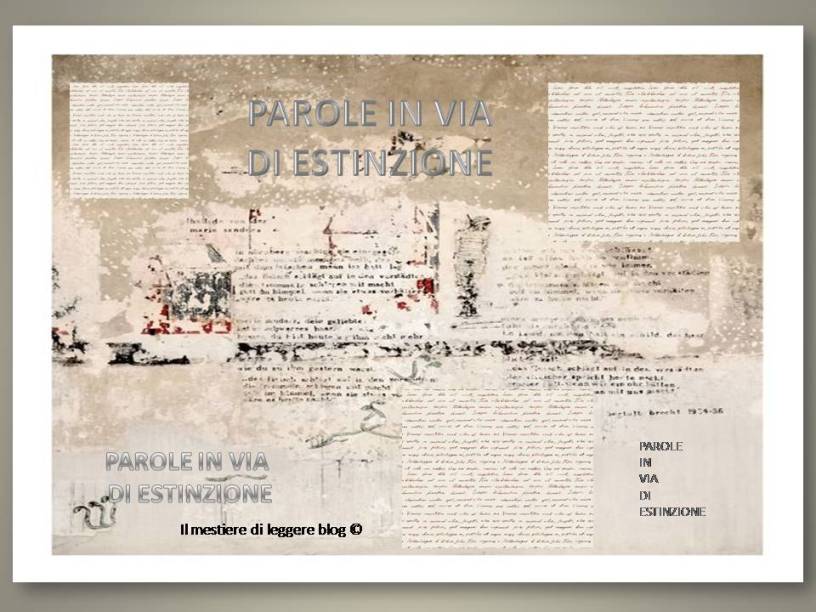

Addiaccio è usato spesso. Anche tabarro nell’accezione di “intabarrato”, nel senso di ben coperto
"Mi piace"Piace a 1 persona
Addiaccio lo sento più spesso in Toscana mentre intabarrato qui a Milano. Io li uso entrambi, mi piacciono 🫶
"Mi piace"Piace a 3 people
Anche in piemontese si usa intabarrato
"Mi piace"Piace a 1 persona
In uso, direi. Ma mi fai sorgere un timore: in uso come me, per me, ancora per poco (si fa per dire)
Ho portato per anni (erano i primi anni ’70) un tabarro (del bisnonno) nero, caldo, ruota intera, di cui ho perso “notizia” (consumato e gettato, temo). Lo adoravo.
In attesa di mia figlia, era perfetto!
"Mi piace"Piace a 3 people
Che bello!! Un vero tabarro 😍
"Mi piace"Piace a 1 persona
L’ideale col pancione!
"Mi piace"Piace a 1 persona
Perfetto!!
"Mi piace"Piace a 1 persona
Bello questo post! anche a me capita di sentire ancora il termine ‘addiaccio’, il secondo mai, tranne che non lo incontri nelle pagine di qualche classico, come hai già scritto tu. Sono vocaboli affascinanti, soprattutto il secondo, perchè evocano immediatamente immagini e realtà legate ad un tempo passato. Anche mio nonno abruzzese ne aveva conservato gelosamente uno, a me piaceva tanto quella stoffa pesante ma caldissima, che ormai non si trova più.
"Mi piace"Piace a 2 people
Ormai non se ne fanno più, chi lo dovesse avere ereditato dal nonno, deve tenerlo come un vero cimelio. Ora ci accontentiamo di evocarlo più in tono ironico che reale.
"Mi piace"Piace a 2 people
Eh no…queste le conosco e le frequento! Se non altro perché mio nonno ce l’aveva davvero il tabarro.
"Mi piace"Piace a 2 people
Il problema è che le nuove generazioni le conoscono poco e le frequentano ancora meno 😔
"Mi piace"Piace a 2 people
Ormai mi devo rassegnare a non esser più nuovissima! 😅
"Mi piace"Piace a 1 persona
O solo molto letteraria 😉
"Mi piace"Piace a 1 persona
😊
"Mi piace"Piace a 1 persona
Addiaccio non ha perso connotazione, tabarro a mia memoria non credo vada oltre a citazioni in romanzi del secolo scorso
"Mi piace"Piace a 1 persona
Stanno scivolando pericolosamente verso l’oblio
"Mi piace"Piace a 1 persona
Al solito… le uso piuttosto spesso.
"Mi piace"Piace a 1 persona
Meno male, teniamole in vita 💪🏻
"Mi piace"Piace a 1 persona
Addiaccio è in realtà un termine che utilizzo spesso, tabarro molto meno (ma “mi intabarro” parecchio di sovente😉), anche se forse dovrei: giusto ieri ho visto in giro per Cesena i pasquarelli, i gruppi di musicanti di strada che qui sono frequenti nel periodo dell’Epifania, e che portavano appunto un tabarro (tra le altre cose). E credo che il tabarro servisse a proteggere anche da qualche altra cosa: in tempi meno (apparentemente) pacifici dei nostri, poteva capitare che qualcuno sfoderasse la sua spada in mezzo alla strada; ed il mantello (fonte gli antichi trattati di scherma) poteva servire come improvvisata protezione o anche come arma d’attacco per difendersi da un malintenzionato.
"Mi piace"Piace a 2 people
Grazie per avere aggiunto questa chicca !!! 😘
"Mi piace""Mi piace"
Addiaccio per me e di uso comune, tabarro no, ma a casa mia si dice “guardala, è tutta intabarrata!” Ora capisco meglio!
"Mi piace"Piace a 2 people
Anche tu sei toscana, e da quelle parti è molto più comune. Intabarrato si sente abbastanza dappertutto. Auguriamo lunga vita a queste parole 🙏
"Mi piace""Mi piace"
All’addiaccio in Toscana si usa molto. Il tabarro non è un capo di vestiario che si usi più, se non nei balli in maschera, perciò lo userei solo per un racconto ambientato nell’Ottocento o, appunto, per una festa in costume. Però si usa l’aggettivo intabarrato!
"Mi piace"Piace a 1 persona
Si è l’uso più comune.
"Mi piace""Mi piace"
infatti quando gli scout dormono all’addiaccio è perke non dormono in tenda ma sull’erba, sotto a un telo tirato o anche sotto al cielo direttamente
"Mi piace"Piace a 1 persona
Esatto 👍🏻👍🏻
"Mi piace"Piace a 1 persona
ovvio
lo so per esperienza
"Mi piace"Piace a 1 persona
In Toscana “addiaccio” si usa ancora tanto e io uso anche “tabarro” (nel senso di “cappottone spesso”), ma soprattutto nella sua versione verbale di “intabarrare” quando ci si copre ben bene perché fa molto freddo.
"Mi piace"Piace a 1 persona
Queste due parole hanno ancora la possibilità di non sparire del tutto.
"Mi piace"Piace a 1 persona
Lo sai che I ragazzi oggi quando leggono I promessi sposi lo trovano scritto in una lingua straniera? 🤣
"Mi piace"Piace a 1 persona
😂😂😂😂😂
"Mi piace""Mi piace"