Parlami di casa, di Jeanine Cummins, Feltrinelli 2025, traduzione di Francesca Pe’, pp. 457
Il suo unico desiderio era vivere una vita piena di significato senza contribuire a peggiorare il mondo, due cose apparentemente impossibili secondo i parametri che regolavano l’esistenza degli esseri umani sul pianeta Terra.
Pag. 341
Jeanine Cummins appartiene a quella schiera di scrittrici capaci di trasformare l’esperienza individuale in una lente attraverso cui leggere le fratture del mondo contemporaneo. Nata negli Stati Uniti, di origini irlandesi e portoricane, porta nella propria biografia la stessa tensione identitaria che attraversa i suoi romanzi: il tema dell’appartenenza non è mai astratto, ma vissuto, interiorizzato, problematizzato. La sua narrativa nasce da un’urgenza etica prima ancora che estetica: dare voce a chi vive nelle zone di confine, geografiche e interiori.
Il successo internazionale le arriva con Il sale della terra, romanzo duro e magnetico che racconta la fuga di una madre e di un figlio dal Messico verso gli Stati Uniti. Lì Cummins sceglie un registro narrativo teso, quasi cinematografico, costruito sul movimento continuo, sulla paura che incalza, sulla precarietà della sopravvivenza. È un libro che mette il lettore in cammino, senza tregua, costringendolo a condividere il fiato corto dei personaggi. In Parlami di casa il passo cambia radicalmente: non più la corsa, ma la sosta; non più la frontiera esterna, ma quella interna. Eppure il cuore tematico resta lo stesso: l’amore materno come forza primaria, la perdita come ferita costitutiva, la paura come compagna silenziosa.
Questa coerenza tematica rivela un progetto narrativo preciso. Cummins non scrive romanzi “di attualità” nel senso più superficiale del termine, ma costruisce opere che dialogano con le grandi questioni del nostro tempo: migrazione, diaspora, identità culturale, memoria, trauma. La sua scrittura si colloca in quella corrente della narrativa contemporanea che potremmo definire realismo empatico o narrativa sociale letteraria: una forma di realismo che non rinuncia all’intensità emotiva né alla cura stilistica, ma che considera la letteratura come spazio di responsabilità.
Non c’è compiacimento nella sua prosa, né ricerca dell’effetto facile. Anche quando racconta storie cariche di dolore, Cummins evita il sensazionalismo. Preferisce lavorare per sottrazione, affidandosi ai dettagli, ai silenzi, ai gesti minimi. È qui che la sua scrittura si fa più potente: nella capacità di suggerire più di quanto espliciti, di lasciare che siano i legami spezzati, le parole mancate, le memorie incerte a parlare.
In questo senso, Parlami di casa rappresenta un passo ulteriore nella sua maturazione artistica. Se Il sale della terra interrogava il lettore sul diritto alla vita e alla sicurezza, questo romanzo lo interroga sul diritto all’identità, alla memoria, alla complessità. Cummins si muove così lungo una linea di narrativa contemporanea che potremmo accostare alle grandi voci femminili che esplorano il trauma e l’eredità familiare non come tema privato, ma come fatto politico e culturale.
Leggerla significa accettare un invito esigente: non solo seguire una storia, ma attraversare una zona di vulnerabilità dove la letteratura smette di essere intrattenimento e diventa spazio di riconoscimento. Ed è forse proprio qui che si trova la sua voce più autentica: in quella soglia fragile dove il racconto si fa coscienza.
La struttura a tre voci di Parlami di casa non è un semplice espediente narrativo, ma la chiave etica del libro. Daisy, Ruth e Rafaela non rappresentano solo tre generazioni, ma tre modalità diverse di relazione con la memoria. Rafaela vive la tragedia della cancellazione, perché la malattia erode i ricordi proprio mentre diventano più urgenti. Ruth è la donna del trauma non elaborato, sospesa tra due mondi e incapace di abitare davvero entrambi. Daisy, infine, è la figura della ricerca consapevole, colei che sceglie di tornare per interrogare le proprie origini invece di fuggirne. Cummins costruisce così una sorta di triangolo emotivo, in cui ogni lato esiste solo in relazione agli altri.
L’uragano iniziale assume un valore simbolico profondo. Non è solo l’evento che mette in moto la trama, ma la rappresentazione fisica di ciò che attraversa le protagoniste: una forza distruttiva che obbliga a fermarsi, a guardare ciò che si stava evitando. Dopo il passaggio della tempesta restano macerie, ma anche la possibilità di ricostruire diversamente. È in questa ambivalenza che il romanzo trova la sua tonalità più autentica.
Uno degli aspetti più riusciti è il modo in cui l’autrice racconta la diaspora senza mai trasformarla in manifesto. Il razzismo, la marginalizzazione culturale, la perdita della lingua madre emergono nei dettagli quotidiani, nei silenzi, nelle incomprensioni familiari. La lingua dimenticata da Ruth non è solo uno strumento comunicativo smarrito, ma una parte di sé amputata. E quando Daisy tenta di recuperare quel legame con l’isola, lo fa non per nostalgia, ma per esigenza identitaria. La casa, allora, smette di essere un luogo e diventa un processo: qualcosa che si costruisce faticosamente attraverso il confronto con la verità.
Il titolo stesso, Parlami di casa, suona come una richiesta fragile e potente insieme. Non è un ordine, è una supplica. Chiede alle madri di raccontare ciò che è stato taciuto, chiede alle figlie di ascoltare anche ciò che fa male. In questo senso, il romanzo è attraversato dal tema del silenzio ereditato e della parola come possibilità di guarigione. La riconciliazione, quando arriva, non è mai spettacolare. È fatta di piccoli spostamenti interiori, di sguardi che finalmente restano, di verità che non possono più essere rimandate.
Nel ritmo delle onde c’era una calma ipnotica e nel respiro di Ruth una lentezza di cui lei si dimenticava ogni volta che se ne andava da lì, per poi ricordarsene di nuovo ogni volta che tornava. Viveva quel dimenticare e ricordare, quell’amnesia oscillante, come una specie di atrofia spirituale. Tutte le volte che tornava doveva affrontare una verità pungente: ormai il semplice concetto di casa le era precluso. Apparteneva a ogni posto e a nessuno.
Pag. 373-374
Cummins scrive con uno stile sobrio ma denso, capace di dare rilievo emotivo agli oggetti, ai paesaggi, alle atmosfere. Portorico non è un semplice sfondo esotico, ma una presenza viva, una forza che modella i personaggi quanto le loro stesse scelte. La natura rigogliosa, la luce, l’oceano diventano elementi simbolici di un’appartenenza che resiste anche quando la memoria vacilla.
Se Il sale della terra era il romanzo della sopravvivenza fisica, Parlami di casa è quello della sopravvivenza emotiva. Meno spettacolare, forse, ma più intimo e necessario. Un libro che non offre soluzioni facili, ma accompagna il lettore in un percorso di riconoscimento, mostrando che la casa non è sempre il luogo da cui si parte, ma spesso quello che si ha il coraggio di ricostruire.
Qui potete leggere l’incipit del romanzo.

Nata in Spagna, figlia di un militare statunitense e di un chirurgo, Jeanine Cummins è cresciuta nel Maryland, ha studiato a Towson University e ha lavorato a lungo nell’editoria a New York (Penguin Books) prima di dedicarsi alla scrittura. Ha vissuto anche a Belfast, Irlanda del Nord. Vive a New York con il marito e le loro due figlie.
Il suo primo libro, A Rip in Heaven (2004), è una memoria sulla tragica morte di due membri della sua famiglia. Ha pubblicato i romanzi The Outside Boy e The Crooked Branch.
American Dirt (Il sale della terra) è diventato un bestseller internazionale, selezionato per il club del libro di Oprah, generando però anche controversie per la rappresentazione della crisi migratoria messicana. Ha dedicato anni alla ricerca per American Dirt, viaggiando al confine e incontrando migranti per raccontare la loro storia.

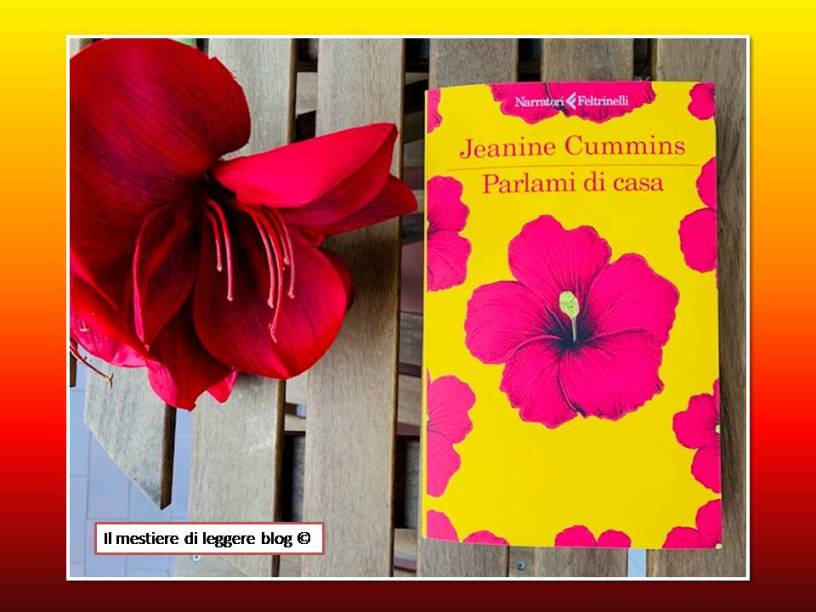

leggendoti, è impossibile non pensare come questi autori stiano reagendo alla politica di trump
"Mi piace"Piace a 1 persona
C’è sicuramente tanta preoccupazione e sconcerto.
"Mi piace"Piace a 1 persona