Quello che possiamo sapere, di Ian McEwan, Einaudi 2025, traduzione di Susanna Basso, pp. 376
Con Quello che possiamo sapere, Ian McEwan torna a uno dei suoi territori più tipici: l’incontro tra intelligenza narrativa e interrogativi morali, tra vita privata e forze storiche più grandi. È un romanzo che si muove con passo elegante e controllato tra due epoche lontane, mettendo in scena un mistero letterario e insieme un grande ragionamento sul tempo, sulla memoria e sulla fragilità di ciò che lasciamo dietro di noi.
McEwan costruisce una storia che ha il fascino del romanzo d’indagine, ma che si apre continuamente verso una dimensione più ampia: la riflessione su cosa significa davvero “sapere” qualcosa del passato, degli altri e persino di se stessi.
Il romanzo si sviluppa su due piani temporali principali. Nel primo, ambientato nel 2014, assistiamo a una cena tra amici, in cui emerge la figura di Francis Blundy, poeta ormai anziano e celebrato. Durante l’incontro, Blundy legge una poesia dedicata alla moglie Vivien, un testo intimo e potente che colpisce profondamente chi lo ascolta. È un momento apparentemente domestico e privato, ma destinato a diventare il centro di una catena di eventi: quella poesia infatti, pur straordinaria, è destinata a sparire, lasciando dietro di sé un alone di mistero.
Nel secondo piano narrativo ci troviamo più di un secolo dopo, nel 2119, in un’Inghilterra trasformata: le conseguenze di una grande catastrofe climatica hanno cambiato la geografia, la società e persino l’idea stessa di “cultura”. In questo futuro vive Thomas Metcalfe, studioso e ricercatore, che lavora su ciò che resta del nostro presente: frammenti, documenti, archivi incompleti, rovine di un mondo ormai quasi mitologico.
Metcalfe si imbatte nella traccia della poesia perduta di Blundy e ne resta ossessionato. La sua ricerca diventa un’indagine letteraria ma anche esistenziale: più scava nel passato, più si rende conto che la poesia è legata a relazioni complicate, segreti, rivalità e forse anche a un crimine. La letteratura, come spesso accade in McEwan, non è mai solo bellezza: è anche potere, ambiguità, possesso.
Uno dei punti di forza del romanzo è il modo in cui McEwan tratteggia i personaggi, senza mai trasformarli in semplici pedine narrative.
Francis Blundy è un poeta che incarna il prestigio culturale del Novecento e del primo Duemila: autore riconosciuto, figura pubblica, ma anche uomo pieno di zone d’ombra. La poesia dedicata a Vivien è al tempo stesso gesto d’amore e dichiarazione di controllo, quasi un tentativo di fissare per sempre qualcosa che nella vita reale resta instabile.
Vivien, la moglie, è una presenza che sfugge alle definizioni: non è soltanto la musa, ma un personaggio con una propria densità psicologica. Il rapporto con Francis è fatto di affetto e tensione, di dedizione e distanza. La poesia diventa anche il simbolo di un matrimonio che, dietro l’apparenza, contiene crepe e non detti.
Nel futuro, Thomas Metcalfe rappresenta un altro tipo umano: l’intellettuale che vive tra archivi e ricostruzioni, ma che finisce per cercare nel passato una forma di senso personale. Metcalfe non è solo un ricercatore: è un uomo che tenta di ricostruire un’epoca perduta come se stesse ricostruendo se stesso. La sua ossessione per la poesia è anche desiderio di ordine in un mondo ormai devastato e privo di certezze.
Attorno a questi personaggi gravitano figure secondarie che appartengono alla cerchia culturale di Blundy, e che contribuiscono a creare una rete di rivalità e ambiguità. McEwan suggerisce continuamente che dietro ogni “documento” sopravvissuto ci sono persone reali, con motivazioni contraddittorie.
L’ambientazione è uno degli elementi più affascinanti del libro, perché l’Inghilterra viene mostrata in due versioni quasi speculari.
Nel 2014, McEwan descrive un mondo ancora riconoscibile: case borghesi, salotti colti, conversazioni raffinate, un ambiente in cui la cultura ha ancora un ruolo centrale. È un’Inghilterra ordinata, stabile, ma forse anche un po’ autoreferenziale: un universo in cui la letteratura può diventare un simbolo di status, e la poesia un oggetto di prestigio.
Nel 2119, invece, l’Inghilterra è irriconoscibile. Il paesaggio è segnato dal disastro climatico: coste sommerse, città trasformate, società riorganizzate. Qui McEwan non costruisce una distopia spettacolare, ma una distopia “sobria”, credibile, quasi burocratica. Ed è proprio questo realismo a renderla inquietante: il futuro non è un incubo fantascientifico, ma un risultato plausibile dell’inerzia umana.
Questa doppia ambientazione rende il romanzo anche una riflessione sulla civiltà: su quanto rapidamente ciò che consideriamo stabile possa dissolversi.
Il titolo del romanzo è già una dichiarazione programmatica. Quello che possiamo sapere è un libro che interroga il concetto stesso di conoscenza.
McEwan insiste sul fatto che la conoscenza del passato è sempre frammentaria, fatta di lacune, interpretazioni e congetture. Nel futuro, Metcalfe studia il nostro tempo come un archeologo: non può sapere tutto, può solo ricostruire ipotesi. Questo meccanismo diventa una metafora potente del nostro rapporto con la memoria: anche quando crediamo di conoscere qualcuno o qualcosa, in realtà possediamo solo pezzi, mai l’intero.
Un secondo grande tema è il rapporto tra letteratura e verità. La poesia di Blundy è al centro del romanzo perché rappresenta una promessa: l’idea che l’arte possa contenere una verità profonda. Ma McEwan suggerisce anche l’opposto: la letteratura può essere una maschera, un modo per manipolare la memoria e controllare il racconto di sé.
Infine, il romanzo è attraversato dalla questione della responsabilità climatica. Il futuro devastato del 2119 è lo specchio di ciò che potrebbe accadere se continuiamo a ignorare le conseguenze delle nostre azioni. McEwan non predica, non costruisce un manifesto, ma lascia che sia la narrazione stessa a produrre l’effetto morale: il lettore percepisce che quel futuro non è una fantasia, è una possibilità.
McEwan sembra voler suggerire che ogni epoca vive dentro un’illusione: l’illusione di essere definitiva, centrale, stabile. Ma il tempo ridimensiona tutto. Ciò che oggi ci appare essenziale domani può diventare un frammento incomprensibile. Allo stesso tempo, però, il romanzo non è nichilista. La poesia perduta, la ricerca di Metcalfe, la sopravvivenza dei documenti, indicano che la cultura è fragile ma non inutile: è uno dei pochi strumenti che abbiamo per parlare con chi verrà dopo di noi. Il messaggio sembra essere questo: non possiamo sapere tutto, ma possiamo scegliere cosa lasciare. E ciò che lasciamo non è solo materiale: sono gesti, relazioni, responsabilità.
Ian McEwan è uno degli scrittori britannici più importanti degli ultimi decenni. Nei suoi romanzi ha spesso unito la precisione psicologica del realismo con grandi questioni morali e sociali: basti pensare a Espiazione, dove la colpa privata si intreccia alla tragedia storica, o a Solar, dove l’ironia si misura con la crisi climatica.
Nei suoi romanzi esplora con un realismo spesso spietato le complessità della psiche umana, le relazioni amorose, i conflitti interiori e i dilemmi etici, mettendo in scena personaggi fragili e contraddittori, capaci di gesti improvvisi e irreparabili. Le sue storie si muovono frequentemente dentro contesti storici e sociali precisi, dove il privato si intreccia con il collettivo: dai traumi dell’infanzia alle crisi della modernità, fino alle paure legate al futuro. Un tema ricorrente della sua produzione è la riflessione sulla relatività della verità, sulla memoria e sul modo in cui gli eventi vengono deformati dal punto di vista, dal rimorso o dall’autoinganno.
Tra i suoi romanzi più noti spicca Amsterdam (1998), vincitore del Booker Prize, un’opera che unisce satira, ambizione morale e tensione narrativa, confermando la capacità di McEwan di raccontare con lucidità le zone d’ombra della coscienza e i compromessi dell’etica contemporanea.
Quello che possiamo sapere, un romanzo colto e stratificato , si colloca perfettamente in questa linea: come in Sabato o Espiazione, la vita quotidiana diventa la porta d’accesso a dilemmi più vasti. Ma qui McEwan aggiunge un elemento nuovo: una costruzione quasi da romanzo speculativo, che sfiora la fantascienza senza mai abbandonare la sua cifra stilistica, elegante e razionale. È un libro che sembra voler raccogliere e fondere molte delle ossessioni dell’autore: la memoria, la colpa, l’ambiente, l’arte, il rapporto tra verità e racconto.
Lo stile è quello tipico di McEwan: preciso, colto, controllato, capace di rendere affascinante anche un dettaglio apparentemente ordinario. La prosa non è mai barocca, ma densissima. Il lettore avverte sempre la mano di uno scrittore che non lascia nulla al caso, e che usa la narrativa come un laboratorio intellettuale.
È un romanzo che richiede attenzione, perché spesso lavora più per sottrazione che per colpi di scena. Ma proprio per questo risulta profondamente letterario: non si consuma in fretta, si sedimenta.
Quello che possiamo sapere è un libro ideale per lettori che amano i romanzi letterari e riflessivi, più interessati alle domande che alle risposte; i libri che parlano di arte, poesia, memoria e ricerca culturale; la narrativa che intreccia vicende intime con temi globali come la crisi climatica. Potrebbe invece risultare meno adatto a chi cerca un ritmo serrato o un romanzo d’azione: la suspense c’è, ma è una suspense intellettuale, fatta di indizi, archivi, deduzioni, e soprattutto di interpretazione.
In definitiva, Quello che possiamo sapere è un romanzo che usa un mistero letterario come chiave per aprire domande enormi: cosa resta di noi, cosa si perde, cosa sopravvive, cosa significa “capire” davvero una persona o un’epoca. McEwan mette il lettore di fronte a una verità scomoda: il futuro ci guarderà come noi guardiamo il passato, con incompletezza e immaginazione. E forse è proprio questo il punto più potente del libro: ricordarci che la civiltà non è garantita, la memoria non è eterna, e la conoscenza è sempre una conquista fragile.

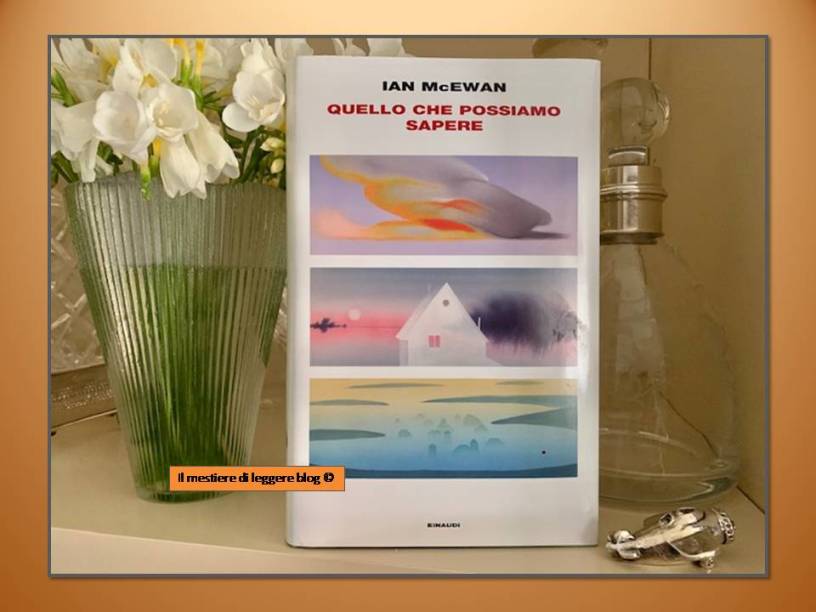

Meno severo, quasi ottimista più della realtà.
"Mi piace"Piace a 1 persona
Da quanto tempo non leggo Ian McEwan! Grande amore fu all’inizio poi delusione. Me lo consigli?
"Mi piace"Piace a 1 persona
Ho apprezzato alcune cose, meno altre ma complessivamente credo valga la lettura.
"Mi piace"Piace a 1 persona
Grazie
"Mi piace""Mi piace"
Questo libro è bellissimo, mi ha affascinato immensamente. Mi è piaciuto il modo in cui McEwan ha saputo raffigurarsi il mondo dopo le varie catastrofi, sia belliche che climatiche, e la vita di chi lo popola; mi è piaciuto il modo in cui il protagonista si immerge totalmente nell’atmosfera del 2014 inglese, con i personaggi sui quali indaga e che gli sembrano più familiari della sua stessa compagna; e mi è piaciuta moltissimo anche la seconda parte, il diario di Vivien, così diversa dalla prima parte da sembrare quasi un altro romanzo, che però illumina di una luce cruda la vita del poeta e di sua moglie, che Thomas aveva tanto idolatrato…
"Mi piace"Piace a 1 persona
Grazie per questo splendido commento che arricchisce la mia analisi.
"Mi piace""Mi piace"