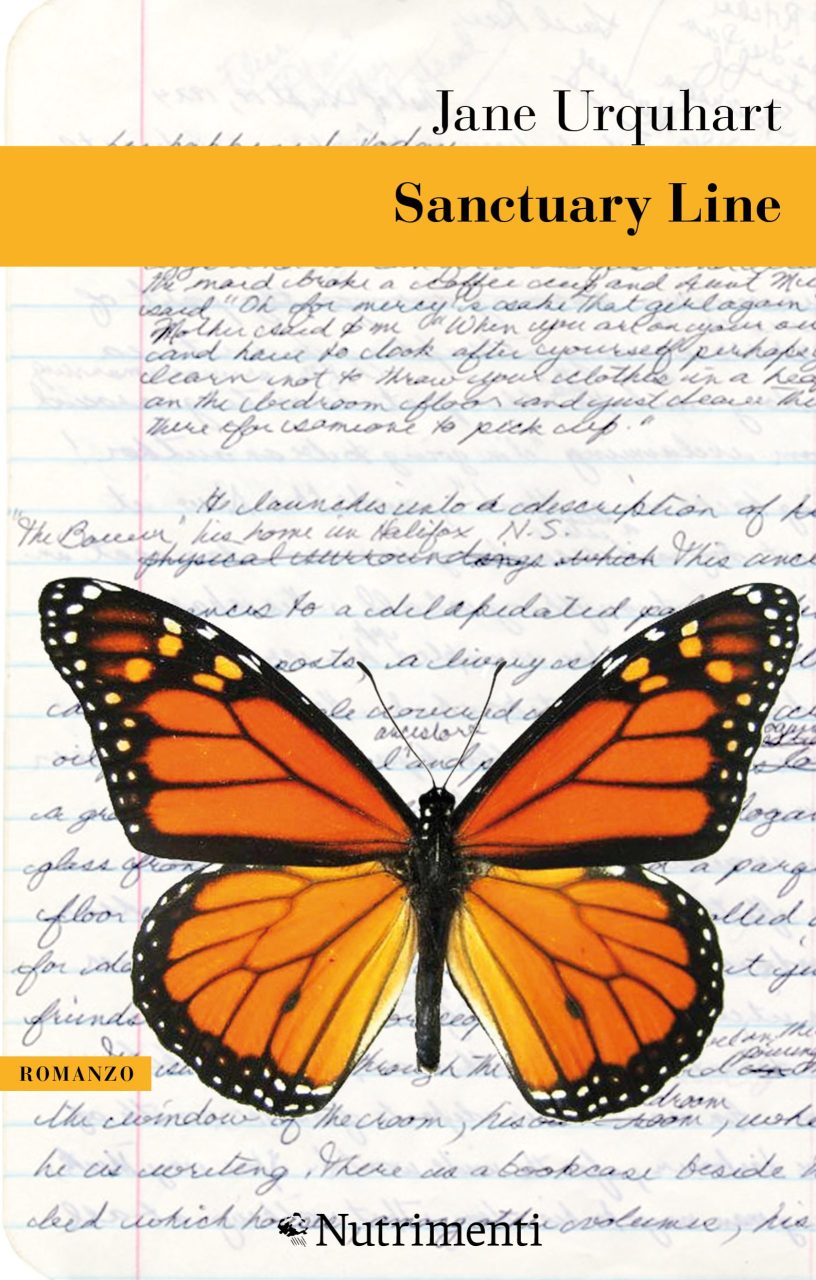INCIPIT
Dai uno sguardo fuori dalla finestra.
Questa fattoria e i suoi terreni sono così rovinati che è difficile credere che ci siano stati campi e frutteti, se non nei miei ricordi e nella mia immaginazione. Anche ai tempi in cui ero poco più che ventenne, questa terra era già cambiata, quasi impossibile da riconoscere, con le baracche dei lavoratori che cadevano a pezzi e gli alberi, incolti, sempre più poveri di frutta. Ma questo accadeva quando mia zia aveva cominciato a liberarsi di alcune parti della proprietà per venderle agli immobiliaristi; un passo, credetti al tempo, indirizzato verso una qualche forma di futuro – perlomeno economica – per lei e per mia madre, che da poco aveva iniziato a vivere qui. Ora mia zia è morta e mia madre vive in un posto chiamato Golden Field, un nome ironico, se c’è qualcosa su cui fare ironia, soprattutto al pensiero dell’unico campo rimasto qui, del suo grigiore nella luce morente.
È vero, certe tracce del passato per un po’ sono rimaste: le staccionate costruite da uno dei vecchi avi, e quello strano tumulo di pietre che un altro dei nostri antenati tirò fuori dal terreno. “La prima messe di ogni anno sono i sassi” era la perla di saggezza che tramandavano a noi pigri discendenti. Mio zio la ripeteva spesso, anche se nella sua vita si era dedicato ben poco all’aratura. Ci raccontava che, alla fine, molte di quelle pietre di campo erano servite per la costruzione dell’imponente fattoria, che resisteva su quelle terre, solida e forte, dalla metà del prospero diciannovesimo secolo, quando era stata costruita.
Ma, soprattutto, diceva mio zio, il primo vero raccolto era stato abbattere tutti quegli acri di foresta, così che un campo, un qualsiasi campo, che contenesse macigni oppure oro, potesse nascervi. Mi sembra di ricordare che durante la mia infanzia c’era ancora una traccia non molto profonda delle fondamenta dell’originaria casa di tronchi dove quei pionieristici taglialegna dovevano aver vissuto. I segni però erano così vaghi che solo uno come mio zio avrebbe potuto notarli, indicarli e insistere perché li osservassimo. Lo ricordo mentre mostrava una manciata di pietre a Teo, il quale restava fermo al suo fianco a guardare obbediente verso terra e poi si rivolgeva a me con sguardo interrogativo, cercando, suppongo, di capire che cosa c’entrassi io, una ragazza viziata di città, con le rudi storie che mio zio gli stava raccontando su quel posto. Bambini morti, ragazzi persi nella tormenta, cavalli che galoppavano a fatica nella tempesta. Teo ascoltava educatamente, con gli occhi castani rivolti al bel viso di mio zio, ma nel caldo umido di quelle estati degli anni Ottanta, quando la fattoria era un fiorire di affari, quelle storie dovevano risultare quasi impossibili da credere per un bambino come lui.
Jane Urquhart