Il termine “manigoldo” richiama la figura di un individuo rozzo, malintenzionato o moralmente spregevole, storicamente associato anche al boia o a chi compie azioni vili; tuttavia, nel suo uso più recente ha acquisito una connotazione ironica, se non benevola. “Mutria” indica invece un atteggiamento altero, un cipiglio di ostentata fierezza o scontrosità, più legato all’espressione del volto che alla condotta etica. Entrambi i vocaboli condividono un’aura di negatività e di distanza dai valori socialmente apprezzati: il manigoldo incute riprovazione per ciò che fa, la mutria per come si mostra. Si distinguono tuttavia per natura e uso linguistico, poiché il primo designa una persona o un ruolo connotato sul piano morale, mentre il secondo descrive una postura emotiva o comportamentale, spesso passeggera e interpretata nel contesto relazionale.
Manigoldo, /ma·ni·gól·do/: persona capace di azioni malvagie, birbante, briccone, canaglia, delinquente, disgraziato, farabutto, filibustiere, furfante, (fam.) malandrino, mascalzone, masnadiere.
La parola manigoldo è una di quelle gemme linguistiche che suonano come un insulto elegante, degno di un duello verbale tra gentiluomini. Deriva dal latino manu guldus o, secondo altri, dal francese antico manigault, con il significato originario di “servo delle mani”, ossia colui che eseguiva materialmente i lavori più brutali — in particolare, il boia o il carnefice. Da qui il passaggio semantico è breve e letale: il “manigoldo” diventa presto sinonimo di individuo spregevole, furfante, birbante di un certo rango. Nel linguaggio comune, tuttavia, il termine ha conservato una sua irresistibile nobiltà d’altri tempi: chiamare qualcuno “manigoldo” oggi è quasi un complimento alla fantasia lessicale, un modo per insultare con grazia, come chi lancia il guanto della sfida con un sorriso ironico e un tocco di teatralità linguistica.
Mutria, /mù·tria/: Espressione del volto abitualmente e ostinatamente accigliata, chiusa a qualsiasi moto di simpatia, per malumore o per alterigia.
La parola mutria evoca un certo broncio aristocratico. Deriva dal francese moutrie o forse dal provenzale mut, imparentato con muet (“muto”), e indica quel particolare atteggiamento del volto chiuso, corrucciato, ostentatamente silenzioso, che nasce da superbia o risentimento. In breve: chi fa mutria non parla, ma comunica moltissimo — e nulla di piacevole. È un broncio che vuole essere eloquente, un manifesto d’orgoglio ferito o di sdegnosa superiorità. Nel linguaggio letterario e popolare ottocentesco la parola era assai gustata: dire “fare mutria” significava “fare il muso lungo”, ma con un tocco di civetteria teatrale.
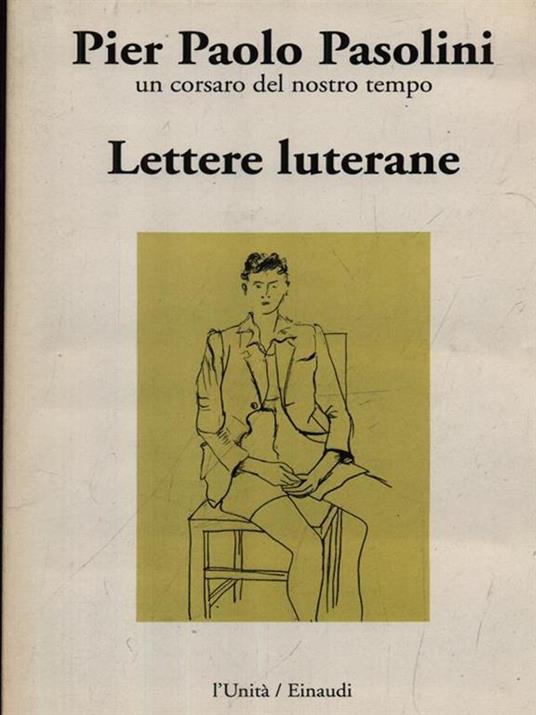
L’unico caso in cui mi ricordo di averla letta nella letteratura novecentesca risale a Pier Paolo Pasolini. A partire dall’inizio del 1975 e fino alla morte, Pasolini pubblicò una serie di editoriali e interventi sul «Corriere della Sera» e sul settimanale «Il Mondo». Furono poi raccolti e pubblicati postumi, nel 1976, da Einaudi con il titolo «Lettere luterane. Il progresso come falso progresso».
Uno degli interventi più struggenti è la lettera luterna contro i campioni dell’infelicità e indirizzata a «Gennariello», che assurge a simbolo di tutti i giovani, ai quali Pasolini rivolge l’augurio di sfuggire alla rinuncia, all’infelicità e alla retorica della bruttezza.
“Non lasciarti tentare dai campioni dell’infelicità, della mutria cretina, della serietà ignorante. Sii allegro.”
Cosa pensate di queste due parole? Le utilizzate? Vi piacciono?

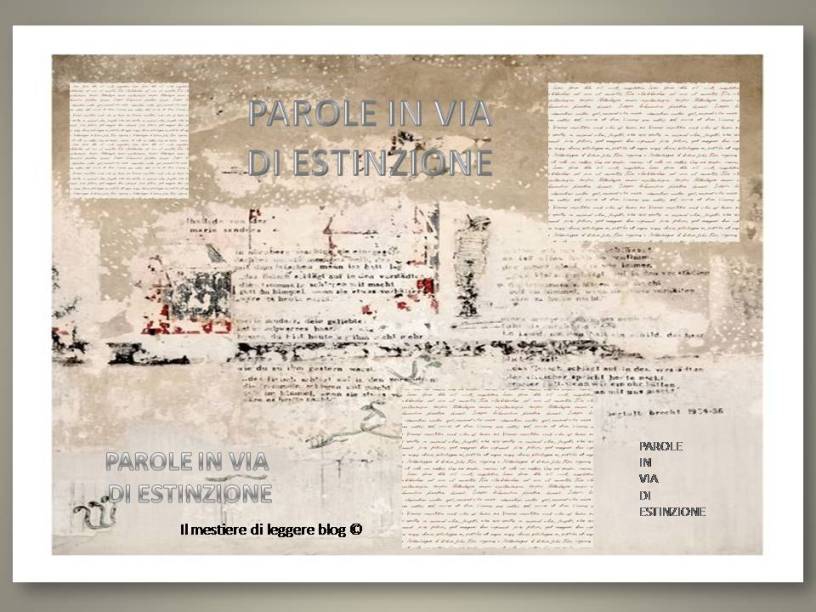

Manigoldo è un sempre verde. Mutria non la conoscevo
"Mi piace"Piace a 2 people
Manigoldo mi piace , lo trovo versatile, ti permette di usarlo e dosarlo nella scala di intensità.
"Mi piace"Piace a 2 people
Suona retrò
"Mi piace"Piace a 1 persona
Un po’ come briccone …
"Mi piace"Piace a 1 persona
Bello briccone
"Mi piace"Piace a 1 persona
🥰
"Mi piace""Mi piace"
Manigoldo non mi sembra in via d’estinzione: prossimo alla minaccia, forse, ma ancora non in pericolo. Mutria invece secondo me è già estinta… e devo dire che non me ne dispiaccio, non la gradisco particolarmente. Mi immagino di usarla in un bel limerick intitolato “La mutria della nutria”, però!
"Mi piace"Piace a 2 people
🤣🤣🤣🤣
"Mi piace""Mi piace"
Su mutria sono d’accordo però vale la pena sapere che esiste. Manigoldo, come ho detto sopra, mi piace molto e spero continui ad essere utilizzato.
"Mi piace""Mi piace"
Non conoscevo Mutria.
"Mi piace"Piace a 1 persona
Non è molto nota in effetti
"Mi piace""Mi piace"
Sai che non conoscevo il termine “mutria”?
"Mi piace"Piace a 1 persona
Sei in buona compagnia 😊
"Mi piace"Piace a 1 persona
😉❣️
"Mi piace""Mi piace"
Manigoldo è pittoresca e quasi simpatica. Mutria non la conoscevo proprio. Ciao Pina! 👋😊
"Mi piace"Piace a 1 persona
Per mutria, come puoi vedere, non sei sola 😉
"Mi piace"Piace a 1 persona
😄😄
"Mi piace""Mi piace"
Come ogni lingua viva, l’italiano evolve con la società. Molte parole cadono in disuso perché legate a oggetti, professioni o concetti che non fanno più parte della vita quotidiana, come “palia” per indicare la paglia. Altre vengono sostituite da termini più moderni o internazionali, seguendo le correnti culturali e tecnologiche del tempo. È un processo naturale che riflette il cambiamento dei costumi e del modo di pensare.
"Mi piace"Piace a 2 people
Proprio così, la lingua è in continua evoluzione, è come un organismo vivente che cambia e si adatta. Analizzando queste parole a rischio estinzione si vede il cambiamento nella società.
"Mi piace"Piace a 1 persona
La prima la conosco, la seconda mai sentita. Ciao Guido.
"Mi piace"Piace a 1 persona
Pina, perdonami… ❤
"Mi piace"Piace a 1 persona
Tranquilla 🙃😉
"Mi piace"Piace a 1 persona
Mutria sì, ma manigoldo …
"Mi piace""Mi piace"
Manigoldo è sicuramente ancora in auge nella nostra generazione e forse ancora un paio dopo. Sulla gen Z mica tanto. Io mi confronto con ragazzi dai venti ai venticinque, tutti almeno con istruzione superiore, per lo più anche già laureati in triennale. Ti assicuro che pochissimi conoscono il significato di questa parola e tantomeno la usano. Quindi credo che nel giro di qualche anno potrebbe rimanere un ricordo…
"Mi piace"Piace a 1 persona
Mutria non la conoscevo (interessante però), manigoldo la uso più in situazioni scherzose ma resta una parola molto efficace nel descrivere un certo tipo di persona. Grazie.
"Mi piace"Piace a 1 persona
Grazie per avere contribuito alla discussione 😊🙏
"Mi piace"Piace a 1 persona
“Manigoldo” lo abbino a “filibustiere”, termini un poco “vintage” che però si incontrano ancora, anche se io, personalmente, li uso raramente.
“Mutria” per me sconosciuto e mai usato: ho letto il testo di Pasolini ma questo particolare termine non lo ricordavo.
Grazie a Pina per la sua solita preziosa azione di vera e propria archeologa letteraria!
"Mi piace"Piace a 1 persona
Grazie a voi che alimentate lo scambio di opinioni su un tema che non sempre sembra suscitare interesse 😊
"Mi piace""Mi piace"
Mutria lo uso, probabilmente in questa zona della Toscana è una parola ancora abbastanza comune, in effetti noi parliamo un italiano un po’ arcaico. Manigoldo non lo userei se non per scherzo, sono termini che ormai appartengono ai romanzi di Salgari…
"Mi piace"Piace a 1 persona
Verissimo… anch’io la uso in tono scherzoso. Mutria la conosco ma non la uso.
"Mi piace""Mi piace"
“Aveva una mutria…” non è insolito da noi per indicare una persona immusonita
"Mi piace"Piace a 1 persona
Me lo hanno segnalato anche altri amici toscani 👍🏻
"Mi piace""Mi piace"
suvvia, non siamo ridicoli
generazioni su generazioni sono conosciute con Topolino, e manigoldo è una delle parole tipiche di Zio Paperone!
"Mi piace"Piace a 2 people
cresciute*
"Mi piace""Mi piace"
Che bella questa citazione 😍😍😍
"Mi piace"Piace a 1 persona
Adoro la parola mutria…. Anche se non la uso mai per paura di non essere compresa. Buona notte, Pina
"Mi piace"Piace a 1 persona
In effetti è vero, a volte evitiamo di usare certe parole per timore di non essere compresi o di apparire saccenti. Dovremmo sentirci più liberi 💪🏻 buona notte cara Silvia
"Mi piace""Mi piace"