Ci sono parole che sembrano nate per stare in vetrina: lucide, precise, con un’aria da “non mi usi tutti i giorni, ma quando entro in scena mi faccio ricordare”. Chicchera e icastico appartengono a questa categoria di rarità affascinanti. La prima ha il suono domestico e tintinnante delle cose piccole e quotidiane, la seconda invece è severa e quasi marmorea, come un termine scolpito. Eppure, a ben guardare, entrambe hanno a che fare con la forma: chicchera è una forma concreta, una piccola architettura di porcellana; icastico è una forma mentale e linguistica, la capacità di dare contorno nitido a un’immagine con le parole. Una sta sul tavolo, l’altra nella frase, ma tutte e due servono a contenere qualcosa: una bevanda, un’idea.
Chicchera, /chìc·che·ra/: Piccola tazza di porcellana o maiolica o terraglia, anche con manico da un lato, in cui si prende il caffellatte o la cioccolata. Nel tempo diffusa anche per bere il caffè.
La chicchera non è una tazza qualsiasi: la parola porta con sé un tono leggermente antiquato, da salotto borghese o da scena teatrale. Dire “chicchera” invece di “tazzina” è come scegliere un guanto di pizzo al posto di un guanto normale: non è necessario, ma cambia l’atmosfera. È ormai un regionalismo diffuso soprattutto nel Nord Italia, in particolare in Lombardia e nel Veneto, ma con una presenza storica anche in Toscana.
Spesso compare anche nell’espressione “una chicchera di caffè”, cioè una piccola quantità.
La parola chicchera deriva dal termine atzeco (náhuatl) xicalli, che indicava il frutto della Crescentia cujete, simile a una zucca verde. I mesoamericani lo essiccavano e lo tagliavano a metà, ottenendo ciotole naturali usate per bere varie bevande, soprattutto quelle a base di cacao. Anche quando nelle corti si diffusero coppe in ceramica più lussuose, la forma delle xicalli rimase un modello e venne spesso imitata.
Con l’arrivo dei coloni europei, questi recipienti continuarono a essere usati e decorati con laccature, pitture e oro. Gli spagnoli, però, trasformarono il termine xicalli in jícara, più facile da pronunciare. Le jícaras giunsero poi in Italia insieme al cacao e il nome si adattò in chicchera. Col tempo, il termine passò a indicare anche le tazzine di porcellana (spesso cinesi) usate per bere cioccolata e altre bevande coloniali, mantenendo così viva, inconsapevolmente, una tradizione nata nelle antiche corti azteche.
Insomma, chicchera è una di quelle parole che raccontano, senza dirlo apertamente, la storia degli scambi culturali: la tazzina come oggetto coloniale, il cacao e il caffè come abitudini importate, e infine l’italiano che trasforma tutto in musica.
Si registra anche l’espressione “parlare in chicchere”, usata in senso figurato per indicare un modo di esprimersi affettato e artificiosamente elegante, come se chi parla volesse ostentare cultura e raffinatezza attraverso un linguaggio troppo ricercato. In pratica significa parlare con leziosità, usando parole “da salotto” o formule sofisticate più per impressionare che per comunicare con naturalezza. L’immagine è ironica: come la chicchera è una tazzina fine e preziosa, così questo modo di parlare risulta “in porcellana”, elegante ma spesso fragile e poco spontaneo.
La parola ha anche un valore quasi onomatopeico: chicchera sembra imitare il rumore lieve della porcellana posata sul piattino. È una parola che tintinna. E forse è anche per questo che, quando compare in un testo, si fa notare: non sta zitta.

Icastico, /i·cà·sti·co/: Improntato a una notevole efficacia rappresentativa, che descrive, rappresenta o ritrae nei tratti essenziali, e quindi in modo efficace e spesso asciutto, tagliente.
Icastico significa efficacemente rappresentativo, vivido, capace di rendere un’immagine con grande forza e precisione. Si usa soprattutto riferito a una descrizione, a uno stile, ad un’espressione linguistica o ad una rappresentazione artistica. Ad esempio, uno scrittore icastico non gira intorno alle cose: le mette davanti agli occhi. Non necessariamente con molte parole, anzi spesso con poche, ma scelte come scalpelli.
“Con due tratti icastici descrisse la stanza: odore di chiuso, una tenda ingiallita, silenzio da ospedale.”
Icastico deriva dal greco eikastikós (εἰκαστικός), legato a eikón (εἰκών), cioè “immagine”. È la stessa radice che ritroviamo in parole come icona.
In origine il termine apparteneva al lessico della retorica e dell’estetica: indicava la capacità di riprodurre fedelmente o rendere presente qualcosa attraverso la rappresentazione. Dunque icastico non significa semplicemente “bello” o “poetico”: significa che rende visibile.
Oggi lo si usa soprattutto in ambito critico-letterario, giornalistico colto e saggistico. Ha una sfumatura interessante: non è solo “chiaro”, ma anche incisivo, quasi drastico. Un’immagine icastica non accarezza: imprime.
Per esempio, in critica si può dire:
“Il romanzo è ricco di ritratti icastici, spesso crudeli.”
È una parola utile quando vuoi dire che qualcosa “si vede”, come se fosse già disegnato.
Molti autori celebri vengono definiti icastici per la loro capacità di creare immagini immediate: pensiamo alla prosa realista, o a certi passaggi di Verga dove bastano pochi dettagli per far comparire un mondo intero. Anche in Dante, spesso, l’immagine non è solo evocata: è mostrata, illuminata con una luce improvvisa. L’icastico è questo: una lingua che si fa luce e non solo suono.
È una parola che spesso viene confusa con “ironico”, “drammatico”, “poetico”. In realtà è più tecnica: descrive un effetto visivo della scrittura. Se la frase fosse un quadro, icastico direbbe che il quadro è nitido e potente, non necessariamente piacevole.
In fondo, chicchera e icastico raccontano due gesti umani: il primo è quello di versare, il secondo di mostrare. La chicchera contiene una bevanda e suggerisce lentezza, conversazione, ritualità; l’icastico contiene un’immagine e suggerisce precisione, intelligenza, taglio netto. E forse il punto in cui si incontrano è proprio questo: entrambe sono parole che non amano lo spreco. La chicchera è piccola, l’icastico è concentrato. Una misura il caffè, l’altro misura la lingua. E tutte e due, se usate bene, lasciano un retrogusto che dura.
Che mi dite di queste due parole? Vi piacciono? Le utilizzate?

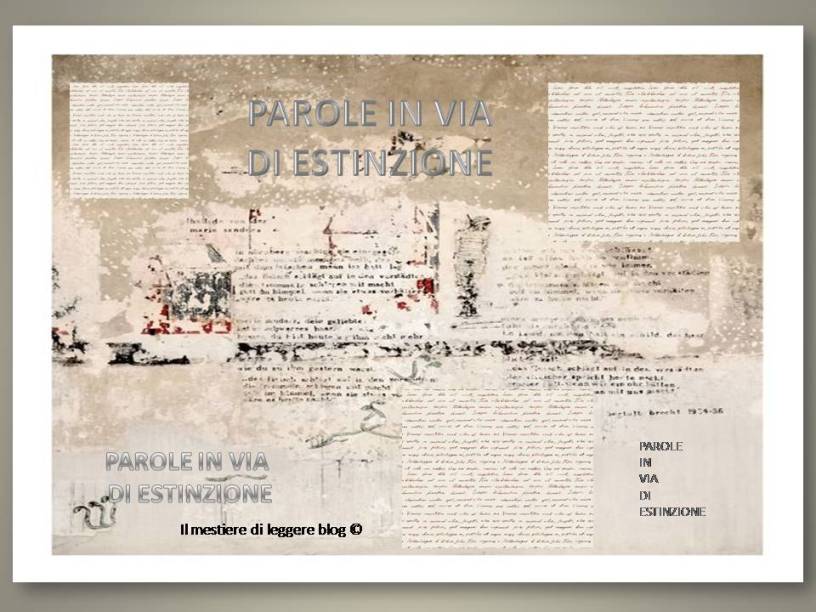

Buongiorno Pina. Ho un vago ricordo di quest parole, ma credo di aver sentito usare solo “chicchera” da ia mamma che aveva trascorso i primi vent’anni della sua vita in un collegio.
"Mi piace"Piace a 2 people
Immagino, chicchera era usata comunemente dalle generazioni precedenti.
"Mi piace"Piace a 1 persona
Da Chicco a chicchera.
Icastica l’ho sentita di rado
"Mi piace"Piace a 1 persona
Immagino che sia così per tanti.
"Mi piace"Piace a 1 persona
Chicchera è tuttora la forma dialettale della tazzina, da noi.
E icastico mi piace per il significato, ma anche perché il suono mi rimanda alle castagne, ne sento il sapore in bicca quando penso o pronuncio questa parola (sono sinestetica).
"Mi piace"Piace a 1 persona
*bocca.
"Mi piace"Piace a 1 persona
In effetti nel nord Italia è ancora consueta.
"Mi piace"Piace a 1 persona
Parlare in chicchera è chi vuole scrivere lirico o elegante ma è ignorante e risulta solo pacchiano
"Mi piace"Piace a 2 people
In effetti … 😆😆😆
"Mi piace"Piace a 1 persona
Mio padre apprezza molto quel tipo di scrittura. Che ora è fuori luogo
"Mi piace"Piace a 1 persona
Icastico la uso spesso (a questo punto, mi sa, non nel suo sendo più corretto) per parlare di frasi appunto taglienti, che colpiscono nel segno senza perdersi in fronzoli… o, se preferisci, senza perdersi in chiacchere :-).
"Mi piace"Piace a 2 people
Beh più o meno ci siamo
"Mi piace""Mi piace"
Icastico spero non sia un aggettivo in disuso; è, come dire, colto. Di conseguenza, relativamente raro nell’uso.
Chicchera: io sono veneta, e noi, per dire tazzina, in dialetto, usiamo cichera. E’ vero, dunque, usando Chicchera mi parrebbe di italianizzare un termine dialettale. Dovrò farci caso, e usarlo.
"Mi piace"Piace a 2 people
Sai che in effetti è vero, sopravvivono di più le forme dialettali di questa parola rispetto all’italiano.
"Mi piace"Piace a 2 people
Le conosco entrambe. In dialetto veronese: ‘Chicara’. ☕️
"Mi piace"Piace a 2 people
Vedi!!! 👍🏻👍🏻👍🏻
"Mi piace""Mi piace"
Chicchera lo diceva mia nonna, io non lo direi però, e non lo scriverei. Icastico lo trovo invece un termine utilizzabile, anzi, in certi casi insostituibile
"Mi piace"Piace a 2 people
Vero. Icastico racchiude un concetto ben preciso e per sostituirlo serve una locuzione.
"Mi piace""Mi piace"
Che belle parole hai scelto e spiegato, per non dire narrato.
Le parole le conosco entrambe e icastico lo uso ancora e spero non si perda perché ha un significato ben preciso che nessun’altra parola ha (visione netta, tagliente, precisa, colta nella sua essenza, descritta senza tanti giri di parola).
Chicchera, dalle mie parti, si usa per dire che una cosa o persona è deliziosa, elegante, piccina, “Che chicchera che è!”
Grazie sempre di questa tua rubrica.
"Mi piace"Piace a 1 persona
Che bello questo uso di chicchera!!!
Icastico anche per me è insostituibile.
"Mi piace"Piace a 1 persona
Icastico sopravvive nel linguaggio dei critici in poesia. Ciao
"Mi piace"Piace a 1 persona