Nel centenario della nascita di Richard Yates, tornare alla sua opera assume il senso di un omaggio naturale, quasi dovuto, ma anche quello di un desiderio più ambizioso: che le sue pagine continuino a circolare, a inquietare, a trovare nuovi lettori disposti a lasciarsi attraversare dalla sua voce severa. Celebrarlo oggi non significa soltanto ricordarlo, bensì riaprirlo al presente, augurandosi che la sua scrittura raggiunga un pubblico sempre più ampio e consapevole.
Perché tornare a Yates non significa soltanto riscoprire uno scrittore del secondo Novecento americano; significa misurarsi con una voce che non ha mai ceduto alla tentazione della consolazione. Ho attraversato tutti i suoi romanzi come si attraversa una città che non concede scorciatoie, e ogni volta ho ritrovato la stessa intransigenza morale. Yates non ammicca, non trucca la realtà per renderla più accettabile: smonta le illusioni con precisione chirurgica e ci costringe a osservare ciò che preferiremmo ignorare, dall’ambizione scambiata per talento, all’amore trasformato in arena di rivendicazioni. È uno scrittore che non promette salvezze spettacolari, ma offre qualcosa di più raro: la possibilità di riconoscersi senza autoassolversi. Ed è proprio questa fedeltà ostinata alla verità dell’umano che, a cent’anni dalla sua nascita, lo rende non solo attuale, ma necessario.
Yates è stato uno scrittore americano fino al midollo, eppure profondamente allergico alla retorica del suo Paese. Nei suoi romanzi non c’è traccia del sogno americano come promessa radiosa. Se compare, è già incrinato, come una bella vetrina dopo una sassata. Durante la sua vita, le sue opere non superarono mai le 12.000 copie. Anche la critica oscillava, divisa tra chi ne riconosceva la precisione chirurgica e chi trovava eccessiva quella desolazione senza anestesia. Come spesso accade, il tempo ha fatto il suo lavoro di restauratore silenzioso. Dopo la morte, Yates è stato riletto, rimesso sugli scaffali giusti, finalmente ascoltato.
I temi che affrontava non erano fatti per entusiasmare un pubblico in cerca di consolazione. La sua visione dell’essere umano è severa, talvolta impietosa. I suoi personaggi inseguono felicità prefabbricate, rispettabilità suburbane, amori che dovrebbero salvarli, e finiscono invece per scontrarsi con la propria mediocrità, con la paura, con l’illusione di essere speciali. Nei suoi libri il sentimentalismo sorridente, quello che promette il lieto fine come una clausola contrattuale, non ha cittadinanza. La realtà, per Yates, non si lascia addomesticare.
Una galleria di fallimenti luminosi
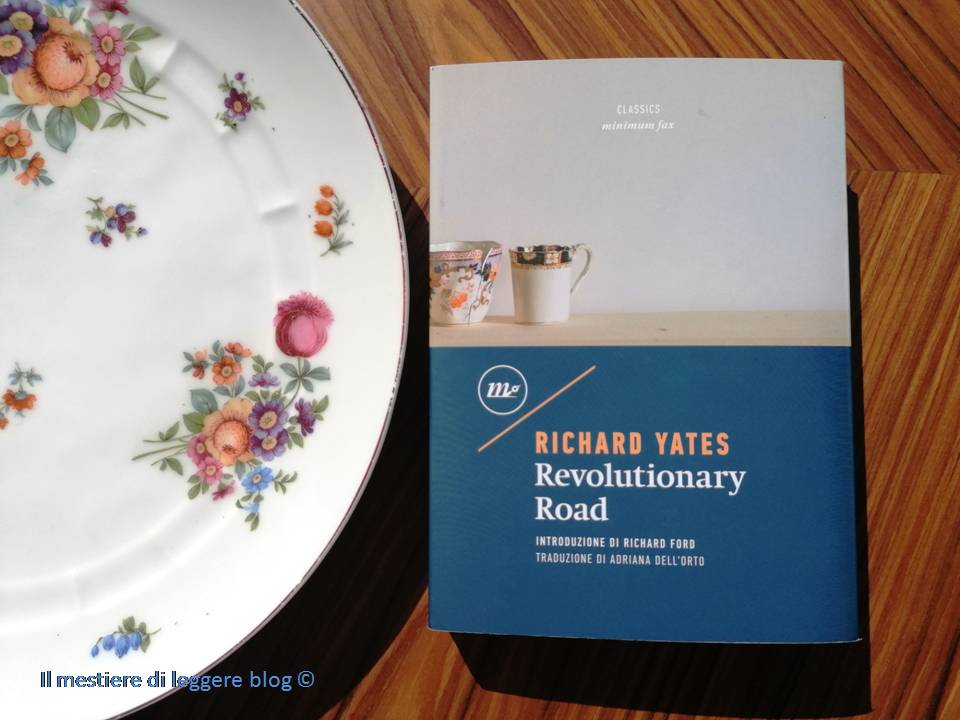
Il romanzo che lo impose all’attenzione di pochi ma appassionati lettori fu Revolutionary Road (1961). Frank e April Wheeler sono giovani, intelligenti, convinti di essere diversi dai loro vicini. Si sentono destinati a qualcosa di più grande della routine suburbana. Progettano una fuga a Parigi, simbolo di autenticità e rinascita. Ma ciò che li distrugge non è il mondo esterno: è l’incompatibilità tra il loro ideale e la loro fragilità. Stilisticamente, Yates costruisce il romanzo con una prosa limpida, quasi invisibile. Non alza mai la voce. L’orrore nasce proprio da quella chiarezza: non c’è enfasi, non c’è giudizio esplicito, solo la cronaca esatta di un’illusione che si sgretola.
Nel 2008 il romanzo è diventato film grazie a Revolutionary Road, diretto da Sam Mendes e interpretato da Leonardo Di Caprio e Kate Winslet. È stato un momento decisivo per la riscoperta di Yates: improvvisamente, quella tragedia domestica è tornata al centro del discorso culturale, mostrando quanto fosse ancora attuale.
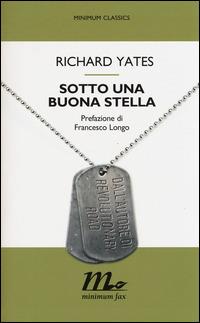
Con Sotto una buona stella (1969), Yates racconta la storia di un giovane soldato durante la Seconda guerra mondiale e del rapporto con una madre ossessivamente ambiziosa. Qui il tema del fallimento si intreccia con quello dell’identità maschile e dell’eredità familiare. La guerra non è epica, ma grigia e confusa. L’eroismo è una parola che suona fuori posto. Ancora una volta, l’autore scava nella distanza tra ciò che crediamo di essere e ciò che siamo davvero.

Il vento selvaggio che passa (1984), penultimo romanzo dell’autore, un’opera che esplora i temi della vita coniugale e delle aspirazioni artistiche. Michael Davenport è un poeta ambizioso, convinto che il talento basti a garantirgli la fama, e rifiuta qualsiasi compromesso, anche dopo aver sposato una ricchissima ereditiera. Pur avendo la sicurezza economica a portata di mano, sceglie un impiego modesto in attesa del successo letterario. Lucy, sua moglie, non comprende questa ostinazione ma si adatta, lasciandosi sedurre dall’ambiente bohémien di giovani artisti e figure brillanti. Eppure, circondata da persone che sembrano realizzate, avverte una sottile infelicità: la sensazione che tutti, tranne lei, abbiano trovato il proprio posto nel mondo.

In The Easter Parade (1976), forse il suo romanzo più struggente, seguiamo le sorelle Grimes lungo decenni di scelte sbagliate, matrimoni infelici, aspirazioni frustrate. “Nessuna delle due avrebbe avuto una vita felice”, scrive Yates nelle prime pagine. Una dichiarazione che è quasi un manifesto poetico. La felicità, nei suoi libri, non è negata per crudeltà, ma per onestà. Il mondo non è progettato per premiare i sogni, sembra dirci. È progettato per metterli alla prova fino a consumarli.

Anche nei racconti, raccolti in volumi come Undici solitudini, emerge la sua maestria. Ogni storia è un microscopio puntato sulla solitudine: insegnanti frustrati, impiegati umiliati, aspiranti scrittori che si scoprono mediocri. Non c’è compiacimento nella sconfitta. C’è precisione. Yates osserva i suoi personaggi come un anatomista che conosce la fragilità delle ossa.

Disturbo della quiete pubblica (1975) è uno dei romanzi più interiori e spietati di Richard Yates. Al centro non c’è tanto l’azione quanto la frattura psichica: il senso di fallimento che si trasforma in paranoia, l’alcol come anestesia imperfetta, l’illusione di potersi reinventare altrove. Yates indaga la fragilità maschile e la paura dell’irrilevanza, mostrando come il vero “disturbo” non sia sociale ma interiore. È il racconto di una mente che si incrina sotto il peso delle proprie aspettative.
Tra realismo e disincanto
Collocare Yates in una corrente precisa è difficile, ma necessario. È stato spesso associato al realismo americano del secondo Novecento, accostato a scrittori come John Cheever e John Updike, con cui condivide l’ambientazione suburbana e l’attenzione ai fallimenti borghesi. Eppure, rispetto a loro, Yates è più spoglio, meno incline all’ironia elegante o alla celebrazione ambigua del desiderio. Il suo realismo è quasi ascetico.
Richard Yates e John Williams condividono un destino quasi speculare: entrambi poco celebrati in vita, entrambi riscoperti decenni dopo, entrambi maestri di una prosa limpida, classica, apparentemente semplice e in realtà di precisione millimetrica.
Pensiamo a Stoner e a Revolutionary Road: in entrambi i casi il centro non è l’eccezionale, ma la vita ordinaria che si consuma. Le ambizioni si rivelano sproporzionate rispetto alle possibilità, l’amore non salva, il talento non garantisce redenzione. Nessun melodramma, nessuna enfasi, solo la lenta erosione delle aspettative. C’è però una differenza sottile. Williams tende a una forma di malinconica compostezza, quasi a una dignità silenziosa del fallimento. Yates è più tagliente, meno disposto a concedere consolazioni morali. Se Williams osserva con tristezza, Yates osserva con una lucidità più fredda, talvolta spietata.
Negli anni in cui la narrativa americana sperimentava con il postmodernismo e le architetture metaletterarie, Yates restava fedele a una forma classica, lineare, apparentemente semplice. Una semplicità ingannevole. Sotto quella superficie scorre una tensione morale potentissima.
La sua riscoperta postuma è stata lenta ma costante. Scrittori più giovani lo hanno citato come maestro nascosto. Le nuove edizioni hanno rimesso in circolo romanzi che sembravano destinati all’oblio, in Italia grazie soprattutto a minimum fax.
Per me, che ho letto tutti i suoi romanzi, tornare a Yates è come riaprire una finestra in una casa dove l’aria è rimasta ferma troppo a lungo. Non c’è polvere sentimentale sulle sue pagine, non c’è indulgenza. C’è una luce netta, quasi crudele, che illumina le crepe nei muri delle nostre ambizioni. I suoi personaggi falliscono non perché siano peggiori degli altri, ma perché sono irrimediabilmente umani: desiderano essere straordinari, e si scoprono ordinari; cercano l’amore come conferma di valore, e lo trasformano in arena di rivendicazioni.
Leggere Yates oggi, nel centenario della sua nascita, significa sottrarsi alla narrativa consolatoria che ancora domina tanta parte della cultura contemporanea. In un’epoca che esibisce felicità come un trofeo e successo come misura morale, la sua opera resta un controcanto necessario. Non celebra il crollo, non lo romanticizza. Lo osserva. E in quell’osservazione severa c’è una forma altissima di rispetto per il lettore.
Forse è proprio questo il motivo per cui il suo vero successo è arrivato dopo la morte: Yates non scriveva per sedurre il presente. Scriveva per chi, prima o poi, avrebbe avuto il coraggio di riconoscersi nelle proprie sconfitte senza travestirle da trionfi. Le sue storie non offrono salvezze facili, ma regalano qualcosa di più raro: la dignità della verità. E quando un autore riesce a fare questo, il tempo diventa il suo alleato più fedele.
Yates non offre soluzioni, non distribuisce premi. Ma regala qualcosa di più raro: la sensazione di essere compresi nella nostra parte meno presentabile. E in questo, paradossalmente, c’è una forma di salvezza.



