Ho passato la mia infanzia in grandi case, popolate e vivaci. Nella casa del grande camino ogni stanza aveva un nome, ed ogni nome una storia, ed ogni storia riprende vita ogni volta che qualcuno entra o esce da quelle stanze della memoria. Non parlerò di tutte le stanze o di ogni stanza, ma questa storia inizia in quella grande cucina, con quel grande camino, il più grande che abbia mai visto fino a che molti anni dopo non visitai castelli e palazzi nobiliari divenuti museo. Non so perché proprio quella casa in cui abitavo avesse quel camino così grande.
La teoria della carruba, pag.25
La teoria della carruba. Con brevi cenni a come non ho imparato a cucinare, di Antonietta Di Vito, La Bussola edizioni 2021, pagg.196
Un libro molto piacevole e profondo quello della scrittrice ed etno-antropologa Antonietta Di Vito, nata a Palata, 500 mt di altitudine, in Molise, una cittadina in cui era presente una comunità di Croati, qui immigrata nel XVI secolo, che è stata poi progressivamente assimilata dalla popolazione italiana, ma che ha lasciato tracce nel lessico e nelle tradizioni, e da cui anche l’autrice ha una discendenza. La teoria della carruba nasce nel periodo di isolamento durante la pandemia in cui l’autrice, come tutti, è stata costretta e che è servito a lasciare spazio a molte riflessioni e ricordi, dando così vita ad una autobiografia che non è una autobiografia – come ci dice Di Vita in esergo alludendo a Magritte – ma che si allarga a molte più generali riflessioni sull’identità personale e sociale di un individuo rispetto al contesto in cui è cresciuto e ha ricevuto sollecitazioni, influenze, e apprendimento esperienziale e teorico.
L’io narrante fa compiere al lettore un viaggio nel tempo, a partire da quei primi anni Sessanta della sua infanzia fino al presente, rievocando fatti salienti – dal rapimento di Aldo Moro fino alla pandemia – ma anche scendendo nei particolari della quotidianità locale e personale narrata attraverso i suoi riti. Quell’atto narrativo che mette insieme storia personale e storia collettiva trovando gli esatti punti di congiunzione, uno stile molto simile a quello di Annie Ernaux.
Man mano che si procede nella lettura si delinea un quadro preciso e condiviso con chi, come me, ne ha tratti nel corredo esperienziale e generazionale. I giochi naturalmente per strada: campana, nascondino, la bicicletta. I riti familiari: il tg alla tv come momento di contatto col mondo esterno, il raccogliersi intorno ai parenti del defunto quando qualcuno mancava in paese, che dava un senso di comunità, un’estate in colonia e la merenda con il pane e una tavoletta di cioccolato, in un continuo palesamento del legame tra ricordo e cibo. E poi i preparativi per il Natale, i regali ai bambini portati dalla Befana, poi, più grande, i regali a Natale per i figli dei dipendenti della FIAT di Termoli, negli anni Settanta. A Natale “Zia Richetta faceva le cancelle con il ferro, le ferratelle imparammo a chiamarle in seguito, con miele e noci all’interno“. Un Natale di regali semplici, modesti ma apprezzati perché utili e sinceri. Diversamente dalla frenesia del lusso e del consumismo attuale.
E in questo strano inverno della pandemia gli oggetti appaiono per quel che realmente sono, ancora più penosi e soli, nell’assurda pretesa che possano sostituire il tempo, la presenza, il rispetto, poveri feticci di un’utopia di un tempo che solo lo stordimento della continua rincorsa può far sembrare di vittoriosa evoluzione.
La teoria della carruba, pag.70
Leggeva tanto, già da bambina. Gli autori russi, Salgari, Camus, Pavese…. frequentava la biblioteca del paese, che allora era situata nella scuola, e divenne amica della bibliotecaria Angela, anche se lei era già un’adulta. Leggere, un’abitudine che l’ha sempre accompagnata. Insegnava ai parenti più anziani a leggere e scrivere.
Cosa contemplavamo nelle pagine di Pavese? Forse la fine di un mondo, anche se allora non lo sapevamo. Forse in Pavese ogni generazione ritrova il lutto per la fine del proprio mondo, della propria infanzia, della propria terra. Ecco perché questa sensazione luttuosa nelle pagine che ti rigettano nel mondo e nella vita come dopo un rituale funerario, perché non si può leggere Pavese ignorando la sua fine e il suo dolore.
La teoria della carruba, pag.48
Non fate troppi pettegolezzi.
Ricordi per immagini, come la foto di lei bambina al mare, pochi ponti che legano gli affetti più cari e che restano indelebili; la luce “che entrava al mattino dal balcone della stanza in cui dormivo l’ho cercata e trovata molte volte, luminosa e amichevole, promettente e carezzevole, a riempirmi gli occhi, cullandomi in quel tempo così vividamente presente di speranze, progetti.” L’estate che si annunciava con “la promessa delle ciliegie“; e torniamo così ai sapori, ai ricordi legati al gusto di un cibo in bocca, come le carrube dell’inizio e i gambi di sulla, come il profumo del mosto cotto mischiato alla neve gelata, come una granita, e quello delle mele cotogne cotte sotto la cenere. Una geografia di cibi popolari, come delle piccole bandiere su una mappa a segnare dei punti di riferimento per percorrere una strada sicura, di quelle che aiutano a non perdersi: Acquasale, Pane e olio, Pane tostato e olio, Panecotto, Pane rognoso, Pane e zucchero, Pane zucchero e burro, Pane burro e marmellata, Fave con il monaco. Tutti cibi umili, dove il pane è la bussola che ti tiene sulla giusta rotta. E zio Tonino, presente nei ricordi dell’autrice con una delle sensazioni più straordinarie della sua infanzia: il sapore e l’odore fresco del mare, racchiuso nei cannolicchi mangiati direttamente al porto, dalle mani dei pescatori, un sapore ricercato per tutta la vita. “Che il tuo cibo sia la tua unica medicina” leggiamo in una delle citazioni in esergo.
Nella cucina dell’Antonietta adulta ci si imbatte nei piatti spaiati, “monumenti ordinari e tangibili della quotidiana reciprocità“: quelli usati per portare un dolce fatto per gli amici, o quello rimasto dopo una serata tra amici in cui non si ricorda più chi fu a portarlo. Un insieme di piatti diversi tra loro, ma uguali nell’evocare un momento di felicità in compagnia, di scambio di cibi preparati con le proprie mani, adagiati in un contenitore che dura, che resta a ricordo, che non si getta come quelli di plastica o di alluminio.
In questa biografia che non è una biografia emergono le figure importanti per la propria formazione, a scuola soprattutto: maestri e professori, alcuni ricordati per dure lezioni, altri con simpatia. E poi il maturare la consapevolezza che ci sono cose che sembrano destinate a durare per sempre e che d’improvviso finiscono e si relazionano a delle immagini, come l’ultima foto di classe della terza media, prima che le strade si dividano per approdare al ginnasio, come l’inizio di un viaggio, come Ulisse, a lasciare i propri luoghi per esplorarne altri sconosciuti. Come la scrittura.
Scrittura e sé. Due atout del nostro mondo — che un tempo avremmo detto occidentale — che ci salvano oppure ci condannano. Il sé e l’identità. La ricerca di sé come se da qualche parte esista un sé più sé di altri.
La teoria della carruba, pag. 139
E la sua narrazione come cura, indagine, confessione.
In un mondo – quello attuale – in cui l’io diventa esposto, condiviso tramite la parola e tramite l’immagine, dove anche gli aspetti più intimi sono “un portfolio da esibire“, diventa quasi un must esibire il sé. Di Vita riflette su una sorta di pornografia in queste vite esposte, “vite che diventano merce” e si chiede se l’unico modo per sfuggire a questo ingranaggio non sia l’anonimato, il nascondere se stessi, proteggere il sé. Nascondersi dietro una scrittura che si fonda sul riappropriarsi del linguaggio, risalendo etimologicamente ai significati delle parole che così riescono a raccontare una storia, a dare significato. Esattamente come fa all’inizio, con la “teoria della carruba“, che racchiude in sé un legame sensoriale col passato, ma anche letterario con Verga e i suoi Vinti, a simbolo di un ceto sociale, e ancora come unità di misura, quel carato che soppesa ciò che è prezioso. La carruba è un frutto antico, quasi dimenticato, che si comprava alle feste paesane, ed è stata per tante generazioni un dolce prelibato, dal sapore simile al cacao, una specie di amuleto olfattivo che ritroviamo in autori siciliani, come appunto Verga, ma anche in Eugenio Montale e Salvatore Quasimodo.
Come l’autrice afferma nel post scriptum, “Tra le esperienze sensoriali la preparazione di piatti è forse la sola che permette di rievocare il passato (..) ricreando atmosfere e percezioni, odori di cucina, di domeniche, di ambienti avvolti dal caldo accogliente di tempi lunghi dedicati agli altri, agli affetti, ai doveri. L’unica esperienza sensoriale del passato che ci è veramente dato rivivere.”: ecco questa è l’anima del libro, il suo messaggio più forte e quello che più ogni lettore può sentire come proprio. Non il cibo feticcio sbandierato nelle trasmissioni televisive, dove la cucina è raccontata con un vocabolario bellico, ma cibo come memoria, come trasmissione di tradizioni, di appartenenze, legame con la terra, frutto di fatica e dedizione per produrlo. Quel cibo che come le madeleines di proustiana memoria ci fa compiere un viaggio nel tempo. Quello perduto della nostra infanzia e giovinezza.
Un viaggio che ho ritrovato con grande piacere, come nei libri di Iaia Caputo, e Philippe Claudel, di cui vi ho parlato.

Antonietta Di Vito, etno-antropologa, lavora nel campo della ricerca sociale e della formazione ed è prolifica autrice di saggistica; La teoria della carruba è la sua prima opera narrativa.
Tra le sue pubblicazioni, ricordiamo Dono ed economie informali. Saggi di Antropologia economica, Roma (2008), e Identità mediterranea ed Europa. Mobilità, migrazioni, relazioni interculturali, Napoli, CNR-Collana sugli studi delle Società del Mediterraneo. Ricordiamo inoltre i saggi “La smart city come nuova utopia urbana” pubblicato in Abitare insieme. Living together, Napoli, CLEAN Edizioni, AAVV
(2015) e “Musine Kokalari, Muza d’Albania” in Insula Europea.

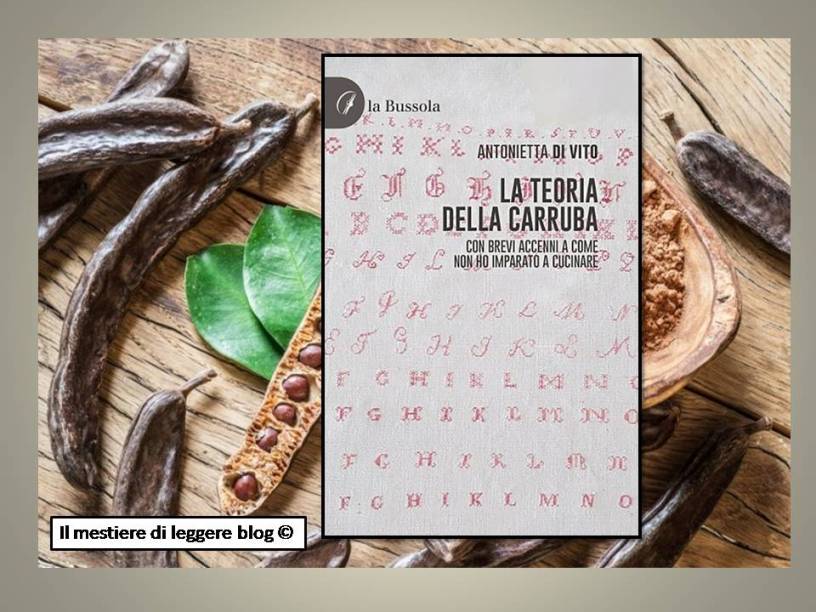

Non ho letto il libro però sento che è una bella storia. Il titolo mi ricorda l’infanzia che ho trascorso nel profondo Sud-Est d’Italia e in parte anche in Abruzzo. Avevo le tasche dei vestitini sempre piene di frutti vari e di carrube che, oltre al pane con il pomodoro, erano le merende preferite da me e dai miei fratellini e amichetti. Pane, sole, mare, carrube & fantasia. ❤ .
Complimenti e in bocca al lupo all'Autrice! ❤
"Mi piace"Piace a 1 persona
Grazie per questo bellissimo commento. In effetti è un libro che tocca corde molto personali eppure generali. Insieme a riflessioni e interrogativi che ci coinvolgono e fannoo pensare.
"Mi piace"Piace a 1 persona
Mi scriverò almeno il nome dell’autrice e il titolo per non dimenticarli. I libri da leggere sono veramente tanti, ma qualcuno ti colpisce subito per cui darò uno sguardo in libreria. Grazie ❤
"Mi piace"Piace a 1 persona
Messo in lista per il prossimo acquisto. Grazie del consiglio.
"Mi piace"Piace a 1 persona
Buone letture!
"Mi piace"Piace a 1 persona
Grazie!
"Mi piace"Piace a 1 persona
Sembra interessante!
"Mi piace"Piace a 1 persona
Lo è. Evocativo, riflessivo. Di quelli in cui ti soffermi sui periodi, rileggi, ti vengono in mente ricordi e pensieri.
"Mi piace""Mi piace"